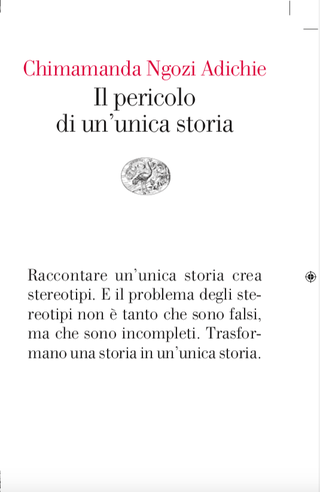«È un po’ strana: non si è voluta sposare. È un po’ strana: si è tenuta il suo cognome. È un po’ strana: non le basta essere una moglie e una madre. Una donna viene giudicata se ha figli, se non li ha, se si sposa, se non si sposa, e se ha figli viene giudicata per come li cresce, e se hai una baby-sitter non va bene, e oh: è ridicolo». La prima cosa che penso è: questo è un rap. Lo penso senza alcuno stupore, perché sono al telefono con Chimamanda Ngozi Adichie, raro caso di scrittrice nota anche a chi non frequenta i libri.
Potete aver letto il suo Dovremmo essere tutti femministi sulle magliette (di Dior) o averlo sentito nei concerti (di Beyoncé). Talentuosissima romanziera classica (leggete Americanah), Chimamanda è postmoderna nell’adattarsi a tutte le piattaforme: «Se usi vari mezzi puoi parlare di più cose che ti stanno a cuore, e la gente ti ascolta», dice quando le chiedo del suo Instagram, usato per promuovere la moda nigeriana indossata da lei stessa, unica romanziera pluripremiata che sotto le foto abbia i crediti dei vestiti.
Il pericolo di un’unica storia, che Einaudi manda in libreria in questi giorni, è una conferenza del 2009. Dice che non ne cambierebbe una parola. (E di Cara Ijeawele, la lettera sulla maternità scritta prima d’avere sua figlia? «Aggiungerei in fondo a ogni capitolo: È dura, è molto molto dura»).
È un’oratrice strepitosa, e ogni sua apparizione in video diventa virale: quella in cui dice che Donald Trump è razzista; quella in cui l’intervistatrice francese le chiede se in Nigeria esistano librerie; quella in cui a una domanda sulle donne trans risponde che un conto è essere nate donne e un conto è averlo scelto dopo essere stati comodamente cresciuti come maschi. C’entra la smania attuale di polemizzare violentemente con chiunque abbia un’opinione («È demoralizzante: la gente vuole arrabbiarsi, se non la pensi esattamente come loro sei una persona malvagia, se la tua opinione è sbagliata sei una persona sbagliata. Rimuovere dalla nostra esistenza tutto ciò che non è uguale a noi non è una buona idea»; aggiunge che per le donne gli insulti sui social sono molto peggio e, quando le chiedo una soluzione, ride: «Non lo so, chiudiamo internet?»); ma c’entra soprattutto l’impossibilità di non notare una donna con idee forti e incontrovertibilmente bella. Quando le dico che secondo Marguerite Duras le troppo belle, abituate a essere guardate e non a guardare, non possono scrivere, ridacchia e mi dice che non è abituata a considerarsi in questi termini. Finché la sgrido: ora non è che possiamo far finta non sia bellissima. «Non farò la finta modesta: non somigliare all’idea generale di bellezza mi va benissimo. Mi piace la mia faccia, mi piace la mia pelle, di nuovo: non faccio la modesta, ma non mi sento una bellezza tutto il tempo, perché nessuna si sente una bellezza tutto il tempo». Ci tiene al suo profilo pubblico, all’essere riconoscibile e ascoltata, ma «non mi rimiro, se ha senso quest’affermazione».
Flashback: novembre, Bookcity, Chimamanda è a Milano e la platea farebbe piangere gente che non sappia ridere; per metà è composta da una borghesia nera che nessun milanese incontra mai; l’impressione (Chimamanda ride quando le ricostruisco la scena) è che abbiano reclutato delle comparse per sembrarle una città assai più integrata di quanto siamo davvero. Bastasse così poco, per fregarla: alla prima occasione, dice alla platea che un’afroamericana (lei vive metà del tempo in Nigeria e metà negli Stati Uniti) se la passa meglio degli afroeuropei, che gli italiani neri sono invisibili, le loro storie non vengono raccontate, i loro libri non vengono scritti, «e stamattina ho scoperto che fino a 18 anni non avete neanche la cittadinanza». Ci ripenso pochi giorni prima della nostra conversazione, quando il New York Times pubblica un articolo sulle romanziere italiane; delle tre fotografate, una, Igiaba Scego, è somaloitaliana: se pubblichiamo la foto dell’unica scrittrice nera di cui disponga il nostro panorama letterario, stiamo forzando il campione statistico sperando che la realtà si adegui presto a questa simulazione? Chimamanda è dubbiosa: «Non credo che “intanto facciamo finta e poi succederà” sia una buona soluzione, e certo, se metti la sua foto dai l’impressione che ci siano altre come lei, ma d’altra parte escludendola non riconosceresti la sua esistenza». Quanto alle storie degli afroitaliani, dice che il problema non sono gli scrittori: «Chi decide chi verrà pubblicato? Chi c’è di guardia all’ingresso? Credo che il pubblico voglia solo leggere buone storie, tutto sommato non è importante chi le scriva».
Uno dei vantaggi del seguirla su molte piattaforme è che so di cosa non parla Chimamanda: non le piacciono le domande sui libri ai quali sta lavorando. Però qualche volta le è sfuggito che sta leggendo molto materiale sulla violenza coniugale. Giuro che non voglio sapere del suo prossimo libro, mento, ma mi chiedo se il peso che diamo all’avere un marito c’entri col poi tenerci quel marito anche se ci pesta. «Molte delle relazioni pessime in cui si ritrovano le donne sono il risultato di come veniamo allevate. Ci educano a credere che sia nostro compito far funzionare il rapporto, anche se ci fa del male: resti lì, ti sforzi, lo giustifichi, speri di cambiarlo. Per gli uomini una relazione infelice non ha lo stesso peso, perché gli uomini non vengono educati a percepirsi incompleti senza una donna, o a credere che la loro vita finisca se finisce una storia. Alle donne viene insegnato che se trovano un uomo devono tenerselo stretto, custodirlo come fosse il cofanetto dei gioielli. L’idea è che una donna valga solo in relazione ad altri: per il suo ruolo di moglie, per il suo ruolo di madre». (Naturalmente non è cascata nel trucchetto di psicologia inversa: non una parola sul prossimo libro).
«Dobbiamo liberarci dall’idea che le donne siano moralmente superiori agli uomini, e normalizzare l’idea che sono umane quanto gli uomini. Ma di quel che ha detto Barack Obama, che le donne governerebbero meglio il mondo, credo sia importante il contesto: ovvero come le donne vengono cresciute, insegnando loro a smorzare la rabbia, a cercare compromessi, a collaborare. Credo parlasse di quello». È riuscita a dire che il suo politico preferito ha torto, e a dargli ragione. Sono ammirata, e non oso chiedere perché parli tanto di remissività femminile, lei che è così evidentemente risoluta.
Deve andare, l'ho tenuta al telefono più del previsto, ma io voglio sapere di Lolita. Oggi lo pubblicherebbero, nell’epoca in cui l’editoria è terrorizzata d’ogni sensibilità ferita e polemica da social? «Non credo potrebbe mai uscire da un editore non di nicchia. A me poi Lolita neanche piace. Ma mi sembra infantile offendersi per un libro. Se un libro non mi piace, non lo leggo». Il pericolo di un’unica storia dà molta importanza ai modelli comportamentali, al rispecchiarsi nelle storie. Le dico che mi sembra un tic recente: se regaliamo bambole alle bambine quelle poi sapranno pensarsi solo massaie, ma probabilmente Margaret Thatcher giocava con le bambole. «Forse la domanda dovrebbe essere: se Margaret Thatcher avesse avuto un modello di primo ministro donna cui guardare, per lei sarebbe stato più facile? Certo che ci saranno sempre donne eccezionalmente determinate e forti e ambiziose e capaci di sfidare le convenzioni, ma che prezzo pagheranno?». Non mi sente convinta, quindi mi racconta di chi la considera «una pazza estremista perché mi sono tenuta il mio cognome anche da sposata».
Chiedo dove, mi dice in Nigeria, ma una volta anche negli Stati Uniti, «una ragazza giovane, mi ha chiesto: ma perché?, e io ho risposto: e perché no? La domanda partiva dall’assunto che fosse normale prendere il cognome di mio marito, ma perché dovrei? È il mio nome, mi piace il mio nome. Dalle donne ci si aspettano risposte a domande che non dovrebbero neppure essere fatte». E questo è il momento in cui mi rendo conto che sto continuando a farle domande, pur sapendo che è in ritardo: me ne approfitto perché è una donna?
Il pericolo di un’unica storia, di Chimamanda Ngozi Adichie, il testo che riprende il suo primo intervento al Ted del 2009, sul rischio che corriamo ogni volta che semplifichiamo vedendo la realtà da un unico punto di vista, è in libreria dal 21 gennaio (Einaudi, € 7).