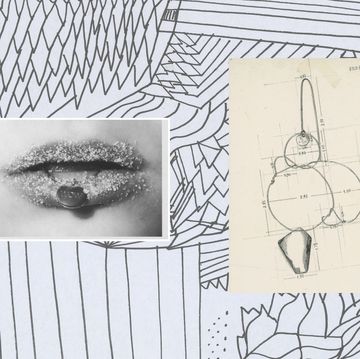Se la nuova serie di Netflix, Emily in Paris ha un pregio, è quello di aver messo d'accordo partiti opposti. La serie tv tra le più viste nel mese di ottobre della piattaforma ha fatto indispettire i francesi – impresa, va detto, tutt'altro che difficile, se si prende ad esempio l'articolo di un paio di settimane fa de Le Figaro, che decretava l'irrilevanza delle passerelle milanesi, prima ancora che le sfilate iniziassero - ha fatto infuriare anche le influencer (parigine, ça va sans dire) che dalle pagine digitali di Vulture hanno bollato come "poco credibile" la scalata al successo su Instagram della sua protagonista; non ha convinto i critici seriali francofoni – ma pure il New York Times – che sul portale aggregatore di recensioni AlloCiné hanno assegnato al prodotto una valutazione di 2,9 su 5. Ma cosa c'è che non piace nell'idea di una ventenne (Lily Collins) che arriva a Parigi da Chicago pronta a vivere il suo "parisian dream", incaricata di erudire un'azienda di marketing appena acquisita dagli States, sul corretto utilizzo dei social media?
La presenza di Darren Star, produttore di successi formato tv incomparabili come Beverly Hills 90210 e soprattutto Sex and The city, aveva fatto ben sperare le nostalgiche, orfane di uno show che ne raccontasse le disavventure sentimental-professionali. Una saudade che è divenuta insostenibile all'annuncio che, a fare da costumista e dare un armadio all'altezza della situazione, sarebbe arrivata Patricia Field, eclettica mente che ha causato, probabilmente, un'impennata nei consumi luxury a tutte le latitudini, grazie al guardaroba di Carrie Bradshaw, Samantha & Co. Il risultato però, è un'accozzaglia di stampe rumorose, che, poco si accordano con la posizione lavorativa, e il probabile stipendio, di Emily. Le camicie stampate e abbottonate solo sul colletto, per mostrare sotto una canotta, insieme a una mini pitonata e stivaletti patchwork, ricordano poco le pur ardite sperimentazioni tessili di Carrie, una poco abituata alla discrezione vestimentaria, e più una caricatura da Saturday Night Live della machiavellica Blair Waldorf, già modello aspirazionale di tutte le blogger nell'Anno Domini 2009. Non stupisce che, di fronte al berretto rosso che la protagonista sfoggia alle lezioni di lingua, Les inrockuptibles, pubblicazione di culto (anche) nel suo smaccato sciovinismo, abbia commentato che "ancora prima di vederlo, i parigini ci stanno ridendo su parecchio".
Se ha suscitato ilarità preventiva l'approccio al guardaroba, scippato al feed Instagram di Jeanne Damas, ha fatto ridere molto meno l'immagine che la serie tv ha dato dei gallici. Un'omelette imburrata abbondantemente di cliché, che è andata parecchio indigesta oltralpe: in successione, i francesi sono visti come poco probabili candidati al premio Stakanov – gli uffici, parbleu, mai aperti prima delle 10 – altrettanto poco a loro agio con l'igiene personale, tabagisti consumati, come se fossimo ancora negli Anni 90 della nicotina liberalizzata in ogni dove, sempre inclini all'arte del flirt – che pure hanno inventato – anche a discapito dell'etica lavorativa, e, come se non bastasse, pure un po' sessisti. L'agenzia di marketing è infatti colta impreparata da una ventenne invece molto "woke" che, venendo dall'America di Weinstein ed Epstein, si sente stranamente in diritto di pontificare in materia, criticando, pur con le sue buone ragioni, il progetto di una pubblicità che coinvolge del nudo e il Pont Alexandre III, "una parodia della nudità usata nei commercial 20 o 30 anni fa", come il 29enne regista Léo Bigiaoui ha commentato al NYT. "Un progetto inimmaginabile, oggi, come ieri: è orrendo". Neanche Parigi ne esce indenne: non solo la sua incuria nelle strade – e qui ci si immagina invece le metropoli americane tutte pulite come sale operatorie – ma soprattutto la sua divisione in arrondissement, brutalmente definita da Emily come "senza senso": così Haussman, intellettuale di pregio e responsabile del misfatto urbanista, incassa uno sbrigativo "Ok, boomer". Persino gli edifici (haussmaniani pure quelli) peccano in efficienza energetica: instagrammabili, sì, ma troppo antidiluviani per sostenere la potenza creativa, e i watt, di Emily e dei suoi sex toys, tanto da far saltare la corrente in un intero quartiere.
Più che dei francesi però, Emily in Paris dice molto degli americani, e della loro concezione del mondo al di fuori dei rassicuranti confini casalinghi, visto come uno sconfinato Klondike – con architetture più esotiche – da conquistare, evangelizzando le masse sulla giustezza del lifestyle made in USA. Così, Emily non si scomoda a imparare il francese, prima di andare a lavorare a Parigi, ingenuamente convinta, sulla base di un predominio culturale sempre più traballante, che i padroni di casa si adegueranno al suo uso del più internazionale inglese. Se l'idea romantica della vie en rose aveva attratto a suo tempo pure Carrie, approdata a Parigi per seguire un artistico fidanzato e iniziare un nuovo capitolo, anche Miss Bradshaw aveva sperimentato la spiacevole sensazione di sentirsi "lost in translation", in una terra molto sognata ma nella realtà poco ospitale, e simile a New York, e a tutte le altre metropoli del mondo, nella sua brutale sollecitudine, che non lascia spazio a stereotipati "bonjour" con la necessaria baguette sotto il braccio: la differenza sostanziale tra le due era che Sarah Jessica Parker sembrava davvero desiderosa di innamorarsi di una città, sostituendola nel suo cuore a New York, e non considerandola un amante di passaggio, come pure Sylvie, boss francese di Emily – una Carine Roitfeld con lo stesso taglio ma senza l'ossessione fetish per le gonne in pelle – le ribadisce: "Arrivi a Parigi, entri nel mio ufficio, non ti prendi neanche il disturbo di imparare la lingua. Tratti la città come se fosse il tuo parco divertimenti. E dopo un anno di cibo, vino, sesso, e forse un po' di cultura, tornerai da dove sei venuta".
Se si tratta, volontariamente, di un'esasperazione dei cliché, volta a suscitare la risata, il risultato è riuscito a metà: perché, nonostante tutto, Emily in Paris si divora in un pomeriggio, complici anche gli episodi da 25 minuti, consapevoli di non essere di fronte al prodotto televisivo più riuscito della stagione, ma in preda a una melancolia dolciastra, che accomuna i malati di Kaukokaipuu – la nostalgia finnica di posti in cui non si è mai stati – e chi invece per Parigi ci è passato, per una notte o per sei mesi, e sa che, alcuni di quegli stereotipi, pur veicolati in maniera approssimativa, nascondono a volte un fondo di verità. Da qui, a crearne un'epopea che trasformi delle esperienze soggettive in verità – televisive – universali, ce ne passa. Ma in fondo, va bene così: Parigi val bene una messa. E anche una serie tv non particolarmente brillante.