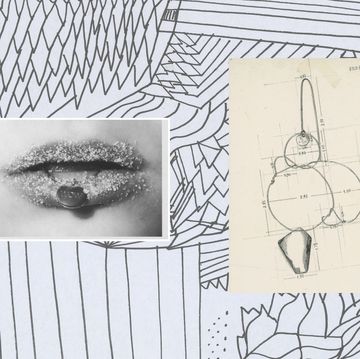Asos è il nuovo proprietario di Topshop: l'accordo di vendita (295 milioni di sterline) include i marchi Topman, Miss Selfridge e HIIT. Questo articolo è stato aggiornato il 1° febbraio 2021.
Entrare nel negozio di Oxford Circus di Topshop, a metà degli anni 10, per un adolescente, non era semplicemente acquistare un capo d'abbigliamento: era validarsi nell'universo parallelo dei moderni viaggiatori, ottenere il passaporto internazionale che liberava dalla vituperata provincialità italica, per innalzarsi al rango di adepti al credo pagano di Mercurio, attraversando il globo sulle ali degli aerei, invece che dei calzari. Non banali turisti, ma esploratori, connoisseur navigati delle faccende del mondo oltre i confini nazionali, spesso guardati con malcelata invidia dagli amici, che si sentivano, di contro, costretti a guardare la vita degli altri che scorre, bambini fuori dalle vetrine di un negozio di dolci il cui accesso gli era vietato, dalla giovane età o dalla mancanza di fondi. Un gagliardetto che pochi altri brand erano in grado di conferire, e spesso il merito era della loro assenza sul mercato italiano: il jeans di Topshop era una cartina tornasole settata sul fuso di Greenwich, una carta Millemiglia che registrava con orgoglio la strada percorsa tra l'Italia e l'Inghilterra, e te lo voleva far sapere, così come la felpa di Abercrombie & Fitch (approdato a Milano nel 2009, per chiudere nel 2019), e la tazza di Starbucks. Poco importava poi che, nella realtà, masticassimo l'inglese al livello del presunto tedesco di "noio volevan savoir" millantato da un Totò confuso dall'approdo a Milano. Topshop era il corrispettivo, in poliestere, del "globetrotter" che campeggia ancora testardamente orgoglioso, nelle bio dei nostri profili Instagram, anche se ormai abbiamo dimenticato l'ultima volta che abbiamo fatto check-in al gate.
Precursore del fast fashion, dal twist anglofono, e dalle dimensioni minori, seppur d'influenza globale (444 negozi in Gran Bretagna, 22 negli Stati Uniti, per un totale di 13 mila impiegati) Topshop nasce formalmente nel 1964, all'interno dei grandi magazzini inglesi Peter Robinson, di cui rappresenta il marchio di proprietà, venduto accanto agli emergenti anglofoni dell'epoca, Mary Quant e Stirling Cooper. Una storia pluridecorata ma mai capace di travalicare i confini nazionali, a farne le fortune è l'imprenditore Philip Green, che, nel 2002 compra non solo il brand, ma l'intero gruppo a cui fa capo, l'Arcadia Group (tra i marchi controllati Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Burton, Topshop e Topman). Il prezzo dell'operazione è di 850 milioni di sterline: la proprietà viene intestata a Tina Green, moglie del fondatore, residente a Monaco, probabilmente non per cavalleria – anche se la regina lo farà Sir per i suoi servizi all'economia del paese, nel 2006 – ma per più banali motivi fiscali: il "London calling" sarà anche affascinante, ma il "Monaco taxing" è irresistibile. Identitario, nazionalista, Topshop, pur facendo parte di quella categoria oggi parecchio esecrata, dei produttori di abbigliamento di tendenza a prezzi agevolati, si schiera da subito a favore del British Fashion Council, sostenendo i giovani e finanziando Fashion East, organizzazione no-profit che aiuta i talenti emergenti della moda in Terra d'Albione e li mette in passerella durante la London fashion week. A differenza dei giganti spagnoli di Zara, dalla presenza capillare e quindi impossibilitata a battere alcuna bandiera di appartenenza, Topshop rivendica una vicinanza di valori – laddove non è possibile gareggiare sulla qualità del prodotto finale – con gli alti ranghi del sistema modaiolo inglese, che infatti, di lì in poi, guarderà al successo del brand, se non con tenerezza, quanto meno senza alcuna animosità. E a Topshop devono i primi successi commerciali designer allora sconosciuti, e oggi invece riveriti come professionisti navigati, da Mary Katrantzou a J.W. Anderson, passando per Christopher Kane: talenti allora acerbi a cui Topshop ha accesso privilegiato, tramite i programmi di sostegno ai giovani nei quali è fortemente coinvolta, e che recluta per disegnare delle collezioni ad hoc. Laddove Amancio Ortega, il milionario spagnolo artefice del successo di Zara, rifugge riflettori e notorietà, evitando con cura le interviste – fino al 2012 ne aveva concesse solo 3 – con lo stesso terrore atavico del Dracula di fronte ad un crocifisso, Philip Green ne è amante, organizza feste e rendez-vous arricchendo la stagione degli eventi di Londra, vivace come non si vedeva dai tempi di Cecil Beaton, intrattenendosi con attori e celebrities, modelle e primi ministri, con i quali discetta di un'apertura di una scuola. Tony Blair lo vorrebbe, Green preferisce un'accademia: nasce così la London Fashion Retail Academy, il cui obiettivo è preparare le nuove generazioni per una varietà di future carriere nel fashion system, convincendo anche i competitor della bontà dell'operazione, invogliandoli a finanziarne la costruzione. E ha ragione, perché dopo 10 anni la FRA avrà generato 128 milioni di sterline di guadagni per l'economia britannica.
Guadagnato già nel 2005 il suo slot alla settimana della moda inglese – con la linea Topshop Unique, indossata dalle modelle sinonimo dello zeitgeist dei fulgidi primi Duemila, Cara Delevingne e Jordan Dunn –nel 2007 recluta però una donna che incarna lo spirito ribelle della moda inglese, realizzando insieme a lei una delle collaborazioni di maggiore successo della storia del brand, la Kate Moss che, secondo alcune t-shirt alquanto partigiane che circolano in quegli anni, rimane l'unica vera Caterina di Londra, ribadendo la supremazia sull'altra Catherine, la Middleton che in quegli anni fa il suo ingresso a Buckingham Palace. Le folle che si accalcano pazientemente fuori dal negozio di Oxford Circus, prima del lancio, sono le stesse che frequentano il festival di Glastonbury: giovanissime, entusiaste, armate di cellulari come fan sotto il palco dei Libertines, la band di indie rock capitanata dal mercuriale Pete Doherty, scandaloso fidanzato rocker della Moss, sinonimo di quell'Inghilterra che rivive, di nuovo, in loop, i fasti e gli eccessi della Swinging London, senza averne più il fisico. Mentre la relazione di Pete con le droghe è ben salda, quella tra i due sta tramontando, la Moss sta riguadagnando credito nel mondo della moda dopo lo scandalo del 2005, con il Daily Mirror che la scopre a sniffare cocaina incoronandola "Cocaine Kate": l'attenzione dei media e l'adorazione dei giovani verso un personaggio iconico anche perché controverso, è al massimo livello. Accampati dalla sera prima del lancio ufficiale, Oxford Circus risuona delle urla quando, dalle vetrine del negozio ancora chiuso, ma già pronto per l'evento, tra manichini in plastica e mini-dress in paillettes, appare lei, reale e immaginaria insieme, stereotipo della dissolutezza e ideale assoluto di bellezza, come una santa protettrice dei peccatori, in un lungo vestito rosso, appunto, come il peccato, pronta a regalare – dietro un pagamento equo, si intende – pezzi di sé: il gilet in suède con le frange e le camicie vittoriane si fanno viatico per assomigliare a lei, per andare al concerto infilandosi con una certa sicumera nel backstage, al braccio del fascinoso e crepuscolare cantante fornito di obbligatoria camicia a pois nera, oppure per festeggiare con Peaches Geldof e l'amica di sempre, Naomi Campbell, durante sontuose cene da Annabel's, il club per ricchi e famosi di Mayfair, che ha abbassato le serrande nel 2018. Kate Moss realizzerà una dozzina di collezioni per Topshop, fino al 2014, cementandone saldamente la fama, tanto che qualche anno dopo nel 2009, quando il brand approda a New York, Philip Green ha al braccio sempre lei, Kate, e Arcadia Group si affida a un private equity firm losangelino, Leonard Green & Partners, che ne acquisisce il 25% , ponendosi come obiettivo quello di replicare il successo inglese, sul suolo americano. Nell'anno di grazia 2012 il marchio è valutato 3,22 miliardi di sterline.
Messaggera del verbo sul territorio statunitense, dovrebbe essere un'altra icona globale ma che negli States gode della stessa adorazione acritica di cui la Moss è stata beneficiaria in UK: Beyoncé. La cantante si affida a Sir Green per lanciare il suo brand, Ivy Park, ma qualcosa comincia a scricchiolare, nell'universo dorato di un uomo che usa il jet privato come i comuni mortali usano la metro – la residenza a Monaco, d'altronde, lo rende necessario, per recarsi sul posto di lavoro, a Londra. Incapace di registrare l'arrivo sul mercato di giocatori agguerriti, come quelli di Zara o H&M, i guadagni cominciano a calare, nel 2018 Arcadia Group registra perdite per 114,4 milioni di sterline, i profitti segnano l'infausto simbolo del meno (-4,5%), la presenza su due continenti non è sostenuta adeguatamente dal canale di vendita online. In più, nel 2015, Green, un po' il Wolf of Oxford Circus, rivende per 1 sterlina, con la spregiudicatezza di chi si crede intoccabile, BHS, una catena di grandi magazzini fondata nel 1928: l'azienda, che già navigava in acque difficili, collassa l'anno dopo, con un deficit pensionistico di 571 milioni di sterline. Niente più strette di mano con Downing Street, dove adesso è insediato David Cameron, ma ben meno amichevoli interrogazioni parlamentari sull'operazione, che costringono Green a pagare 363 milioni di sterline, devoluti allo schema delle pensioni della defunta attività. Beyoncé, artista geniale ed eclettica, ma saggia imprenditrice, fiuta l'aria da New York, e abbandona il progetto, mentre in un'azione che appare più disperata che spregiudicata, la Leonard Green rivende il suo 25% del brand al suo proprietario, per 1 dollaro. Nel 2019 sembra arrivare la temuta bancarotta, ma i creditori si accordano, approvando un piano di ristrutturazione del debito che consente al Green – ancora Sir, ma considerato molto meno onorevole di un tempo – di licenziare, chiudere le serrande negli Stati Uniti, negoziare tagli all'affitto: tutto pur di tornare a segnare il più. Un'operazione dolorosa, ma che forse sarebbe riuscita, se il 2020 e la sua pandemia non fossero mai esistiti: secondo l'Office of National Statistics inglese, da febbraio le vendite online sono aumentate del 45%, quelle in negozio diminuite del 14%. Dati che non favoriscono di certo una visione, quella di Green, che non ha mai spinto per una modernizzazione del canale di vendita online, viziato da una decade che lo ha illuso, da celebrities che gli hanno prestato, per qualche anno, l'arma di seduzione di massa del loro star power, e che oggi, dopo altre accuse, di molestie razziali e sessuali, forse girano lo sguardo, incontrandolo tra le strade alberate di Mayfair, alzandosi il bavero della giacca, fingendo di patire il freddo dicembrino di Londra, e non un ben più banale imbarazzo. Il gruppo è dal 30 novembre in amministrazione straordinaria: a gestire questa fase è Deloitte, che ha annunciato, nel frattempo, la normale operatività, senza parlare di licenziamenti. Il re di High Street, come lo chiamavano nel 2010, è ancora cavaliere (chissà se ancora per molto) ma il suo regno, nato a Oxford Circus, ha visto giorni migliori. E, invaso dalla nebbiosa incertezza del 2020, ci si chiede se riuscirà a far tornare il sole. Anche se, a dirla tutta, non era certo il clima inglese, la motivazione per la quale frotte di adolescenti da ogni latitudine si accalcavano alle porte dei suoi negozi, ma una promessa ben più invitante: quella di sentirsi migliori, più grandi, all'altezza di un mondo che si estendeva molto al di fuori di un paesino della provincia. Una promessa che, come molte di quelle fatte durante l'adolescenza, è stata poi disattesa dallo scontro con l'età adulta, la vita reale, un mondo che è cambiato. E che al modello sul quale si fondava Topshop, ha smesso di far sconti da tempo.