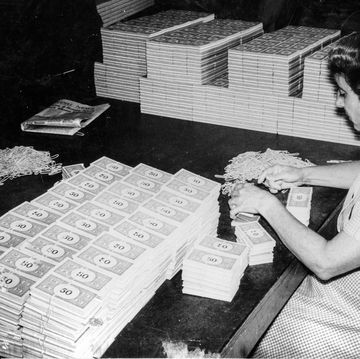«Pensa a qualcosa di estremamente triste». Click. «Pensa a qualcosa di estremamente bello». Click. In cinque minuti aveva scattato il ritratto più bello che io abbia mai avuto, senza trucco né parrucco né Photoshop. «Non servono a niente, soprattutto alle donne», mi diceva. «Quello che hai dentro è molto più importante di qualsiasi abito, o makeup o gioiello. Dalle persone io voglio tirare fuori l’archetipo, ma visto attraverso il mio sguardo, la mia visione: per questo scattare un ritratto sottende sempre qualcosa di sessuale, è un entrare dentro l’altro per poi restituirsi a vicenda». Posso dire che con la morte di Giovanni Gastel se ne va il mio primo amico milanese, quando tutti e due lavoravamo per Donna e Mondo Uomo, per cui aveva inventato dei meravigliosi Arcimboldi fatti di cinture, foulard, occhiali da sole.
A me sembrava strano che un uomo come lui – alto, bello come un nobile proustiano, aristocratico, elegante di quell’eleganza che ce-l’hai-o-no e lui ce l’aveva, con i suoi abiti stazzonati che gli stavano da dio, ereditati dal papà e dallo zio Luchino Visconti, mentre le camicie se le faceva confezionare da suo fratello Luchino: Giovanni era l’ultimo di sette figli – fosse così gentile, educato, simpatico. All’epoca era già una star della fotografia internazionale di moda (fotografava per le campagne di Dior, Krizia, Trussardi, Versace), eppure trattava chiunque con una delicatezza e un tatto che ti facevano sentire al centro della sua attenzione sia pure per due minuti di chiacchiera. L’incontro con Giovanni Gastel, per me che venivo dagli arroganti fasti romani sembrava la quintessenza della lombardità sofisticata eppur concreta, quella che mi ha fatto poi perdutamente innamorare di Milano e di quella sua ritrosa timidezza che addestra fin da piccoli a nascondere i propri demoni sotto un’amabilità e una grazia che all’inizio, sembrano impenetrabili. Quando poi siamo diventati più intimi, diceva di sé: «Sono un malinconico che ride sempre». Era vero. Credo di non aver mai riso così tanto come con lui quando declamava volgarità irriferibili che, pronunciate da lui, suonavano melodiche e armoniose come le poesie che affidava alla sua pagina Facebook e Instagram: profonde, disperate senza essere piagnone, lucidamente sconfortate. Figlio di Nane Visconti di Modrone, a sua volta figlia dell’industriale farmaceutico Carlo Erba e sorella del celebre regista, che si era voluta sposare a un bel signore della media borghesia, viveva perennemente sotto il segno (ma anche il fardello) di appartenere a una famiglia dove vigeva un’educazione militare, senza fronzoli. «Quando, negli anni Settanta, tentarono di rapirmi e io ne ero terrorizzato, mia madre disse “Se succede, vedremo cosa fare, del resto finora sei vissuto nella bambagia” e nonno Giuseppe insisteva “voi dovete vivere in modo che il mondo vi perdoni di essere nati ricchi”». Nello stesso tempo, la sua opera vibrava di cultura, conoscenza, competenze: le luci alla Mantegna. I riferimenti agli impressionisti. L’ammirazione per i grafismi giapponesi. Solo nelle sue foto Giovanni raggiungeva quel magnifico mondo di raffinata voluttà e infinito sapere e dolce sensualità in cui avrebbe voluto vivere e che ricostruiva dietro la macchina fotografica. Un mondo dove non c’erano né ricchi né poveri, ma dove regnava la bellezza: quella di una modella, di un oggetto, di un paesaggio, di un viso su cui il tempo aveva lasciato il segno. ««Mi piace l’innaturalità, quando ci si sposta verso l’estremo, in bilico tra forza e leggerezza». Quella lombardità così spiccata saltava fuori quando meno te l’aspetti: «La creatività senza un impianto rigoroso, di sostegno anche economico e buona amministrazione, è un talento sprecato». La sua ostentata seduzione, da lui troppo facilmente spiegata con l’ossessione per le donne (anche se poi tradì la moglie Anna molto meno di quanto lui stesso facesse credere, con modi guasconi ma cortesissimi) come le conversazioni dove alternava citazioni di Montale a confidenze imbarazzanti, erano modi per scardinarti i sentimenti e essere autenticamente una persona anticonvenzionale. Ricordo una cena in cui, tra un calice di vino e una sigaretta (mangiava pochissimo, come tutti i nervosi d’animo) fece un elenco sterminato di tutti i medicinali che assumeva, con un'assoluta mancanza di pudore «un sentimento che non mi è mai appartenuto». In un’intervista ha chiarito: «Io sono anche le pastiglie che prendo e in fondo discendo pur sempre da Carlo Erba. Non voglio certo invitare a impasticcarsi, ma quando stavo male non riuscivo a fare niente. C’è un dolore che può sanificare, e un altro che non crea niente di buono, quindi se la medicina è in grado di togliermi dal pozzo nero, che lo faccia subito».
Era generoso, empatico, ironico: il suo impegno attivo nel mondo della fotografia lo avvicina all'Associazione Fotografi Italiani Professionisti, di cui era presidente dal 2013. Nel 1997 la Triennale di Milano gli dedica la prima personale curata da Germano Celant, dove fotografa per la prima volta i suoi incubi nella mostra Maschere e spettri. Nel 2002 riceve l'Oscar per la fotografia. Eppure, la sua era la sfrontatezza che cela la ferita dei non amati, non importa quanti premi abbia avuto, quanto successo abbia riscosso, quanto numerosi siano stati i riconoscimenti. Abitava in lui una muta richiesta di essere presente nella vita di ognuno, di restare impresso nella memoria di chiunque, che non erano frutto di una personalità egotica, ma di un’anima “estranea al mondo e alle sue storie”. Lo ha scritto nella sua autobiografia che titolò Un eterno istante. La mia vita (Mondadori).
E in un certo senso, anche quando conobbe un periodo di relativo calo di notorietà, Giovanni Gastel è andato sempre più in fretta della vita stessa: si è autocriticato, si è reinventato, ha sperimentato linguaggi nuovi. «Ho intravisto, correndo, la vita», scrive ancora nel libro. «Il ricordo ora me la ripresenta così, scomposta in quadri, in avvenimenti e persone che appaiono e scompaiono come accade nei sogni». Più volte, tra chi gli era più vicino, ci si chiedeva come aiutarlo, come cercare di disabituarlo a certi riti così sottilmente e pervicacemente autodistruttivi da non essere neanche notati dagli altri. Dal “mondo”. Non c’era verso: tra una risata, una barzelletta sconcia e una mano sulla spalla si riducevano le possibilità di insinuarsi in quella zona d’ombra tra l’angoscia e la magnificenza, tra il tormento e l’estasi, tra il disagio e un’allegria forzata. Rimaneva elegante e nervoso, pieno di possibilità anche spaventose: una corsa nella notte. E rimaniamo qui, per colpa di uno stramaledetto virus, a domandarci se “ti voglio bene” glielo avremo detto abbastanza o no. Aveva solo 65 anni. E malgrado lottasse tanto con l’esistere, amava tanto stare qui, sulla Terra, a inventare meravigliosi universi estetici.