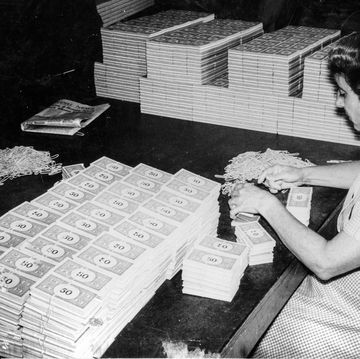All’uscita del trailer di Knock Down The House, “il documentario su Alexandria Ocasio-Cortez su Netflix” come viene sbrigativamente sintetizzato, ho pensato che di storie Davide vs Golia non se ne ha mai abbastanza. Dell’exploit di Alexandria Ocasio-Cortez e dei suoi occhi sgranati di fronte alla vittoria alle primarie democratiche per il distretto numero 14 (Bronx e Queens), di blue wave alle elezioni midterm 2018, di bellezza della diversità di genere e di etnia in politica c’è una fame molto forte, oggi come oggi. Non solo nel paese ancora più potente del mondo, ma anche altrove (e in Italia non è da meno, anche se certamente meno impattante rispetto ad altri tempi). Nel documentario che Rachel Lears ha iniziato a girare subito dopo l'elezione di Donald Trump, con i finanziamenti arrivati tramite Kickstarter e una presentazione al Sundance prima della pubblicazione su Netflix il 1 maggio 2019, la grazia inesperta ed emotiva di quattro donne, qualcuna provata da una vita di asperità, ognuna con le sue peculiarità e i suoi motivi per candidarsi, diventa il motore di un cambiamento fortemente voluto, ma che non sempre può riuscire.
Alexandria Ocasio-Cortez e le altre, vale a dire Amy Vilela, Cori Bush e Paula Jean Swearengin. Un poker di donne reclutate da Justice Democrats e Brand New Congress, organizzazioni politiche apposite che si occupano di selezionare gli outsider per le primarie di ogni partito politico. Quartetto ben dislocato negli angoli degli USA che ha guidato una piccola rivoluzione culturale in atto nell’establishment politico americano, tradizionalmente guidato da maschi bianchi etero di provato attaccamento alla poltrona. La Storia ha registrato solo la vittoria di AOC, candidata del Bronx. Ma le tre perdenti, seppure a minutaggio relativamente meno affascinanti della giovane latina, non sono realmente sconfitte. Hanno segnato una svolta, a modo loro: la volontà di lanciarsi contro l’industria del voto, evitare il puro marketing, prepararsi e studiare. Credere che la buona fede, l’impegno, la denuncia di una società che non funziona e che è schiava di una ricchezza inaccessibile possano funzionare. Crederci davvero, fino all’ultimo risultato, a quelle percentuali che possono inchiodarti nell'oblio di chi non ci è riuscito o nelle cronache della Storia.
Crederci come Amy Vilela, che ha deciso di candidarsi in Nevada dopo la morte della figlia Shalynne, uccisa da un’embolia polmonare non individuata per mancanza di documenti che attestassero l’assicurazione sanitaria. Shalynne aveva 22 anni. Dopo la scomparsa della figlia e con un’altra adolescente a carico, madre single, imprenditrice nel suo piccolo, attivista di Medicare 4 All, Amy Vilela ha deciso di candidarsi per garantire l’accesso alle cure mediche senza distinzione di conto in banca. Non ci è riuscita, ma la sua storia personale e la sua battaglia appartengono a tutti. Gli occhi rossi quando racconta della morte della figlia, la fatale ingiustizia subita, il non rispetto del diritto alla salute che è universale, sono di tutti quei milioni di americani che non possono avere accesso a cure mediche basilari. Il pianto doloroso di Amy Vilela di fronte alla sconfitta alle elezioni è la consapevolezza della fine di una probabilità. “La prima cosa che ho pensato, la prima cosa che ho detto, è stata ‘Moriranno altre persone’. E non avrò potuto salvarle. Come non ho potuto salvare Shalynne. Ho sentito quel peso” ha raccontato la Vilela a The Atlantic.
Crederci come Cori Bush di St.Louis, in Missouri. Una casa a cinque minuti di macchina da Ferguson, il paese che entrò nelle cronache mondiali nel 2014 dopo la morte dello studente Michael Brown sparato dalla polizia (lui disarmato), e una sfida agli eterni eletti dem della famiglia Clay che dal 1969 tengono stretto il posto al Congresso, prima il padre e poi il figlio, forti del riconoscimento del nome. Cori Bush si è posta come volto reale della comunità. Non ci è riuscita nemmeno lei, ma il Missouri le deve quanto meno l'onore e l'attenzione di averci provato. Perché Cori Bush ha ricordato a tutti che il sistema elettorale americano, nella sua utopistica accessibilità, non è realmente per tutti. In USA le dinastie politiche sono reali, a volte incensate, a volte indagate. Esistono, tengono principalmente a poltrone, finanziamenti e lobby, e continuare a votarle forse non cambierà le cose. Cori Bush si ripresenterà nel 2020 sempre contro i Clay, riporta RiverFrontTimes. E non è detto che stavolta non sia quella buona.
Crederci come Paula Jean Serengin del West Virginia, uno degli stati più poveri e provati degli USA, sventrato dalle miniere di carbone che lasciano dietro di sé una scia nera di disoccupazione, pressione sociale e malattie oncologiche. Le questioni ambientali sollevate dalla Serengin, unica delle quattro ad essersi candidata al Senato, diventano rapidamente lo spettro di visione di vite molto personali. Veder sparire una montagna dopo averla scalpellata in un lungo e largo, lasciare il paesaggio in preda alle scorie e veder cadere morti di tumore attorno a sé indicandone le case in una macabra conta, è un pugno in faccia. L’attenzione al climate change, al rispetto dell’ambiente nello sfruttamento, diventa la garanzia di poter fornire un bicchiere di acqua pulita a chiunque. L'attivismo cambia immediatamente di segno: da universale diventa personale. Talmente personale da toccare le singole famiglie di un’intero stato. Al senatore vincente Joe Manchin III che la chiama per chiederle, sommessamente, di restare in contatto per fare qualcosa insieme, Paula Jean Serengin risponde "Senatore, le persone continuano a morire, qui". L’impotenza ha il suono del silenzio. Come si legge nei titoli di coda, né Manchin né Lacy Clay hanno voluto farsi riprendere post elezioni.
Né tantomeno Joseph Crowley, sconfitto dall’unica vincitrice. Perché a crederci come Alexandria Ocasio-Cortez, con un team che ogni giorno ne sostiene e alimenta il carisma, con la famiglia accanto, con l'impegno costante e continuo di strategie studiate con il fidanzato Riley Roberts, ce la si fa. E crederci davvero significa anche lasciarsi andare alle emozioni. Knock Down The House è anche un documentario sulle emozioni, oltre che sulla necessità di fare politica ugualitaria. Le lacrime di chi avverte la pressione, le lacrime di chi perde, le lacrime di chi vince e sa che il lavoro vero comincia nel momento esatto in cui le percentuali superano il 50%+1. Come ha riportato Meghan Garber su The Atlantic, Knock Down The House su Netflix ribalta la concezione dell’emotività in politica, non più indice di fragilità e debolezza da usare contro le donne candidate. In passato era così (e lo è ancora, in realtà) e ne fece le sue spese più dure Hillary Clinton nel 2008: fu ripresa mentre piangeva in un bar nel New Hampshire poco prima delle primarie presidenziali. Quelle lacrime le costarono molto care, perché superato quel momento di gentilezza fu accusata di aver organizzato una messa in scena per sembrare più umana, e spazzata via. Dieci anni dopo, piangere in video ha ben altro potere. Le lacrime di queste quattro donne sono pianti di forza, di ribellione, di rivelazione: sono i pianti di chi ci crede, i pianti di persone con una vera, autentica missione sociale, i pianti di chi capisce l’impegno che ha profuso o dovrà profondere, di chi non vuole stare lì solo a scaldare una poltrona e stringere mani per garantire lo status quo. Sono le lacrime di persone cui importa così tanto da stare male per quell’idea. Che è in realtà l’anima più profonda, bella e potente della politica reale. E vale la pena innevare il divano di kleenex sognando di riprendersi in mano l'attivismo civile per ricordarselo.