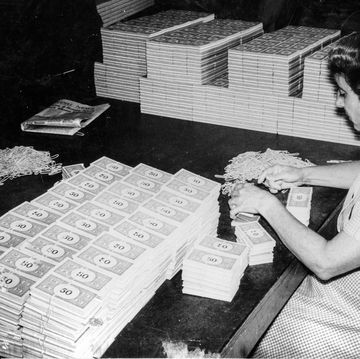Con Alberto Arbasino è scomparso l’ultimo scrittore italiano abbastanza di peso da potersi permettere di essere, all’occorrenza, leggero come una piuma. Sartoriale fuori, avanguardista dentro, Arbasino avrebbe potuto essere il figlio naturale di Porfirio Rubirosa e di Marcel Proust, anche se un test di paternità a mezzo Novecento letterario, musicale e teatrale, nel dubbio, lo avrebbe potuto chiedere di diritto.
Ha scritto saggi che sembrano romanzi (Parigi o cara, in cui raccoglie i suoi abboccamenti con Céline, Cocteau, Jean Renoir, Simenon) e romanzi che sembrano saggi (La bella di Lodi, specie di Travolti da un insolito sperimentalismo gergale e dialettale che narra, sullo sfondo della Versilia, l’amore tra una ricca possidente lodigiana e un meccanico dell’ACI); nonché poesie che sembrano poesie (Matinée) e poesie che sembrano emceeing (Rap! e Rap2). Si è occupato professionalmente di borghesia italiana per circa sessant’anni, rendendola sia il suo pubblico che il principale oggetto delle sue lodi travestite da satire, e viceversa; senza mai volerla stupire o, semmai, fingendo di farlo apposta.
Morto un Arbasino non è probabile che se ne faccia un altro. La paura è che, d’ora in avanti (ma è già così da un pezzo), esisteranno solo o accademici che si atteggiano a influencer o influencer che si atteggiano ad accademici.
Alberto Arbasino parlava come mangiava: benissimo; ma non per questo aveva paura dei fuori menu. Scarpe fine e cervello grosso, il suo vero vantaggio evolutivo fu di essere stato amico intimo di marxistoni come Nanni Balestrini o Edoardo Sanguineti, finendo per fondare con loro il Gruppo 63, salvo poi però essere anche mondano come una soubrette. Mutatis muntandis, è un po’ come se Umberto Eco non avesse dedicato un saggio a Mike Bongiorno, ma ci fosse andato a letto.
Frequentare Cortina o il Lido di Venezia non era un guilty pleasure da intellettuale arrivato, ma una serissima questione di fonti. Era di casa al Piper come in Ambasciata, anche se, possibilmente, non presso la Santa Sede. Arbasino aveva infatti l’ardire di scherzare sia coi fanti che coi Santi. Nell’incipit della Bella di Lodi dedica queste parole a Santa Francesca Cabrini: “era una tremenda, e infatti nella zona si usa ancora come modo di dire cattivo come la Cabrini”. Eppure, rileggere oggi la descrizione di quella provincia ha una particolare potere rilassante. Ti fa viaggiare con la mente in quelle fattorie e quelle cantine, accanto a quelle ragazzone che “guardano sempre dall’alto in basso tutto quello che è di Milano, perché loro si sentono più antiche e più solide”, ricche di una ricchezza plurigenerazionale e multistrato. È un po’ come fare una partita ad Animal Crossing in un’isola di felicità sui cui alberi spuntano crescenza e grana.
Anche se Arbasino non fu mai abbastanza militante per essere anche un idolo degli intellettuali in senso stretto, scriveva troppo bene per non godere comunque di una forte street credibility. Pier Paolo Pasolini, per esempio, lo aveva ritratto in uno schizzo che lo prendeva in giro per il suo essere elegantemente oggetto di consumismo, dedicandolo a: “Arbasino, in un atto di industria culturale (abbietto, naturalmente)”. Ma è chiaro che lo stava prendendo molto sul serio. Tutto ad Alberto Arbasino veniva perdonato per via della sua scrittura. Per la serie: Signorino, lei, con quei sintagmi, può dire quello che vuole. Anche se non è mancato qualcuno che, a vederlo consacrato in un doppio Meridiano Mondadori, ha storto il naso, ed era già il 2009.
La sua Italia era un’Italia spider, come quella in cui dava passaggi a Carlo Emilio Gadda (quando non gli dedicava saggi). Un’Italia in si poteva nascere assistenti alla cattedra di Roberto Ago alla Statale di Milano (diritto internazionale, chic e impegna) e poi decappottarsi ad Ariccia a mangiare Italporchette (La vita bassa, Adelphi, 2008) con la nobiltà nera. Era quanto di più rivoluzionario ci potesse essere in un prosatore piuttosto attento alle forme. Per lui un saggio, un articolo, figurarsi un romanzo, non iniziavano mai dalla copertina e finivano nella quarta, ma nelle infinite precedenti, contemporanee, successive riverberazioni delle vite sua e di quella di chi vi veniva raccontato, che fosse Moravia o il suo oste favorito. In questo era profondamente espressionista e, in particolare, cubista-espressionista (tipo Cézanne maturo), nella misura in cui i cubisti-espressionisti vedono la realtà attraverso la lente deformante costituita da tutto ciò che temono, vogliono e, soprattutto, sanno di essa. Così, per Arbasino, scrivere era trasformare ogni concetto, personaggio o luogo nella consapevolezza che la grammatica e la sintassi (specialmente quella molto ipotattica) non sono altro che una Matrix in cui evitare i proiettili sparati dalla banalità. In altre parole, possedeva un castello mentale non organizzato con le consuete stanze e porte, alla Sherlock Holmes, ma solo di un unico open space con piscina.
Tanto nel mondo ideologicamente bipartito di ieri, quanto in quello follemente polarizzato di oggi, la lettura di Alberto Arbasino è curativa come impiastri di Novecento sulle nostre ferite di italiani disfatti dalla contemporaneità. In tantissimi lo ricorderanno per il libro Fratelli d’Italia, il più sostanzioso dei suoi scritti, rimaneggiato e accresciuto per una vita, se si può dire sostanzioso di una penna che amava lasciarti sempre un po’ a metà tra l’insoddisfatto — come una sigaretta — e sovrastimolato — come un personal trailer del pensiero.
Noi proveremmo a ricordarlo con una puntata di Match, il programma che condusse sul secondo canale della Rai, per dieci puntate, dal 23 novembre 1977. Questo non tanto per come, in quel contesto, riuscisse ad essere prosa in azione (e anche nel gesticolare, perfino nei silenzi eloquenti), ma perché non faceva divulgazione culturale in tv, ma faceva cultura in televisione. Indimenticabile, in questo, la sua funzione di anti-moderatore, di fomentatore degli animi degli ospiti, nel caso si rivelassero poco inclini alla dialettica o fossero Romano Prodi. Ospiti di parte, nel pubblico, provvedevano a gettare ulteriormente benzina sul fuoco. In pratica, Match era la prefigurazione di tutto quello che sarebbe stata la televisione italiana di lì a venire, senza saperlo e con più eleganza. Guardatele tutte, ma se RaiPlay dovesse fare le bizze, uno dei must è quella con Susanna Agnelli impegnata nel suo celebrity death match contro Lidia Ravera (con Porci con le ali fresco di stampa).
Tra le cose di cui gli saremo per sempre debitori ci sono due costrutti su cui abbiamo fondato gran parte degli ultimi decenni di cultura italiana. Il primo è la casalinga di Voghera — di cui era contemporaneamente e coraggiosamente padre linguistico e nipotino genealogico, essendo egli stesso vogherese e lei, l’archetipo, sua zia. L’altro è la gita a Chiasso, il luogo apparentemente banale di cui finisci per innamorarti. In questo era veramente settentrionale e chissà come doveva sentirsi nei lunghi anni a Roma (spoiler: perfettamente a proprio agio).
Questo è stato Alberto Arbasino per la cultura italiana: un agitatore di pregiudizi, un sobillatore di concetti, un sindacalista del superficiale e uno sculacciatore del profondo; Efesto di neologismi; critico di lidi ed esegeta di trattorie, tinelli, capitani d’impresa e premi Nobel. Sempre consapevole che in ogni sua riga o telefonata non c’era e non ci sarebbe mai stato vizio o tic o vanità così grave da non essere curato con una minuziosa descrizione o un’accorata confessione. Ci ha saputo restituire, a fronte della complessità generale dell’esistenza, la semplicità del non provarci nemmeno, a fare una sintesi. In questo, più che in molti altri aspetti della sua poetica, è stato una venerata promessa,