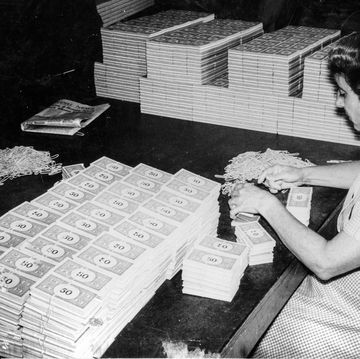Prima di poter intervistare Laurene Powell Jobs, lei voleva intervistare me. Una richiesta inusuale ma non sorprendente, perché a quasi un decennio dalla scomparsa di suo marito, Steve Jobs, il co-fondatore di Apple, Laurene rimane una persona riservata. Quando c’era Steve, stava alla larga dalla vita pubblica. Aveva un’azienda di cibo naturale, era impegnata a cambiare le leggi sull’immigrazione e sull’istruzione e si prendeva cura della sua famiglia. E anche se negli ultimi anni è sempre più coinvolta in progetti di business e filantropia, continua a mantenere un basso profilo: pochissime interviste e zero riflettori. Per parlare con qualcuno, vuole capire chi avrà davanti.
Quindi in una fredda mattinata dello scorso anno, ci siamo seduti sui divani del Greenwich Hotel di New York, in una sala dalle luci soffuse illuminata da un camino. Mentre beveva una centrifuga di verdure, abbiamo parlato di cambiamento climatico, di buddismo e di altro. Una conversazione off the record. Due mesi dopo ci siamo ritrovati sullo stesso divano, ma questa volta il mio registratore era acceso.
Mi è stato subito chiaro perché Laurene Powell Jobs sia cauta nell’apparire in pubblico. In un’era di tweet veloci, ti parla con calma intrecciando racconti personali, politica e il suo punto di vista sui cambiamenti sociali. Cita Dante, Ralph Waldo Emerson e persino Ross Perot (il miliardario indipendente che si è candidato nel 1992 e nel 1996 alla presidenza degli Stati Uniti, ndr). Senza pretendere di avere soluzioni facili a problemi complessi. E crede anche che una delle citazioni più popolari di suo marito - “Siamo qui a lasciare un segno nell’universo” - sia stata fraintesa.
Si sono incontrati nel 1989, quando Steve Jobs ha tenuto una conferenza alla Stanford Graduate School of Business dove lei studiava dopo un periodo alla Goldman Sachs. Si sono sposati due anni dopo nel parco nazionale di Yosemite concludendo la cerimonia con un’escursione a piedi nella neve. In quel periodo, dopo aver dato le dimissioni da Apple anni prima, Steve era a capo di NeXT. Nei due decenni successivi, tornato alla Apple, lancia gli iMac, iPod, iPhone e iPad. E nel frattempo sua moglie fonda College Track per aiutare i giovani disagiati ad accedere al college, ed Emerson Collective, un’organizzazione che raccoglie tutti i suoi business e le attività filantropiche. Dopo la morte di Steve Jobs nel 2011, ha passato anni lontano dai riflettori. Ma recentemente, Laurene Powell Jobs - la 35esima persona più ricca al mondo, con circa 27,5 miliardi di dollari - ha iniziato a esercitare la sua influenza.
Ha acquisito Pop-Up Magazine, molte azioni della rivista The Atlantic e di Monumental Sports, che è proprietario delle squadre di basket dei Washington Wizards e Mystics oltre alla squadra di hockey Washington Capitals. Collabora con l’ex segretario dell’istruzione Arne Duncan per ridurre la violenza legata all’uso delle armi a Chicago. E quest’anno al festival del cinema indipendente di Sundance i documentari del nuovo Concord Studio, che lei sostiene finanziariamente, hanno avuto successo. Insomma, ha interessi molto diversi, a conferma di quanto povertà, istruzione, salute e ambiente siano interconnessi.«Quando tiri un filo, sfili tutto il tappeto», dice, «se lavori nel sociale non fai progressi a lungo termine se sei focalizzato solo su una cosa».
A 56 anni, Laurene Powell Jobs sta agendo con un senso di urgenza. Crede che le politiche del presidente Trump abbiano scatenato delle forze oscure che stanno facendo a pezzi il tessuto della società: «C’è stato un crollo nella capacità degli americani di dialogare e ascoltare gli altri. Tutto è peggiorato negli ultimi tre anni, siamo stati legittimati a sentire i nostri vicini come “altro da noi”». E questo l’ha portata a buttarsi in una delle battaglie politiche del giorno. Da sempre sostiene i diritti di quelli arrivati negli Stati Uniti da bambini - i cosiddetti Dreamers - seguendo la promessa del sogno americano, e ha anche acquistato pubblicità televisive per contrastare la decisione di Trump di sospendere il programma che li proteggeva dalla deportazione. Dice che lo scorso anno gli attacchi di Trump ai media sembravano usciti dal manuale di un dittatore, e ne ha scritto su The Atlantic.
Dopodiché si rende anche conto dell’immensità del suo privilegio. È una miliardaria della Silicon Valley che ribatte al ricchissimo occupante della Casa Bianca. «Non è giusto che alcuni individui possano accumulare ricchezze pari alla somma di quelle di milioni e milioni di persone» dice. Ma non si scusa: «Ho ereditato tutto da mio marito, che non era interessato ad accumulare ricchezza. E in onore del suo lavoro ho dedicato la mia vita a ridistribuire in modo efficace, per aiutare individui e comunità in modo sostenibile. Non intendo creare lasciti per la mia famiglia, e i miei figli lo sanno», aggiunge. «E se io vivrò a lungo, tutto finirà con me».
Laurene Powell Jobs (nata nel 1963 a West Milford, New Jersey) con il marito Steve Jobs co-fondatore di Apple, scomparso nel 2011. I due si sono conosciuti nel 1989, sposati due anni dopo e hanno tre figli, Reed, Erin ed Eve. Laurene vive a Palo Alto, California.
Com’è stata la sua infanzia? Sono cresciuta nel Nordovest del New Jersey. Dietro casa mia c’era un lago ghiacciato in inverno e ci pattinavamo. E poi si poteva nuotare e andare in barca. Ho imparato le regole basiche della vela. Mia madre credeva che i bambini dovessero stare all’aria aperta. Se cercavo di infilarmi in casa per leggere un libro me lo requisiva e mi costringeva a uscire.
Altrimenti come trascorreva il suo tempo? In prima la mia maestra mi ha portato in biblioteca e quella è stata la chiave d’accesso alle meraviglie: grazie ai libri mi sono avventurata ovunque e ho anche immaginato cosa avrei potuto fare. Le mie superiori non sono state eccezionali, però c’era una biblioteca, il posto che mi rende più felice. E poi sono finita in un buon college.
Suo padre era un pilota militare ed è morto in una collisione aerea. Che impatto ha avuto sulla sua famiglia perderlo così presto? È morto il giorno prima del suo trentunesimo compleanno, io ne avevo tre. Mia madre poi si è risposata e sono cresciuta in questa nuova famiglia. Il mio patrigno era consulente per l’orientamento scolastico alle superiori, mia madre è stata a lungo un’insegnante supplente. Se perdi un genitore così tragicamente il tuo mondo cambia. I miei fratelli e io siamo cresciuti con la consapevolezza dell’impermanenza di questa vita. E anche se è difficile da accettare, è stata una grande lezione.
Qual è stato il suo primo lavoro? Se volevamo soldi per qualsiasi cosa, dovevamo guadagnarceli. I miei fratelli distribuivano i giornali e io ho ereditato una delle loro strade del quartiere. Quando nevicava spalavo davanti a casa. Ho fatto la baby-sitter, la bagnina, l’istruttrice di nuoto. A 16 anni la cameriera. E poi al college ho cercato ogni possibile fonte di sostentamento: prestiti, borse di studio, e ho continuato a fare la cameriera.
Quando ha iniziato a interessarsi ai temi sociali? Quando mi sono trasferita in California da New York vivevo a Palo Alto, che è attaccata a East Palo Alto, dove c’era una comunità più povera, con stipendi bassi, e una qualità dell’aria che è la peggiore dei dintorni. Lì la terra è avvelenata, molte delle fabbriche della Silicon Valley l’hanno usata come discarica per anni. C’è arsenico nella falda acquifera. Io ero sconvolta che ci fossero comunità così a distanza di due miglia dalla mia casa. Era un deficit strutturale, e i deficit strutturali devono essere ristrutturati. Ross Perot diceva qualcosa tipo: «Non dimenticare che ora c’è un bambino nelle strade di Calcutta che sta morendo e che è molto più intelligente di te».
Steve come ha influenzato il suo pensiero su questi temi? Potrei parlarne per ore. L’ho incontrato quando avevo 25 anni. E siamo stati insieme per 22. Quindi ha influenzato tutto. Avevamo un’intesa ricca, molto molto bella. Parlavamo tantissimo, per ore, ogni giorno. Un insegnamento profondo di Steve è che non dobbiamo accettare il mondo in cui siamo come qualcosa di fisso e impermeabile. Perché quando lo ingrandisci, è fatto di atomi, che come noi si muovono in continuazione e che attraverso l’energia, la forza di volontà e le loro intenzioni possono cambiarlo, questo mondo. La gente ama citare Steve dicendo: «Voglio lasciare un segno nell’universo», ma così suona sprezzante. Lui intendeva che “ognuno di noi è in grado di cambiare le cose”. Mi ci è voluto un po’ per capire che fosse realmente possibile agire. Ma ora con Emerson Collective credo che sia davvero possibile.
Sono quasi vent’anni che lavora per cambiare la legge sui Dreamers, ma non è successo molto. Io e gli studenti abbiamo raccolto le firme e fatto una petizione nel 2002. L’abbiamo portata a Washington e Jon Corzine nel Senato e Anna Eshoo nella House l’hanno usata per la Dream Act Legislation che stava nascendo. Ho pensato che sarebbe passata e che non sarebbe stato più un problema per questi studenti promettenti e ricchi di talento e invece 18 anni dopo siamo ancora qui. Come Paese abbiamo fallito, non siamo riusciti a fare di loro dei cittadini o residenti attivi. E questa cosa mi fa impazzire. Ma non mollerò finché vivo.
A volte sembra che gli americani con punti di vista politici diversi non riescano a parlarsi. Come possiamo risolvere questo problema? Un passo alla volta, e a all’interno delle nostre famiglie. Nella mia ci sono dei sostenitori di Trump. Sapevo che avrei passato del tempo con loro a Natale e volevo parlarci, cercare di trovare un terreno comune.
E com’è andata? Abbiamo trovato molti punti di accordo. Sui valori americani di libertà, dignità e giustizia, per esempio. Abbiamo parlato del diritto di emigrare nel nostro Paese come molti nostri parenti hanno fatto tempo fa.
Fino a che punto il crescente risentimento contro i grandi milionari e filantropi influisce sul suo lavoro? Ci penso molto. Non è giusto che pochi individui possano ammassare fortune di questo tipo. L’abbiamo visto all’inizio del secolo scorso con i Rockefeller, i Carnegie, i Mellon e i Ford. È un accumulo di ricchezza pericoloso per una società. E non dovrebbe succedere, non così.
©2020 The New York Times Company