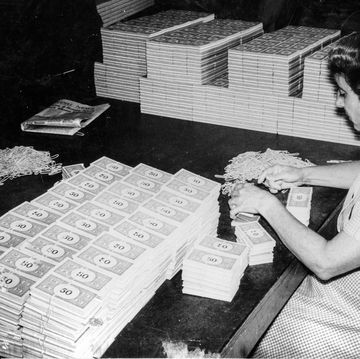Marsha P. Johnson ha vissuto una vita sola, e anche molto breve, ma definirla in poche righe sarebbe impossibile anche per il più talentuoso minimalista dell'arte della scrittura. Perché in uno Stonewall post Covid-19, a ingresso contingentato, tutte le definizioni e le iterazioni possibili su di lei, creerebbero subito assembramento. "La Rosa Parks del movimento LGBTQ+"; "Solo un altro omosessuale morto" , secondo la polizia di New York, che nel 1992 derubricò così la sua fine, senza darsi troppa pena di indagare su quel corpo ritrovato nell'Hudson River; una rivoluzionaria vestita con le corone di fiori in testa, eppure per niente pacifista, come quegli addobbi a basso costo dei quali si contornava, potevano dare a immaginare; la reietta tra i reietti, ripudiata da quel suo originale maschile (Malcolm Michaels) e dalla parte "presentabile" della comunità gay, che nel 1973 non la volle al Pride – che pure lei stessa aveva battezzato con i moti di Stonewall – per via di una malattia mentale che la rendeva "fragile", poco utile alla causa; "la madre di tutte le drag", come ha qualche anno fa affermato RuPaul, nume tutelare contemporaneo delle drag queen attraverso un talent seguitissimo Oltreoceano, RuPaul's Drag Race, ed eminenza grigia e rispettabilissima, quota Q(ueer) di ogni evento social statunitense che voglia attestarsi una patente di inclusività. Marsha P. Johnson è stato tutto questo, tutto insieme.
Se oggi parliamo ancora di Marsha P. Johnson, lo si deve soprattutto alla memoria storica LGBTQ+friendly di Netflix, che nel 2017 ha reso disponibile sulla sua piattaforma The life and death of Marsha P. Johnson, documentario su vita e opere della drag queen arrivata dal New Jersey al Greenwich Village nel 1963 con i suoi vestiti in una busta, e 15 dollari in tasca. Molto meno apprezzabile, invece il film del 2015 Stonewall di Roland Emmerich, che della Johnson fa una citazione veloce, come se si trattasse di un personaggio secondario e abbastanza ininfluente, affidando il ruolo di iniziatori delle rivolte – oggi festeggiate annualmente con il Pride – nella migliore tradizione patriarcale ad un gruppo di gay sì, ma ovviamente bianchi. Un'operazione di whitewashing, come la chiamerebbero gli americani, oggi molto condannata ma solo cinque anni fa passata in sotto traccia.
Perché se le leggende a volte sono generate da fantasie molto fervide, e non supportate dalla realtà dei fatti, nascondere sotto il tappeto una personalità effervescente, ma disturbante e non catalogabile come quella di Marsha, è stato impossibile anche per i più cocciuti negazionisti. Non è vero, ad esempio, che Marsha era presente quando scoppiò nello Stonewall Inn – refugium peccatorum di omosessuali e trans e di tutta quella comédie humaine rifiutata altrove – la lite con la polizia, come fu la stessa Marsha ad ammettere in un'intervista ad Out, sostenendo di essere arrivata solo a tarda sera, quando lo scontro si era ormai fatto infuocato. E però è vero, verissimo, che nei giorni successivi, quando quegli scontri diventarono vere e proprie proteste contro una polizia sempre troppo pronta a manganellare e schedare chi si macchiava dell'onta del travestitismo, Marsha si arrampicò su un lampione e da lì, lanciò su una macchina della polizia parcheggiata, la sua borsa carica di tutta quella rabbia per i suoi diritti negati, i verbali dei suoi molteplici arresti per prostituzione, e un paio di mattoni, che, sebbene non più o meno pesanti di una vita fatta di negazione e soprusi, furono quelli che, materialmente, sfondarono il parabrezza della vettura.
Johnson, come il ristorante Howard Johnson sulla 42esima strada, P. come Pay it no mind, "Non pensarci", che poi era quello che Marsha rispondeva sorridendo a chiunque le chiedesse in quale genere si identificasse. Una volta, dopo uno dei suoi tanti arresti – esibiti tutti con uguale orgoglio, e arrivati, secondo la diretta interessata, a superare la Quota 100 – lo disse anche ad un giudice che probabilmente condivideva lo stesso humor, e che, divertito, la rimise presto in libertà. Figlio di un operaio alla catena di montaggio della General Motors e di una governante, sei fratelli, Malcolm comincia a trasformarsi in Marsha già a 5 anni, quando inizia a essere irresistibilmente attratto dagli abiti di sua madre, in un perfetto incipit da Bildungsroman queer, e con una finale poi però inequivocabilmente pasoliniano. Dopo il diploma ripara a New York, scappando dai soliti bulli dalle mani lunghe e da una famiglia non preparata a quel figlio incapace geneticamente di sentirsi in colpa, nell'ostentare il suo essere altro: gay, trans, non ha mai voluto definirlo neanche lui, figurarsi se lasciava il compito ad altri. "Ero un nessuno, venivo dal nulla, fin quando poi non sono diventata una drag queen", sono le uniche parole che Marsha usava, per definirsi, anche se, pure sul concetto di drag queen, ostentava una certa riottosa vena socialista, ironizzando su una certa glamourizzazione patinata e bisognosa di denari, per entrare con serietà nel personaggio – comprensivi di rossetti, belletti e abiti sgargianti – che, con le sue entrate, non poteva permettersi. Si esibisce in diversi spettacoli con numerosi collettivi artistici, l'occhio newyorchese attento di Warhol la incrocia e la scatta nella serie di Polaroid Ladies and Gentlemen.
La fama regalatale all'interno della comunità newyorchese dopo Stonewall, è brevissima. Non i 15 minuti canonici warholiani, ma qualche anno. Nel 1973, al terzo Pride, la faccia presentabile del movimento – composta principalmente dagli stessi gay bianchi celebrati come propugnatori della rivoluzione arcobaleno del 1969 dalla pellicola di Roland Emmerich – le rinnega senza molte cerimonie la maternità di quella manifestazione. Marsha è malata, probabilmente schizofrenia, a volte viene ricoverata in ospedale e la sua voce si trasforma, torna a essere quel Michael bambino vittima di abusi, e però nel corpo di un adulto dalla silhouette alta e snella, guizzante e irascibile. Marsha è inaffidabile, Marsha rifiuta di adeguarsi allo stereotipo dell'omosessuale disegnato da canoni etero-normativi, e inoculato anche dalla comunità gay, che vede nell'adesione a quell'immaginario una strada più veloce nel riconoscimento dei propri diritti. Optando per il rito abbreviato, la comunità decide che Marsha P. Johnson è un'eredità iconografica in fondo abbastanza scomoda, della quale disfarsi nel pubblico delle marce celebrative. Marsha ne soffre di certo – non tanto quanto Sylvia Rivera, altra deus ex machina di Stonewall ripudiata per motivi similari, e che continuerà a tuonare improperi e maledizioni da qualunque palco riesca a guadagnare – ma è donna del fare, e in fondo "fin quando non ci saranno uguali diritti per tutti, non c'è motivo per cui celebrare". Proprio con Rivera fonda STAR, Sweet Transvestite Action Revolutionaries, organizzazione che protegge e sostiene i giovani ripudiati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale, e apre poi la Star House, rifugio il cui canone d'affitto è regolarmente pagato attraverso l'unica attività remunerativa che è concessa a chi, come Marsha e Sylvia è di colore e nata nel corpo sbagliato: quella della prostituzione. Immarcescibile rivoluzionaria, idealista assoluta e però anche molto pratica, variante queer dalla East Coast – e molto meno politically correct – di quell'Harvey Milk che era già assurto a santino del movimento gay quando era in vita – e poi da Oscar anche dopo la morte, con pellicola hollywoodiana dove si scomoda uno Sean Penn in stato di grazia – Marsha non ha beneficiato delle stesse corone di alloro neanche nel giorno della morte.
Nel 1992, il suo corpo viene ritrovato senza vita nel fiume Hudson, la polizia un po' indolente lo cataloga come suicidio, facendo leva sul peggioramento progressivo della sua malattia mentale. In un acme di svogliatezza, la testimonianza di diverse persone che affermano di aver visto, la sera prima, Marsha molestata da un gruppo di teppisti, o anche quella di un uomo che vide Marsha lottare animatamente con qualcuno che le rivolse un insulto omofobo, per poi presentarsi in un bar del quartiere qualche ora dopo, vantandosi di aver ucciso una "drag queen chiamata Marsha", finì sepolta dalle scartoffie e macchiata dalla crema di qualche ciambella, nella centrale di polizia. In fondo, nessuno aveva tempo di occuparsi dell'"omicidio di un omosessuale": Marsha continuava, con una certa ammirevole testardaggine, a essere scomoda, anche dopo la morte. Oggi è il doodle di Google che celebra il Pride; mea culpa e tabù inconfessabile della comunità di cui ha fatto rumorosamente parte per tutta la vita, e che l'ha sempre vista come troppo scomoda, perché anche l'essere diversi ha una sua etichetta di rispettabilità alla quale attenersi con fervore ortodosso; una morte avvenuta per cause sconosciute – modifica effettuata nel 2012 quando furono inutilmente riaperte le indagini, senza trovare le prove necessarie a dargli la rispettabilità di un trafiletto in cronaca nera. Domani diventerà forse un monumento a Greenwich (se ne parlava già nel 2019, l'opera dovrebbe essere completata nel 2021, e la vedrà insieme alla sua amica di sempre Sylvia Rivera, morta di cancro nel 2002 a 50 anni). Marsha P. Johnson continua a trent'anni dalla sua morte, a fare rumore, sfasciando parabrezza e stereotipie in un mondo migliore (ma chissà poi se è vero) e che però di una come lei, ha ancora disperatamente bisogno.