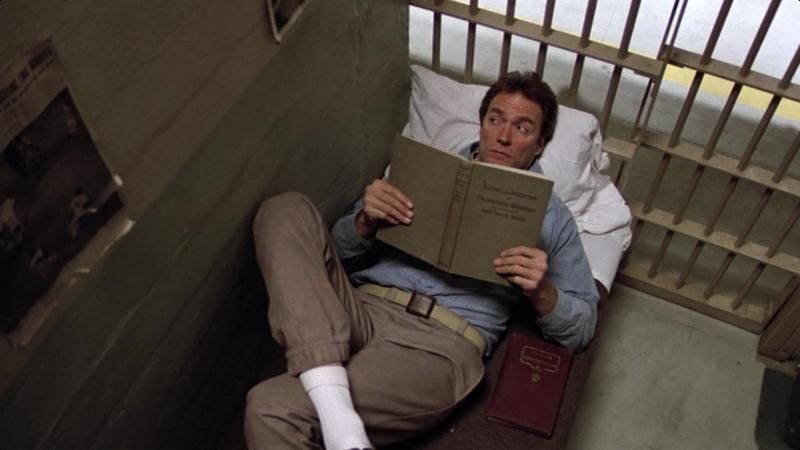La sera in cui tornai a Ferrara da New York capii che dovevo trovare una qualsiasi scusa per scappare lontano. I miei erano in vacanza. Avevo la febbre e il mal di gola. Chiesi a Emma di venire da me. Lei si fermò in una rosticceria per prendere faraona ripiena e patate. Mangiammo a letto, guardando i cartoni animati. Come avrei potuto giustificarmi se lei avesse conosciuto soltanto una minima parte della mia vita fuori da quella camera? Dovevo lasciarla, ma mi mancava il coraggio. Rimandare il problema mi sembrava la soluzione meno dolorosa. Non pensarci, tenermi impegnato. Addirittura lavorare.
Ma i miei vaghi progetti di carriera accademica ricevettero un duro colpo quando il professor Procioni – che all’attività teoretica aveva sempre unito un altrettanto intensa attività fisica – decise di fare un giro in mountain bike sui colli Berici. Un vecchio non rispettò uno stop, lo investì e, dopo pochi giorni, del cervello che aveva imitato alla perfezione lo stile di Schopenhauer ridicolizzando baroni e tromboni, fu decretata la cessata attività elettrica. Probabilmente non mi avrebbe mai aiutato nel concorso per il dottorato e per tutto il resto, ma da allora presi a dire che sì, quella era stata una gran sfortuna, oltre a una tragedia umana, per carità, perché il docente che mi avrebbe appoggiato era dipartito prematuramente e, si sa com’è l’Italia, ora avrei dovuto rivoluzionare completamente i miei programmi per il futuro. Mi sentivo liberato. Già, ma quindi che fare?
Cominciai ad ammorbare Bill Doust di chiamate e messaggi perché mi assumesse nell’azienda di moda di cui era direttore commerciale. Quella era il mio destino, evidentemente, raccontavo. Lui rimandava.
Così in estate andai a lavorare come commesso nel negozio del mio amico Paolo Haas, in Sloan street a Londra, “per migliorare il mio inglese”, raccontavo a Emma e a tutti quanti.
Gillie, che del negozio era la manager – la titolistica anglosassone rende prestigioso alle orecchie latine ogni mestiere – aveva sessantasei anni, i capelli corti biondo platino, ma le orecchie erano congiunte alla mascella da una linea di peluria nerastra – suo padre era di Teheran. Diceva di essere un’appassionata di lirica e di Samuel Beckett, di cui possedeva un busto nel suo atrio d’ingresso a Mayfair. Di detestare il balletto russo e il modernismo architettonico. Ma soprattutto non sopportava che un cliente se ne uscisse senza impugnare un’elegante busta – nera con la scritta rossa – “Reiner Haas”. Quando questo accadeva, lo seguiva fino alla soglia tenendo per il tallone lo scarponcino rifiutato, agitandolo in aria – brandendolo, in una parola. Digrignava la mascella, borbottava, prima, “è sicuro?”, “guardi che perfetta cucitura norvegese”, poi, vedendo che non sortiva effetti, “che dannato idiota”, “miserabile”, “pezzente” e si affacciava seguendo con lo sguardo il sopravvissuto finché, notando a poche decine di metri più su verso Sloan Square il negozio di Giusy Zanotti – sempre scarpe di lusso, ma che vendevano molto di più – concludeva, “andrà da quell’altro dannato stupido di Zanotti – si voltava verso di me – Piaceranno mica anche a te, quelle vecchie ciabatte?”
Dovevo arrivare in negozio alle nove e quaranta, riporre tutte le calzature delle mensole sul pavimento, lucidare le superfici espositive con una spugnetta inumidita in un secchio, infine risistemare le scarpe nelle loro collocazioni originarie. Su ogni mensola sandali e stivali potevano essere anche cinque o sei e io dovevo ricorrere a tutta la mia memoria visiva perché, se solo le punte finivano per essere appena più convergenti rispetto alla posizione primigenia, se solo le suole distavano un centimetro in più dal bordo del pianale, ciò scatenava l’ira implacabile di Gillie. “Sono scarpe, non patate! – digrignava – Hanno un senso.”
Una mattina, appena alzato, scrissi l’unico pensiero di tutta l’esperienza: “Un commerciante è onesto quando riesce a fornire al cliente valide scuse per giustificare a se stesso l’acquisto.” Quindi, appagato, lucidai la mensola riservata agli stivaletti di struzzo con un insolito impegno, intanto che, come sempre, lo stereo sciorinava il meglio del Rat Pack. “Oggi c’è da spedire venti paia alla principessa del Brunei”, disse Gillie richiudendo l’ombrello – lei arrivava alle dieci, a negozio già quasi assettato. Hiroko, la “manager assistent”, una giapponese computerizzata e efficientissima, stava già scendendo nel magazzino per eseguire il compito. “No”, la bloccò il capo, “oggi deve venire lord Maddigan con moglie e figlie, voglio che tu faccia gli onori di casa. – aveva già raggiunto Hiroko sul primo scalino, mi guardò – Gastone impacchetterà”, mi fece cenno di seguirla là sotto – Hiroko si scansò assumendo una posa da hostess.
Il magazzino è una stanza profonda e stretta, con le scatole accatastate lungo le pareti fino al soffitto – gli spazi, in Sloan Street, costano. Gillie, parlottando da sola, dispone sul tavolo centrale scarpe, scatola di cartone, scotch, scotch da pacchi, forbici, graffettatrice, taglierino, un pennarello indelebile rosso, uno verde – tutte le volte che prendeva un oggetto dai cassetti sentivo la temperatura corporea alzarsi di un grado centigrado, corrispondente a uno virgola otto gradi Fahranheit (mi stavo emancipando dalla provincialità), perché le eventualità combinatorie sarebbero cresciute. “C’è un solo modo di imballare bene. – brandisce le forbici – E te lo mostrerò solo una volta.” Al secondo giro di scotch da pacchi, coadiuvato in alcuni punti che a me parevano del tutto arbitrari dall’applicazione parsimoniosa dello scotch normale, fui già ben consapevole che, con la manualità che mi impedisce tutt’ora di eseguire una firma che non possa essere scambiata per quella sotto un disegno dal titolo “il mio amichetto del cuore”, non avrei cavato un ragno da un buco. Continuavo a ripetere “ok”.
“Ora tocca a te”, Gillie alza la testa solo a lavoro terminato. A me era sembrato un tempo lunghissimo e l’opera – con lo scotch distribuito in maniera talmente uniforme da non avere angoli rialzati, deviazioni, sfumature e che quindi aveva reso la scatola una grande gelatina alla liquirizia dalla superficie riflettente – mi parve perfetta e inarrivabile come le camicie piegate per la valigia da mia madre. Per chi è affetto dalla mia inettitudine rifare il letto diventa un atto di fede perché si sa, in coscienza, nonostante ci si ripeta “su, basta applicarsi e non aver fretta”, che il risultato finale darà sempre l’impressione di qualcosa di raffazzonato e dilettantesco – l’ottenimento di superfici lisce rimane misterioso quanto le costruzioni megalitiche prima della scoperta della legge della leva.
“Perfetto!” dico a Gillie e mi piego sul tavolo. Lo scotch con me si ribella, non aderisce uniformemente, i suoi bordi si ritorcono su loro stessi, sembra aver perso parte del proprio potere incollante. Ma appena gli avvicino le forbici per tagliarlo si imbizzarrisce – è dotato di un primordiale istinto di sopravvivenza – e si attacca al metallo con la forza della disperazione, e più cerco di far ruotare la lama per liberarla, più il nastro le si avvolge attorno (intanto continuo a ripetere “dunque, vediamo, era così, giusto? sì, e poi così, giusto?, e quindi così, no?”). E quello che ne viene fuori, quando finalmente mutilo il bastardo, è un avvolto di gibbosità che invalidano totalmente l’obiettivo iniziale, cioè isolare ermeticamente le scarpe destinate alla principessa del Brunei dall’atmosfera terrestre – non ho avuto il tempo, né la lucidità, per chiedermi “ma perché cazzo?”.
Guardo Gillie di sottecchi, ho la fronte sudata e provo quello che provavo durante le interrogazioni di trigonometria. Gillie ride – ha i denti ingialliti dal tabacco. Ride e dice “lascia stare, faccio io”. Non vi nascondo che sul momento la cosa mi abbia provocato un gran piacere, nonostante le chiedessi, ipocritamente, “Sicura? Guarda che riprovo io, forse dovevo tenere il taglierino più obliquo, non credi?”
Tuttavia, col passare delle ore e dei giorni, mi resi sempre più conto che Gillie mi aveva graziato solo perché mi riteneva – me, il poliedrico genio letterariofilosoficolinguistico – un completo imbecille, talmente irrecuperabile che non valeva neppure la pena insultarlo. Ma la definitiva resa dei conti con me stesso stava giusto per arrivare.