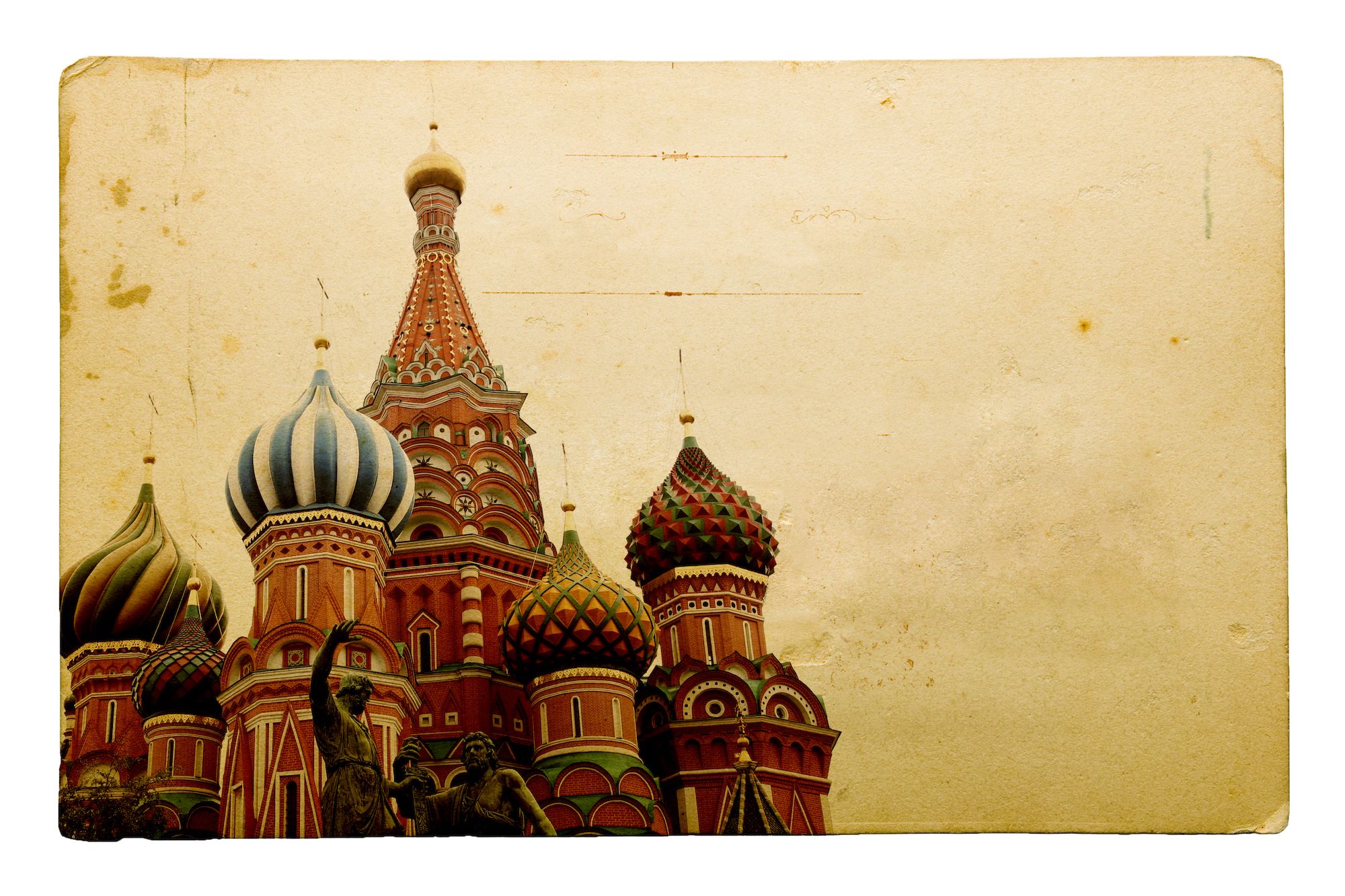Le ho sempre viste dentro a una scatola. Una scatola di scarpe, in un angolo nel prefabbricato dove abbiamo vissuto dopo il terremoto in Friuli. Poi, quando ci siamo trasferiti nella nuova casa, è cambiata anche la scatola. Le lettere che tu e mamma vi siete scritti mentre stavi in Russia hanno conservato un’aura di sacralità a cui non mi sarei avvicinata se non da adulta. In fin dei conti erano affari vostri, mi dicevo, e non mi interessavano quelle smancerie. In realtà non mi interessava conoscere un aspetto dei miei genitori che non avevo mai visto. Pochi baci, pochi abbracci. Figuriamoci leggere dei vostri sogni più intimi. Per me eravate come vi avevo sempre visti, immutati e immutabili.
Quando ho deciso di raccontare la tua storia e farne un documentario (Missing Tape, prodotto da Zalab) sono partita proprio da lì, da quelle lettere. Ho scoperto un’affettività che non sapevo fosse esistita e che avrei voluto colorasse di più le nostre vite. L’ho scoperta tardi, è vero, ma l’amore prepotente che traspare dalle vostre parole a distanza è universale, appartiene a tutti. Nel 1987 l’Unione Sovietica esisteva ancora e tu eri andato a lavorare a Rjazan, 200 km a sud di Mosca. Ti avevano offerto un buon contratto che ti ha permesso di comprare la casa dove siamo andati a vivere sette anni più tardi. Non avevi messo in conto tanto struggimento. Immagino le lacrime, papà. Devi essere partito pensando solo al risultato, quella casa che non avevi mai avuto e dove avresti fatto crescere la tua famiglia.
Invece ti sei accorto di quanto fosse difficile vivere lontano dalla donna che amavi, dalla figlia che avevi lasciato all’asilo.
Neanche il terremoto ti aveva fatto sentire così vulnerabile. Così lontano, oltre la cortina di ferro, con qualche centinaio di dollari nascosti nei calzini. Un lavoratore migrante come tanti, ieri, oggi, sempre.
Voleva che approfittassimo di questo viaggio, la mamma. E sono sicura che l’ha fatto anche con te. La immagino a letto mentre ti sussurra parole sentite decine di volte. «Parla di più con le tue figlie; costruisci un rapporto di affetto e confidenze». Parole che suonano come sassi nel pozzo, la cui eco è frastornante.
«C’è tanto di tenero in lui», mi aveva detto, «sarebbe bello che trovassi la chiave per vederlo anche tu». Mamma, che conosce bene quella tua ruvida dolcezza, sa scovarla dietro ai tuoi modi un po’ rozzi da uomo di montagna. Anche io so che esiste, ma nei panni della figlia-giudice non concedo proroghe. Papà, ti vorrei diverso, e tu potresti dirmi «anche io ti vorrei diversa», ne avresti tutte le ragioni. Facciamolo una buona volta, prendiamoci a schiaffi. Sarà doloroso, mi dico, ma non potrà che nascere qualcosa di buono. Per giorni mi sono chiesta come scrivere queste pagine.
Avrei potuto cominciare dal nostro viaggio in Russia, dalle riprese del documentario che sto realizzando, dalla tua storia di lavoratore migrante nell’ex Unione Sovietica. Avrei potuto cominciare in tanti modi diversi, tutti altrettanto veri ma tutti facili. Perché continuare a nascondermi dietro ai sensi di colpa? È stata un’ossessione per tutto il viaggio. Papà, vorrei fartele leggere, una per una, quelle parole che non ho mai saputo dirti. Concedimi la preziosa libertà della scrittura, fammelo dire così.
Ti ho osservato a lungo mentre scorrevi il paesaggio dal finestrino del treno. Abbiamo lasciato Mosca, la Piazza Rossa, i mercati dove abbiamo comprato cappelli, matrioske e tè cinese; Mosca e l’incenso delle chiese, il lungofiume, le nostre passeggiate infreddoliti tra una stazione del metrò e il parco. Il tuo sguardo è sempre ben disposto, sa posarsi sul mondo con delicatezza, come i fiocchi di neve di cui parli nelle poesie a mamma. Il tuo sguardo mi ha insegnato a guardare, papà. La babushka davanti a noi lavorava a maglia e insieme a me ascoltava il tuo racconto di una Russia che non esiste più. Nell’Unione Sovietica dei tuoi ricordi i treni avevano le panche di legno, nei supermercati le commesse facevano di conto con il pallottoliere, e le automobili, poche in verità, giravano a fari spenti. Non sappiamo se per risparmiare batteria o per nascondere qualche malefatta, le nostre interpretazioni sono discordanti.
Mi piace ascoltarti. Raccontami di nuovo la storia dello spaccio aziendale dove i lavoratori stranieri erano obbligati a spendere centomila lire ogni mese. Il regno delle cianfrusaglie, il “bistrot” come lo chiamavi tu, ha fatto felice chi aspettava il tuo ritorno: matrioske di ogni colore e misura, scatolette di caviale da rivendere, bottiglie di vodka alla fragola, alla menta e alla pesca. Esaurita la lista degli acquisti, ti sei buttato sulle sigarette. Non hai mai fumato, le regalavi ai colleghi. Ti vedo, la sera, stapparti una birra mentre cuoce la pasta e distribuire le stecche ai tuoi compagni di dormitorio.
A Rjazan abbiamo visitato la fabbrica dove hai lavorato 30 anni fa. È diventata una conceria e dà lavoro a 3 mila operai. I macchinari sono italiani, gli stessi di quando c’eri tu. L’odore di animali morti ci accompagna nel tour organizzato da Violeta. Prima di noi qui è venuto il presidente Putin, che ha firmato un tamburo di carne secca appeso vicino alla porta degli uffici. Violeta ne è orgogliosa. Ventiquattro anni, è la responsabile marketing dell’azienda nonché figlia di un ex agente del Kgb addetto alla sorveglianza degli operai stranieri nella fabbrica trent’anni fa. Che caso! Peccato che tu non ricordi Vladimir dei servizi segreti. Ci sono tante cose che non ricordi, papà. Il caleidoscopio che mi hai portato dalla Russia insieme alla balalaika e al colbacco. Non ricordi il viaggio a Bolzano per cercare un nuovo lavoro, ma c’ero anche io seduta sul sedile posteriore con il mal d’auto. E i nostri risvegli dopo il tuo rientro, perché non li ricordi? «Erano momenti normali, come faccio a ricordare la normalità?». Lasciamo perdere. Invece no. Quelle mattine non erano affatto la normalità. Eri appena tornato, come potevano essere la normalità? Come potevano non significare nulla? Lasciarti indifferente? Sono stanca di rincorrere un tuo abbraccio. L’ho rincorso per tutto il viaggio. Colpa tua, colpa mia, importa poco.
Avrebbe dovuto essere un regalo. Tornare insieme, trent’anni dopo. Non dovevi pensare a niente, biglietti, visti, prenotazioni, soldi. Ho fatto tutto io, ma ho fatto troppo. Non ti ho lasciato spazio e me lo fai notare durante il volo di rientro. Un tonfo, prima ancora di decollare. Ti rispondo che un altro padre, invece, avrebbe ringraziato. Provo a distrarmi, fingo di leggere, ma le lacrime scendono ingrossando i sensi di colpa. Non ci sono riuscita neanche stavolta. L’esortazione di mamma non è servita.
Quando ci capiterà un’altra occasione, papà? Avrei voluto che questo viaggio andasse diversamente, ma non ho il coraggio di dirtelo perché non ho il coraggio di dirti che sarei stata meglio se ogni tanto mi avessi abbracciata. I sentimentalismi ti imbarazzano. Non so che fare. Lascio perdere. Stai bevendo il cappuccino, meglio aspettare. Guardo fuori, all’aeroporto di Riga c’è il sole. Ti prendo le mani sul tavolino: «Scusa papà, ho sbagliato. Non avrei dovuto parlarti così. Non ho il diritto di cambiarti». Le mie lacrime adesso sono anche le tue. «No, hai fatto bene. Mamma mi ripete sempre che dovrei parlare di più». Ti tengo stretto, non voglio che finisca.
Riuscirò a guardarti con occhi diversi? Senza critica, libera da quei condizionamenti che mi hanno sempre fatta restare un passo indietro. Vorrei farmi vedere da te per quella che sono diventata, per quello che ho imparato; non sono più l’adolescente incazzata di quando me ne sono andata. Eppure continuo a pensare che tu mi veda sempre uguale. Sono sempre uguale, papà? Con questo viaggio sapevi che sarei tornata da te e che lo avrei fatto da donna. Al contrario di me, che non ho tagliato i fili e che doverne cucire insieme di nuovi mi fa paura. E se scoprissi di non essere una buona figlia? Maledetti fili vecchi, maledetti sensi di colpa. Io non c’ero a festeggiare con voi i tuoi sessant’anni; non c’ero quando zia è venuta a mancare, quando Barbara si è iscritta all’università, quando mamma ha fatto le analisi, quando Laura ha scelto una nuova strada. Sempre via, lontana come quando tu stavi in Russia. Dovresti capirmi. Asseconda il mio bisogno di affetto, ma che sia fisico, tangibile, materiale. Che mi vuoi bene già lo so, papà. Abbracciami.