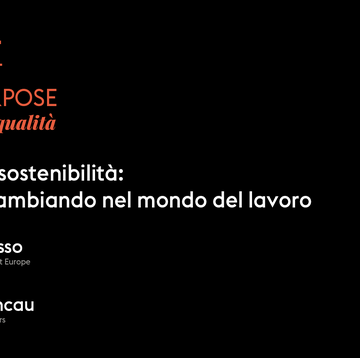NON NE HO LA STOFFA, lo confesso, non sono mai stata una vera amica. Ciò non significa che mi sia sottratta alla vita sociale, ma fin dalla più tenera età ho sempre evitato di cadere in quella trappola di obblighi e pretese reciproche imposte da una certa idea di amicizia, femminile ma non solo.
Quando avevo sei anni e andavo a scuola dalle suore, essere una vera amica spesso significava subire i capricci possessivi di un gruppetto di bambine viziate (me compresa). Alle medie il regime di sudditanza si faceva ancora più asfissiante, e sui banchi del liceo c’era addirittura da impazzire: il rischio di tradimento allora era allo zenit. Se, per esempio, baciavi un ragazzo che secoli prima era stato il ragazzo di un’altra del gruppo era considerato un caso di incesto. Non rimaneva altro che dichiararsi ubriache quella sera, in attesa del perdono che di solito coincideva con il sopraggiungere di un altro caso di bacio, o peggio, in stato di ebbrezza.
L’amicizia, almeno quella in cui sono cresciuta io, era una religione fondata sul carisma, con i suoi dogmi, riti, dubbi da occultare, prove di forza e verità ultime. Ancora oggi questa visione dei rapporti umani, sempre a metà tra il mistico e la corte marziale, mi ripugna. Alle prime avvisaglie tremo: quando un capogruppo mi invita a cena e, da evidenti segnali, capisco che non posso portare qualcun altro perché l’intruso deve prima passare un esame d’ammissione, metto una scusa e scappo. Odio l’esclusione, il settarismo, l’iniziazione, non so mantenere i segreti, mi imbarazzano gli sfoghi, non so consolare, di oltraggi e offese non capisco mai bene il punto, tutte cose che fanno di me un’amica pessima e infedele.
OSSERVANDO, IN PARTE VIVENDO, l’evoluzione contemporanea del concetto di amicizia, non posso fare altro che rallegrarmene. Mi danno un grande sollievo le cosiddette reti diffuse di salvataggio, non mi scandalizza affatto l’amicizia intesa come uno scambio di posti letto, di informazioni, di ex amori, di indirizzi utili, di tempi morti da riempire. Sono solo favori? Prestazioni occasionali? È colpa del sistema dei social? È tutto così superficiale e opportunista? Sarà, ma il fatto che certe gerarchie siano saltate e che una conoscente con cui vai a fare il brunch o l’aperitivo possa renderti brevemente più felice di una sadica prepotente cui hai giurato fedeltà col sangue un paio di vite fa non mi pare tanto irragionevole. Non vorrei che il mio entusiasmo fosse preso per cinismo, né per cieco pragmatismo. La libertà, ovvero il non rompersi le balle a vicenda su questioni di principio che non interessano a nessuno, la libertà, dicevo, di potersi frequentare con leggerezza e senza senso di colpa, fa sì che al momento del bisogno, quando notoriamente si riconosce l’amico, si è forse più disponibili ad aiutarsi.
In vista della ricompensa, sperando di ottenere lo stesso trattamento? Be’, pazienza.
Eppure tutto questo lo si ammette, se lo si ammette, usando spesso una formula scivolosa che ci riporta alla solita morale conservatrice e punitiva: la rete sostituisce la famiglia assente. Allora, così, come surrogato della famiglia, valore assoluto, va bene. Peccato che molti fautori delle reti amichevoli (mi si perdoni l’errore, ma ancora non riesco a usare con disinvoltura l’espressione amicale) le famiglie ce le hanno eccome, non è vero che sono solo il rifugio, anzi, lo squallido ripiego del single. Ci sono madri, padri, figli, fratelli che come possono si avvalgono delle reti amichevoli, e ne tessono di nuove. Tanto per dire, hanno più amiche di brunch e caffè le mamme che attendono l’uscita dalla scuola dei loro bambini che la single destinata, stando alla visione stereotipata e consolatoria di cui sopra, a piangere tutti i venerdì sera sulla spalla di un amico, gay. Piangere per poi tornare, ovviamente, a sorridere, magari ubriache come ai tempi del bacio incestuoso. Semmai, a voler essere sinceri, la rete riafferma la natura più salutare dell’amicizia come fuga dalla famiglia.
S., una delle persone che ho intervistato, tanto per dare un pochino di sostanza alle mie affermazioni, è mamma di due ragazzi di dodici e quattordici anni: li adora, per carità, ma frequenta un giro di amiche occasionali che i figli non ce li hanno perché: «Mi dimentico di loro, dei ragazzi, per un paio d’ore. Sono diventata meno ossessiva, sto meglio».
T. invece è maschio ed è single, ma ha un padre di cui si deve occupare. Recentemente si è fatto un giro di amici cosiddetti del parco. Gente che, come lui, porta fuori il cane: «Faccio finta che quel cane sia mio e non di mio fratello che lo ha lasciato a mio padre. È che ho mentito all’inizio e ora non riesco più a tornare indietro. Ma essere lì perché padrone di un cane, e non come il solito figlio responsabile, mi mette di buonumore».
Le amicizie leggere, poco profonde, garantiscono gioie minori e nascoste, piaceri quasi infantili, in cui ci si sente a proprio agio. Quasi senza accorgersene, innescando una serie di appuntamenti tra poco più che conoscenti, si precipita nella famosa comfort zone, e qui veniamo a un altro imperativo da abbattere. Perché, mi chiedo, si deve per forza uscire dalla comfort zone? Perché se uno sta bene, si sente tutto sommato al sicuro, deve guastarsi la giornata, per non dire la vita?
NON LO SOSTENGO IO, esistono decine e decine di manuali che ci insegnano come abbandonare il luogo sicuro e confortevole che ci siamo faticosamente costruiti. La rete di salvataggio non fa eccezione: quando diventa troppo comoda e non ti espone più al rischio (augurabile?!) dello schianto rovinoso, allora è tutta da smontare. Esiste ideologia più feroce di questa? Dalla comfort zone dovrebbero uscire - spingendo le cose al paradosso - perfino gli anziani che contano sui vicini di casa: sono invitati a sbattere con vigore porte in faccia, a piantare non si sa come astratti e odiosi paletti, a difendere la propria privacy, per non dire di quelli, poveri relitti, che si illudono di partecipare ancora alla vita corrente attraverso l’uso dei social: via! Tutto troppo comodo, troppo poco ardito. Salvarsi comodamente è peccato, serve il triplo salto mortale, senza rete, anche intorno agli ottanta.
In realtà il guaio della comfort zone non è che ci stritoli in una serie di amorevoli e sensate abitudini, ma che in fondo non esista, dunque si perda tempo a combatterne anche solo il desiderio, l’illusione.
Detto ciò, una rete dIffusa e superficiale di amici può comportare rischi veri, altro che starsene beati in una tana, avventure adrenaliniche come la truffa e la bancarotta. Pensiamo alla fine che hanno fatto certi conoscenti di Anna Sorokin, la falsa miliardaria tedesca, la ventisettenne che ha frodato hotel, banche, lasciando buffi clamorosi. La sua storia diventerà la serie di punta della prossima stagione di Netflix. Non era amicizia vera quella che si stringeva con la Sorokin, figlia di un camionista russo, ma una piacevole frequentazione tra le tante, tipicamente newyorkese, che prevedeva soggiorni a scrocco, immersi nel lusso, all’ombra di una fantomatica fondazione. In molti le hanno creduto perché in quel contesto era più facile che sospettare il contrario. È l’eroina negativa della rete degli amici un po’ così, distratti e scafati, in cui i soldi si danno per scontati finché non spariscono. In quel caso gli amici veri, noiosi, possessivi e prepotenti forse li rimpiangi, ma solo fino alla prossima seduta confessionale in cui dovrai giustificarti per qualche scemenza e ti ritroverai come niente a insultare donne e uomini che non conosci perché l’amica vera non li stima più. Le cause della disistima sono talmente banali che le ometto, fanno parte del pacchetto e tutti le immaginano. Così, mentre annuisci all’invettiva come un automa, speri di poter prima o poi mollare le chiavi di casa all’indignata amica vera che hai di fronte, speri che venga a bagnarti le piante mentre sei fuori, ma poi ci ripensi e sai che questo genere di favore, amichevole e gentile, ti conviene chiederlo all’amica superficiale cui presti la casa.