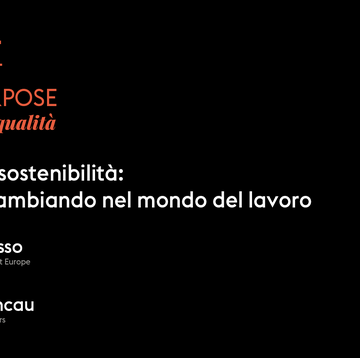Ergastolo per genocidio e crimini contro l’umanità: è la sentenza emessa dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia nei confronti dell’ex capo militare dell’esercito serbo-bosniaco Ratko Mladić. Nel luglio del 1995 ha guidato i soldati che hanno ucciso oltre ottomila civili, uomini e ragazzi musulmani nella cittadina di Srebrenica, di fronte alle forze Onu di servizio in quel luogo che era stato dichiarato "zona protetta".
Molte sono le donne sopravvissute al massacro che rendono testimonianza di ciò che hanno visto. Qui di seguito pubblichiamo il racconto di una sopravvissuta, raccolto dalla organizzazione no profit inglese Remembering Srebrenica, la cui missione è mantenere viva la memoria sul genocidio, archiviando testimonianze e organizzando conferenze e viaggi a Srebrenica.
Ogni 11 luglio si tiene una cerimonia pubblica al cimitero e memoriale di Potočari, appena fuori Srebrenica, per inumare i resti a cui è finalmente stato dato un nome. Ancora oggi continuano i riconoscimenti dei corpi estratti dalle fosse comuni, che sono poi sepolti tra le lacrime delle donne rimaste, che spesso non hanno mai saputo per anni cosa fosse esattamente successo ai propri cari, mariti, figli, fratelli. Questa è la storia di una di loro.
TESTIMONIANZA
Anche se è nata in una famiglia povera con quattro figli, che faticava a tirare avanti nella Jugoslavia degli anni 50, a Fadila Efendić è stato insegnata l'importanza della scuola e della lettura fin da piccola. Ma niente di ciò che aveva letto avrebbe potuto prepararla a quel che sarebbe successo nel luglio del 1995.
«Non basterebbero cento film per raccontare ciò che ho visto in quei due giorni», dice scuotendo la testa e ricordando l'orrore che lei e altre migliaia di persone hanno dovuto vivere sotto gli occhi delle forze Onu a Potočari, appena fuori Srebrenica. Suo marito Hamed e suo figlio Fejzo sono stati uccisi insieme a oltre ottomila altri uomini e ragazzi musulmani che tentavano di fuggire da Srebrenica, ma Fadila non ha mai conosciuto il loro destino per molti anni a seguire. L'unica cosa che ha dato a Fadila la forza di andare avanti era assicurare a sua figlia l'opportunità di studiare e di fare qualcosa della sua vita.
Oggi, nell'ex Jugoslavia ormai divisa, e specialmente in Bosnia Erzegovina, tutti sono ben consapevoli che i nomi sono parte dell'identità delle persone e indicano se sono Bosgnacchi musulmani, Serbi o Croati. Invece Fadila ricorda che le cose erano molto diverse mentre stava crescendo.
«Esistevano tanti momenti di socializzazione condivisa, i pionieri, il motto di Tito Fratellanza e unità, la scuola, e non ci chiedevamo mai chi fossimo o a quale religione appartenessimo. Quando andavo a scuola a Tuzla adoravo il nome di una mia compagna, Elena, e una volta ho detto a mia madre: 'Mamma, è il nome più bello che conosco'. Lei mi ha risposto: 'Sì, è davvero un bel nome cattolico'. Cercavo di capire cosa significasse che era un nome cattolico. È stata la prima volta in cui mi sono resa conto che in Jugoslavia esistevano i cattolici, i cristiani ortodossi e i musulmani».
Sua madre introdusse segretamente i suoi figli alla religione: «Sapevo che ero musulmana. Mia madre non era membro del partito comunista, come lo era mio padre, e faceva le cose a modo suo. Andava in moschea, pregava, ci insegnava queste cose. Naturalmente di nascosto da mio padre. Era decisa e non ha mai rinunciato, e non ne aveva intenzione: 'Tu fai a modo tuo, io a modo mio', gli disse».
All'inizio degli anni 90 la situazione iniziò a cambiare, ma anche se Fadila sapeva di problemi in altre parti del paese, non aveva idea di quanto sarebbero peggiorate le cose.
«Non percepivo nessun tipo di intolleranza tra serbi ortodossi e musulmani a Srebrenica. Al lavoro chiesi ai miei colleghi: 'Cosa succederà?' Mi dissero che non lo sapevano e uno rispose 'forse nel caso qualcuno abbia dei debiti con qualcun altro, allora si dovranno saldare, magari litigheranno, ma niente di più'. Ero così ingenua che pensavo di non aver debiti con nessuno, di non aver mai litigato con nessuno, quindi non mi sarebbe successo nulla di male. Per questo sono rimasta a Srebrenica. Mia sorella se ne andò con i tre figli e così anche i miei fratelli. Io rimasi. Mia madre era molto malata e non poteva partire, qualcuno si doveva occupare di lei. Quindi rimasi con mio marito e i miei due figli».
Questa decisione cambiò la vita di Fadila per sempre: «Non si può spiegare a qualcuno che non l'ha vissuto direttamente, ma se avessi saputo quel che stava per accadere, non sarei rimasta. Sarei scappata via. La guerra non porta solo le uccisioni, ma altre cose terribili. I giorni passavano e ogni giorno era peggiore del precedente. Dovevamo sopravvivere ai bombardamenti e a tutte le avversità della guerra».
Nonostante le terribili condizioni, la famiglia di Fadila tentava di restare in contatto con ciò che stava accadendo, ma la radio trasmetteva solo propaganda.
«Ascoltavo Radio Belgrado, ma riuscivamo a sentire le notizie solo finché duravano le batterie. Non ce n'erano a sufficienza nemmeno per la luce nella stanza. Parlavano dei contro attacchi che partivano da Srebrenica e di come l'esercito serbo era obbligato a farsi avanti per difendere la popolazione. Allo stesso tempo sopportavamo pesanti bombardamenti, non c'era nessuno per strada, non avevamo abbastanza armi per difenderci. Mentivano in continuazione, cercavano di giustificarsi con le famiglie che spedivano i figli in battaglia. Costruivano l'idea che si dovesse combattere, difendere le persone, quando in realtà ci stavano uccidendo. Era propaganda di guerra. Chi si sente in colpa cerca sempre un modo per giustificarsi».
La madre di Fadila è morta nel 1995, ma il resto della famiglia viveva ancora nella casa appena fuori Srebrenica. «Non ho mai creduto che quella fosse una zona protetta, come la chiamava l'Onu. Come potevamo crederlo quando i soldati serbi ci lanciavano le bombe e uccidevano le persone quando volevano? Gli spari si intensificavano talmente che chiesi a mio marito 'Caro, cosa succede? Cosa succederà?'. 'Qualcosa deve succedere, mi disse, torneremo liberi oppure ci uccideranno tutti'. Il generale serbo Milanovic disse a Radio Belgrado: 'Srebrenica è un'enorme sala d'aspetto. Possono solo rimanere seduti e aspettare quando arriveremo per finire il lavoro'».
Non molto dopo questo nefasto avvertimento, accadde il peggio: «Arrivò il fatale 11 luglio 1995. Dicevano che ci avrebbero protetto. Gli aerei della Nato volavano sopra Srebrenica ma non facevano nulla. Ho chiesto a mio marito: 'Cosa stanno aspettando? Non vedono che le persone sono nel panico, che stanno cercando di scappare nei boschi?'. Mi ha risposto: 'Il mondo non permetterà che accada'. Ma quale mondo? Puoi contare solo su te stesso. Non contare sul mondo per proteggerti. Io e mia figlia lasciammo la nostra casa, mentre mio marito e mio figlio rimasero per cercare di fuggire nei boschi il giorno successivo. Dopo ho sentito che anche loro sono venuti alla base Onu, dove ero andata con mia figlia. Ma non li ho mai più rivisti».
Invece di un rifugio, la base Onu era una scena dall'inferno, come ricorda Fadila: «Io e mia figlia siamo rimaste alla base Onu due giorni e due notti senza cibo né acqua. Non avevo fame, solo freddo, eppure era luglio, ci saranno stati trenta gradi. Ma io sentivo freddo, gelavo. Era la paura, non faceva veramente freddo, ma ero terrorizzata. Stavamo guardando la morte negli occhi, aspettando che ci venissero a prendere per ucciderci. Parlavi con qualcuno e un attimo dopo era scomparso. Dove era finito? Bastava un cenno con un dito e veniva ucciso o portato via. Era terribile, tutti per terra in questa fabbrica di batterie: vecchi, donne, bambini. In un angolo una donna partoriva, in un altro angolo una donna moriva. Non che l'avessero uccisa: stava morendo di paura. Una donna partoriva, sentivo il bambino piangere, e un momento dopo non si capiva se fosse vivo o morto. La mamma non aveva latte al seno. Ricordo un'altra donna che aveva partorito due giorni prima e implorava per avere del latte o dello zucchero per il bambino. I bambini morivano o piangevano di continuo. Una donna si è impiccata per la paura. Era il caos totale. Mi alzai in piedi per guardare la scena. Se solo avessi avuto una telecamera per riprendere tutto. Rispetto i giornalisti, ma quando le cose arrivano al peggio, non ci sono mai. Scappano, è normale. Tutti hanno paura per la propria vita».
Un incontro che fa venire i brividi è rimasto indelebile nella mente di Fadila, anche se non era consapevole del significato all'epoca. «Mi trovavo alla base Onu nella fabbrica di batterie a Potočari, quando un soldato serbo si è avvicinato e mi ha detto: 'Non avere paura, non ti faremo del male. Dobbiamo solo sapere chi è il padrone e chi sono gli schiavi'. A quanto pare era proprio il generale Ratko Mladić. Ma come potevo sapere chi fosse Mladić? Era solo un uomo in uniforme, che venne da me e mi disse questo».
Il giorno dopo, Fadila e sua figlia furono portate via su un camion militare. «Aspettavamo solo che ci facessero scendere per ucciderci. Vedi un uomo morto, ma non ti interessa. Non hai tempo di guardarlo e capire chi sia. Il momento peggiore è stato nella cittadina di Kravica, mentre guardavamo una colonna di persone che veniva portata dentro un magazzino. Un uomo del gruppo mi ha riconosciuta e ha urlato il mio nome. Ma quando l'ho sentito, non ho osato voltarmi. Pensavo mi avrebbero uccisa, pensavo mi avrebbero sparato. Potevi vedere la paura sul volto di tutti. Colpivano la gente con le pistole. A Milici ci lanciarono sassi. Il camion si era fermato per rifornimento d'acqua. Acqua? Non era certo il nostro primo pensiero. Volevamo solo proseguire, così che un sasso non ci colpisse in testa. Questo era il livello d'odio. Quattro soldati in uniforme nera imprecavano e dicevano: 'Guarda quanti bambini. Dovremo fare un'altra guerra tra vent'anni'. E io pensavo soltanto che se fossi rimasta viva avrei dovuto sopportare di nuovo tutto questo. O come i nostri figli avrebbero dovuto rivivere tutto da capo».
L'attesa di notizie su ciò che era accaduto a suo marito e suo figlio era straziante e di certo non aiutava ricevere informazioni sbagliate. «Mi mentivano, un traduttore mi disse che aveva visto Fejzo e Hamed su un bus, che in realtà erano già in territorio libero. Altri dicevano che li avevano catturati e lasciati andare. Mi fidavo dei diplomatici, credevo che avrebbero fatto qualcosa. All'epoca non ero certa che potessero uccidere davvero tutte quelle persone. Già uccidere dieci persone è tanto, non parliamo di tutte quelle migliaia. A volte mi chiedo semplicemente come non si siano stancati. Arrivata nei territori liberi continuavo a cercare mio marito e mio figlio. Mi dissero che ero pazza. Come potevano essere arrivati lì con tutte quelle persone scomparse? Ok, ero pazza. Il giorno dopo sono andata alla Croce Rossa Internazionale per denunciare la loro scomparsa e non riuscivo nemmeno a dire una parola. Ho dovuto bere dell'acqua prima di parlare».
Solo un anno dopo Fadila ha cominciato ad accettare l'idea che non li avrebbe mai più rivisti vivi: «Andai in Germania e, mentre viaggiavo su un treno diretto a Zagabria, un soldato croato mi disse: 'Non si illuda, non sono vivi, è meglio se capisce che se ne sono andati per sempre. Erano tanti prigionieri e sarebbe stato troppo costoso tenerli in prigione o in campi. Era più facile ucciderli tutti'. Lo fissai con uno sguardo triste. Era davvero difficile per me poterlo accettare, ma bisogna affrontare la realtà prima o poi, non importa quanto amara».
Finalmente, molti anni dopo, nonostante gli sforzi delle forze serbe per nascondere i cadaveri in fosse comuni, furono ritrovati i resti di suo marito e suo figlio. «Nel marzo del 1998 è stato identificato il corpo di mio marito, ma non era completo. Il suo corpo è stato trovato in una fossa e la sua testa in un'altra. Quella verità è stata terribile. Altrettanto difficile è stato quattro anni dopo, quando ho scoperto dove fosse finito mio figlio. Ma hanno trovato solo due ossa delle gambe». Il dolore per la perdita del figlio è particolarmente difficile da sopportare per Fadila: «Ogni madre è una leonessa per i propri figli. Quando partorisci lo sai. Quando tuo figlio ha la febbre, hai paura che accada qualcosa, che possa morire. Cosa puoi dire quando tuo figlio è ormai cresciuto, ma qualcuno te lo porta via per ucciderlo».
Nonostante il dolore e il trauma di queste esperienze tremende, Fadila è ritornata a Srebrenica per aprire un negozio di fiori. «Ho iniziato a capire che dovevo andare avanti. Sono sopravvissuta insieme a mia figlia, e lei ha solo me. Devo lavorare e guadagnare, affinché mia figlia non si senta orfana. Un po' si è sentita così senza la tenerezza e l'amore di suo padre e suo fratello. Sono dovuta essere forte e in grado di darle tutto ciò che potevo. Il suo compito era studiare, il mio lavorare. Abbiamo fatto un patto: devi studiare per non deludere tutta la fiducia che ho in te, mentre io lavorerò per pagare la tua istruzione».
Per quel che riguarda la giustizia, Fadila è irremovibile. «Io dico solo la verità e quelli che mentono, che negano il genocidio di Srebrenica, negano le esecuzioni che sono avvenute qui, negano che la Serbia abbia partecipato alla guerra, loro devono avere paura. La Serbia deve essere ritenuta responsabile. Se pagheranno le riparazioni di guerra o saranno puniti per ciò che hanno fatto, potranno vivere e morire in pace. La verità verrà a galla prima o poi. Chi mente crea problemi per le future generazioni, per i propri figli».
Per i sopravvissuti come Fadila, il negazionismo sul genocidio di Srebrenica causa ulteriore dolore. Oggi è seduta nel suo negozio di fronte al cimitero e memoriale di Potočari, dove ogni 11 luglio vengono seppelliti i corpi a cui ogni anno, lentamente, viene dato un nome: «Quando sento queste bugie è come se mi picchiassero. E non posso dire che mi fa male? Fa male quando si viene picchiati. Non c'è giustizia. Queste tombe e tutti questi morti sono caduti dal cielo? Un meteorite è caduto e le ha uccise tutte? Non è quello che è successo. È risaputo chi ha ucciso queste persone. Nemmeno io credevo potesse accadere, ma ora devo parlare perché quel che è successo a noi non accada mai più a nessun altro».
Remembering Srebrenica è un'organizzazione no profit della Gran Bretagna, impegnata a salvaguardare la memoria di Srebrenica per costruire comunità più sicure e combattere odio e intolleranza. Coordinano le commemorazioni per il genocidio di Srebrenica nel Regno Unito e l'anno scorso hanno organizzato oltre mille eventi, coinvolgendo oltre 60mila studenti.
Traduzione e adattamento a cura di Laila Bonazzi.