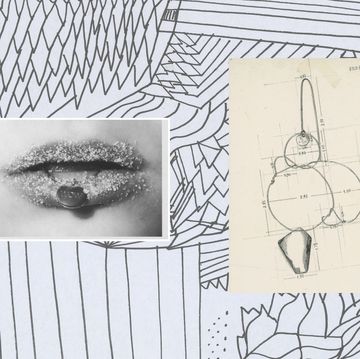Alla fine, è sempre una questione di soldi.
Hedi Slimane non disegna più Saint Laurent. I rumors di un suo abbandono si sono coagulati in uno scarno comunicato stampa a firma di François-Henri Pinault, patron di Kering, conglomerato del lusso che possiede, oltre alla griffe fondata da Yves, anche Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, Stella McCartey, Boucheron, Pomellato, Puma e qualcun altro che ora ci sfugge. Ringraziamenti, formule di rito, è stato bello ma ora adieu. Adieu, mica au revoir. Secondo i ben informati, alla base dello scisma ci sarebbe stato, al momento di rinnovare il contratto quadriennale scaduto, un mancato soddisfacimento reciproco. Insomma, detta in parole povere (perdonate il mesto giochino di parole), Hedi Slimane avrebbe chiesto più soldi. La Nestlé del lusso gli avrebbe risposto: «No».
Girava già da alcuni mesi la notizia che non sarebbe stato più lui il direttore artistico della leggendaria maison francese. A cui, per prima cosa, aveva troncato il nome proprio e aggiunto “Paris” alla fine: del resto aveva fatto la stessa cosa quando era salito agli onori della cronaca nel 2000, disegnando la linea uomo di Christian Dior, che con lui era diventato semplicemente Dior Homme. Quattro anni fa era stato chiamato a risollevare un marchio che di mitologico aveva i ricordi dei fasti trascorsi, nonostante il buon lavoro svolto dal suo predecessore, Stefano Pilati (poi andato da Zegna e anche lui rimosso dall’incarico di direttore artistico del marchio italiano di sartoria maschile).
Con quello di Massimiliano Giornetti da Ferragamo, di Alessandro Sartori da Berluti, di Alexander Wang da Balenciaga, di Alber Elbaz da Lanvin, di Raf Simons da Dior, di Brendan Mullane da Brioni si consuma l’ennesimo divorzio tra i creativi e chi tiene il portafoglio. Sono troppi. Non sono più sintomi di una malattia. È una malattia.
La cosa strana è: nel caso (di alcuni) degli altri, un simile atteggiamento si poteva giustificare con un mancato decollo di vendite e, di conseguenza, un tragico atterraggio nei fatturati. Nel caso di Saint Laurent l’addio di Hedi Slimane non può essere spiegato neppure così. Il Wall Street Journal riporta che dai 353,7 milioni di euro nel 2011 il marchio era asceso a 973,6 milioni di euro nel 2015: vendite più che raddoppiate e soprattutto ben distribuite. Sono volati dai negozi abiti e borsette, scarpe e cinture, cappelli e bijoux, equamente ripartiti tra consumatori e consumatrici, con una conquista mai vista prima dei mercati orientali, Cina e Corea in prima linea. Nulla da fare: non è bastato neanche questo.
A noi che scriviamo di falpalà e falpaqua, il fatto che Slimane se ne vada, sembra indizio di un disagio che contagia un sistema sempre più smarrito, che annaspa nella spasmodica ricerca di superare i ricavi del semestre precedente. Non importa se le vendite s’impennano, gli introiti sono sotto Viagra, i ricavi giganteggiano. Che l'industria della moda i conti li faccia prima con stessa, e poi con i direttori creativi, impiegati di prim’ordine ma dai contratti più fragili di quelli di una Fornero modaiola.
Mi costituisco: quando Slimane fece la prima collezione per Saint Laurent, la trovai spaventosa. Di più: irrispettosa, anacronistica, sbagliata, proprio perché noi, vittime consenzienti della moda, lo avevamo così tanto amato nei primi anni 2000 da costringerci a prolungati digiuni pur di entrare nei suoi abiti sottili sottili. Se era riuscito a far dimagrire Karl Lagerfeld di 40 chili per entrare nelle sue giacchette che ridisegnavano una volta per tutte la silhouette maschile, figuratevi noi, ragazzotti della periferia del glamour. Uno dei miei colleghi preferiti, Alexander Fury, che scrive per l’Independent, parlò di «disonore» sia rispetto al percorso professionale di Hedi medesimo, sia rispetto a quello del grande Yves. Dentro di me, lo applaudivo. Be': ci sbagliavamo.
Hedi Slimane è sempre stato, per usare una parola molto di moda oggi, estremamente “divisivo”. Reagiva male a chi osasse criticarlo: zero interviste, vietato per sempre l'ingresso a chi scrivesse che le sfilate per Saint Laurent erano così così, come successe nella faida tra lui e Cathy Horyn, all’epoca temuta critica di moda del New York Times. Be': si sbagliava pure lei. In realtà Slimane ha dimostrato di non essere solo un designer intellettuale e d’élite, ma un creatore di identità. Lui, e non noi, ha capito per primo che oggi far sembrare di Zara abiti che una volta presi in mano rivelano una fattura squisita, è la ricetta vincente per il successo.
ntanto fiorivano le leggende: il pessimo carattere, gli ostinati mutismi alternati a improvvise sfuriate, le notti insonni cui costringeva il suo team per arrivare al fit perfetto, l'aver fatto restringere le porte dei suoi uffici perché non tollerava assistenti donne oltre la 40 e assistenti uomini oltre la 46. Di madre italiana e papà tunisino, capisce benissimo la nostra lingua ma si rifiuta di parlarla. L’ho incontrato una sola volta, nel 2002, al Pitti di Firenze, in occasione di una sua sofisticatissima installazione, Intermission - un labirinto di specchi neri che secondo lui era ispirato a una Versailles astratta e cupa ma per me somigliava a una darkroom da sesso casuale - accompagnata da un libro di pagine specchiate, intervallate da poche foto di ragazzini di schiena o di tende dischiuse su albe in città anonime. Abbiamo parlato a lungo dell'amore per il giornalismo (non voleva fare lo stilista, ma il reporter), per l’arte contemporanea, per la fotografia (guardate il suo Diary Online). E ci siamo confrontati sulla sua ossessione per quel periodo brevissimo della vita in cui non si è né uomini né donne ma crisalidi sull’orlo della sessualità: l’adolescenza. Intermission, per capirsi, è l’intervallo tra il primo e secondo tempo di un film o di uno spettacolo teatrale: un tempo breve, spesso vuoto ma prezioso. Per me lui è un artista e, va da sé, avevo speso due stipendi per presentarmi strizzato in un suo tailleur da uomo - li chiamava così, 15 anni prima del genderless - cercando di essere come lui senza ovviamente riuscirci. È alto, magrissimo, dinoccolato, con un inquietante aspetto giovanilistico - nel 2016 compirà 48 anni - e dagli occhi enormi come quelli di un malato del morbo di Basedow. Se anche avessi deciso di morire d’inedia, non sarei mai riuscito a incarnare la fisicità fantasmatica che evocò per Dior Homme. Eppure, con quei vestiti, Slimane fu il primo stilista di moda maschile a ricevere il CFDA, il premio del Council of Fashion Designers of America, la Camera della moda Usa.
La capacità di modificare il corpo maschile è stata così rivoluzionaria e definitiva che vedere una parata di vestirelli vintage, giubbotti da motociclista, camicie a quadretti grunge che cancellavano per sempre l’esprit parisien del grande Yves, mi è parsa una furbata disutile, un oltraggio insensato, un pateracchio di robe già viste, un H&M drogato nei prezzi destinato a fanciulle/i anoressiche/i e miliardarie/i. Invece no: ci ha dimostrato che un artista può diventare un accorto businessman. La missione era vendere? Bene: i consumatori oggi sono minuti perché soprattutto orientali, sono magri per status sociale (s'è mai visto una ragazzina ricca e cicciona? No). E s’identificano non più con le modelle ma con i loro idoli. Ha usato benissimo i social media, mettendo online i video dei défilé, chiamando come testimonial icone musicali di celebrità totale: Kim Gordon e i Daft Punk, Marianne Faithfull e Jane Birkin, Courtney Love e Marilyn Manson.
Ha continuato a essere amato e odiato: ha perfino fatto uscire dai gangheri quel bravo ragazzo di Imran Ahmed, fondatore di Business of Fashion. Ha messo paletti insormontabili alla stampa: al massimo due inviti a testata, l'obbligo di mettere sempre il suo nome nelle didascalie dei vestiti e di non metterlo mai in quelle di profumi e make up, campi in cui non gli è stato concesso di mettere becco creativo e da cui platealmente ha preso le distanze. In più c'è un ufficio stampa laureato all’Università dell’Antipatia. Tutto condito da una smania di controllo che puoi comprendere solo se consideri una passione divorante e smodata per ciò che si fa. Senza tralasciare neanche una paillette.
Hedi adora la perfezione anche se mette in scena il disordine. Proprio perché è il suo disordine, non ha mai lasciato nulla al caso: dalle campagne pubblicitarie al casting di ogni singolo/a modello/a.
Ora io chiedo perdono. Mi rendo conto che l’aver fatto risorgere Saint Laurent in quel modo lì – studio creativo a Los Angeles, dialogo ininterrotto con ogni espressione creativa underground - era l’unico per renderlo contemporaneo. Basta con la ricerca stilistica e vai con le band californiane sullo stage, gli inviti commissionati a pittori e fotografi semisconosciuti, le sfilate-evento dove quel che conta è l’atmosfera da effondere, in seguito, su una canotta, un paio di orecchini, un portachiavi.
Un cinismo che poi si è rivelato nella sua anima più vulnerabile con l’ultima sfilata donna per il prossimo inverno: una prova di rigore matematico e di eleganza assoluta che segna la strada per una nuova grammatica della couture. Ha di nuovo scaravoltato tutto e tutti, ci ha fatto capire che lui di idee nuove ne aveva e ne ha, e pure tante. Poi, niente: alla fine del défilé ha baciato sulla guancia l’ottuagenario Pierre Bergé, storico compagno di vita di Yves Saint Laurent. Et voilà, se n’è andato. Certo, se a uno che ti fa fare tanti denari non vuoi riconoscere un ritocco allo stipendio, non puoi arrabbiarti se va via. Magari sbattendo la porta (stretta). Soprattutto se gli ordini di fare solo abiti e di non intromettersi nei settori del trucco o dei profumi. Ché i ricavi, cari miei, aumentano soprattutto ai duty free, mica solo nelle boutique.
Alla fine, non è sempre una questione di soldi.
Altrimenti finisce tutto in Vaccarello.