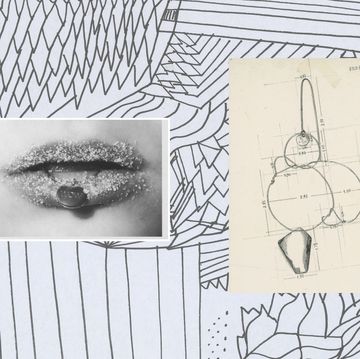Era tutto pronto, con l’accuratezza con cui nessuna cartella era mai stata preparata. Le lentiggini me le avrebbe disegnate con la matita per il contorno labbra, per i codini erano, per la prima volta nella vita, giusti i miei ricci, e il vestito bianco era abbastanza somigliante a quello dentro al televisore: sarei stata una Candy Candy perfetta, e quello degli 8 anni sarebbe stato il più bel Carnevale di tutti i tempi. Poi la babysitter rispose al telefono della camera dei miei, quel telefono bianco che suonava strano, poi da grande avrei scoperto che si chiamava Grillo ed era considerato un capolavoro del design, ma allora era solo uno scomodo telefono senza cornetta - ma sto divagando.
Già che ci siamo con le incidentali: la babysitter non era una vera babysitter, era una cugina molisana di mia madre, viveva nella mansarda intanto che faceva l’università a Bologna, e in cambio, invece di godersi la vita da ventenne fuori sede, sprecava il suo tempo libero a badare a me - ma io all’epoca mica sapevo quanto doveva detestarmi per il mio ruolo di argine alla naturale scelleratezza della sua età, poverina, ero convinta che mi volesse bene, e che me ne volesse anche suo padre, che ogni Natale mi regalava molti più soldi di quanti me ne desse mia nonna, e io non sapevo che era il suo modo di pagare la pigione della figlia, io pensavo che tutta la vita avrei ricevuto rotoli di banconote così, per simpatia. Fine delle divagazioni, torniamo al telefono bianco.
La poco più che ventenne risponde al telefono: era mia madre. Non era a Bologna, era una donna di 38 anni che non possedeva scarpe senza tacchi, ancora le reggevano le tette e la faccia, la invitavano alle feste e in lunghi weekend in posti da ricchi, non aveva mai lavorato un giorno in vita sua: voi, al suo posto, avreste perso gli ultimi anni buoni della vostra tenuta epidermica appresso a una bambina? No. E infatti: neanche lei. Non ricordo dove si trovasse, in quei giorni di Carnevale, mentre io mi accingevo a indossare il costume dei sogni, ma mi ricordo la telefonata dal telefono bianco, quella in cui vidi la mia fine sul viso della cugina molisana. Certo, le stava dicendo. Due paia, le stava dicendo. La trasformazione del sogno in incubo aveva un nome, un nome preciso, un nome che conoscevo dalle odiate settimane bianche, e quel nome era: collant di lana.
È inutile che vi racconti lo strazio del resto della conversazione, io che strappo il telefono urlando come in certi ralenti disperati di brutti film, nooooo, i collant di lana nooooo, ti giuro mamma non fa freddo; la cugina che dice: in effetti a Bologna non sta nevicando; mia madre che taglia corto: figuriamoci, è febbraio, vuoi farmela ammalare (sottinteso: poi finisce che mi tocca frequentarla, non ho neanche un costume da madre pronto per questo Carnevale). È inutile che vi racconti come quel sogno lieve di Candy in mussolina divenne un incubo di pomeriggio con due collant dal cavallo corto. Perché oltre al caldo - io ho sempre caldo, non riesco a ricordare se fosse così anche prima o se il mio chiedere sempre di spegnere il riscaldamento sia il prodotto del trauma di quel Carnevale - oltre al caldo c’è il dramma che non devo certo spiegarvi, se mai avete intravisto una pista da sci lo sapete: il collant di lana ha sempre il cavallo corto.
Per molti anni ho creduto fosse un difetto mio: ho le cosce sbagliate, alle altre non sta un centimetro troppo giù, inducendole a camminare a gambe larghe come i cowboy. Il momento più rasserenante della mia vita adulta, quelle folgorazioni che di solito devi pagare vent’anni d’analista per ottenere, è stato quello in cui un’altra m’ha detto che no, non ero io: il cavallo dei collant sta sempre corto a tutte. Se dovessi sceneggiare un film autobiografico, ci metterei una scena in cui, il martedì grasso del 1980, la piccola Guia, con delle lentiggini mal pittate in faccia, giura come Rossella a Tara che non avrà i collant mai più. Supererò questo momento, e quando sarà passato non soffrirò mai più il cavallo corto: dovessi mentire, truffare, rubare, uccidere, lo giuro davanti a Dio, non soffrirò mai più il collant. Poi non fu necessario truffare, non più di tanto: sono diventata grande negli anni in cui sono passate di moda le calze.
Al massimo quelli che dovevano far vedere che non badavano alla moda t’irridevano un po’: prima ti chiedevano se volevi fare la londinese, poi la newyorkese, poi la milanese; mentivi per omissione, certo non potevi confessare d’avere il problema del cavallo corto. Per fortuna c’erano le parigine, intese non come cittadine di quel posto elegante senza sforzo ma come calze che si fermavano sopra al ginocchio e non infierivano sul tuo cavallo sbagliato; un tipo per ogni fase: quelle a righe bianche e nere che mettevo al liceo, molto londinesi, si compravano allo stesso mercatino dei jeans strappati; quelle di seta, che tentavano d’esser sexy, ebbero il loro momento di gloria fra i venti e i trenta; e poi scoprii le parigine di Prada, ci investii un capitale intorno ai trent’anni, ogni tanto ne spuntano ancora fuori di spaiate da qualche anfratto del guardaroba, erano così favolosamente da bibliotecaria sexy che quasi dimenticai che non erano una scelta fashionista, bensì la copertura del mio più segreto e impresentabile problema: i collant che mi stavano sbagliati, il cavallo corto.
La soluzione alla mia principale vergogna, l’alternativa al morire di freddo senza calze, o al mettere i pantaloni da novembre ad aprile, è stata quel movimento di liberazione dall’imbarazzo da commesse che è il commercio on line. La mia vita è cambiata il pomeriggio in cui, su un sito di calze, ho selezionato come taglia la quarta. Lì non c’erano addette alla vendita che ti guardavano e ti dicevano che figuriamoci, eri alta un metro e un barattolo, per te ci voleva la seconda. Lì non c’erano donne evidentemente speciali che potevano permettersi il lusso di pensare che il guaio da scongiurare fosse il collant grande che ti faceva le pieghette sulla caviglia, loro fortunate, loro felici poche cui la vita non aveva insegnato quel guaio invalidante che è il cavallo corto. Cliccare e comprare la quarta, appresi appena arrivò il pacco, era risolutivo: c’era tanta di quella stoffa in più che potevo tirarmi l’elastico fin sotto le tette, e mai più avrei dovuto sentire il cavallo tirare e scendere.
Non ho mai capito cosa sia l’empowerment, ma so che la mia infanzia infelice è finita solo verso i quarant’anni, il giorno in cui mi sono sentita pronta a mollare il vile ripiego dell’acquisto su internet, a entrare in una merceria e, alla commessa che tentava di vendermi la seconda, dire risoluta che no, io valgo, io vivo nel progresso e nella performance, io sono mia, e voglio i collant della quarta. Sì, sono per me. Sì, lo so quanto sono bassa, grazie, non si preoccupi. Non ho mai ben capito quando un trauma si consideri superato - quando non fai più brutti sogni? Quando non lo ritieni la cosa che i nuovi fidanzati devono sapere di te? Quando ti rendi conto che per amore non si muore, lo sai dalle canzonette, ma nessuno t’aveva detto che non si muore neanche d’imbarazzo? - però a ogni Carnevale io le vedo per strada, le bambine in costume, e le scruto con attenzione per notare smorfie di disagio, e ogni tanto, se sto camminando con qualcuno, quel qualcuno mi fa notare che le fisso, e fa giri di parole che vogliono domandare se la mia attenzione indichi un ripensamento, un rimorso, un interrogarmi su quelle figlie che potrebbero essere mie; e invece è che quelle figlie potrei essere io, e voglio accertarmi che nessuno sia stato così prepotente da far indossare loro i collant di lana.
GUIA SONCINI Ha scritto cinque libri, non ha mai festeggiato Halloween da grande, ed è stata piccola negli anni in cui i rullini costavano. Se un giorno finirà di scrivere il sesto libro, quello sui travestimenti infelici degli anni Ottanta, nessuna foto d’epoca potrà sbugiardarla (la bambina nella foto non è Guia).