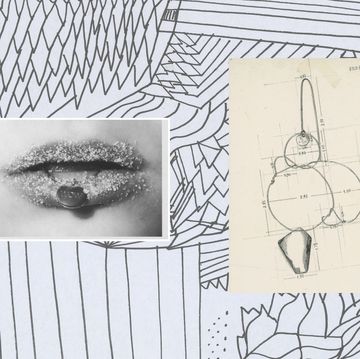Zac Posen chiude la sua linea: una notizia, quella di un fallimento, che non è mai bello sentire. E figurarsi quanto sarà stato drammatico per i dipendenti del marchio fondato nel 2001, apprenderlo lo scorso venerdì. Si cercava nuovi acquirenti in quanto la società di investimento che ne deteneva una quota, Youcaipa Companies, desiderava vendere. Ma il tempo è scaduto, e i nuovi acquirenti non sono stati trovati. “Surreale, orribile, molto intenso”, ha detto l'omonimo stilista al WWD, giornale al quale ha dato la notizia della chiusura. E però la notizia sostiene la tesi, costruitasi negli scorsi anni in sordina, quasi vergognandosi anche di pensarla, che il fashion system americano, promosso urbi et orbi da Anna Wintour, che ha da poco compiuto 70 anni, non funziona, al netto di una costante propaganda regalata al mondo intero attraverso le pagine dei giornali nazionali.
Tornando indietro, in effetti, di quella leva modaiola del 2009, che la Wintour si è spesa nel magnificare – passando anche, da pratica businesswoman qual è, all'atto pratico, e quindi mettendo in contatto i virgulti da lei selezionati con i produttori e poi con i principali department store del paese – è rimasto poco, e tutto particolarmente trascurabile, agli occhi di italiani e francesi, i diretti competitor che non si sono mai sentiti neanche sfiorati dal "wind of change" che sarebbe dovuto arrivare dagli USA. Nessun altro direttore di giornale ha mai avuto il suo peso specifico nell'economia della moda, nessuno ha mai fatto pesare così tanto la sua influenza, eppure. Zac Posen, oggi 39 anni, già con un documentario Netflix a lui dedicato, strumento cinematografico perfetto per lo story-telling di un culto mai nato nella vecchia Europa (House of Z, del 2017), avrebbe dovuto essere l'erede diretto di Oscar de la Renta, creatore ante litteram di abiti da red carpet e sogni in organza. Peccato che di soli red carpet, purtroppo, negli anni dieci non si viva più, e nonostante le creazioni di Posen siano state portate ai maggiori eventi da Uma Thurman, Gwyneth Paltrow e Naomi Watts, tra le altre, non sia mai arrivato poi nei guardaroba delle americane. Una linea da giorno sempre e comunque troppo incastrata incerti stilemi antichi, che non ha mai preso il volo, non ha aiutato il brand, che comunque Zac Posen ha cercato negli anni di sostenere attraverso molteplici licenze e collaborazioni (tra le altre Delta Airlines e Brooks Brothers).
Eppure, di questa crisi di talento, al netto dell'abbondanza di nomi, aveva già scritto nel 2013 Cathy Horyn, quando era ancora al New York Times, lamentando il calendario di una New York Fashion Week colmo di eventi che si sovrapponevano, e però carente di un vero significato: “Il problema è che ci sono troppi marchi e il talento non è abbastanza originale: è scioccante vedere la mancanza di energia e di fantasia.Nel momento in cui il talento in Europa è particolarmente forte –Christopher Kane, Raf Simons da Dior, Phoebe Philo da Céline, per citarne solo alcuni – la debolezza di New York è sconcertante”.
Non un caso isolato, in effetti, è stato quello di Zac Posen. Il vero wunderkind secondo Anna è sempre stato Alexander Wang, che invece avrebbe dovuto prendere il testimone dal brand sinonimo dello sportwear à la page, quello di Tommy Hilfiger, aggiornando i canoni dell'athleisure, prima che questa parola divenisse di uso comune, e comunque A.V, cioè Ante Virgil(Abloh) che poi ne ha espanso il significato fino all'eccesso, caricandolo di un astuto marketing di cui gli americani avrebbero dovuto essere maestri (a scanso di equivoci, Abloh, profeta dell'athleisure odierno, è americano, ma con il suo marchio, Off-White, sfila a Parigi e ha comunque iniziato la sua carriera dopo gli stilisti qui citati, mai definendosi come designer, e mai gravitando nel circolo ufficiale della moda americana). Si disse, all'epoca, che fosse stata la mano di Anna, leggendaria e decisiva quanto la mano de Dios di Maradona contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986, ad orchestrare l'arrivo di Wang da Balenciaga. Eppure, il sodalizio iniziato nel 2012, durò solo tre anni e qualche collezione in più. Gli esperti un po' campanilisti, tennero le labbra strette parlando di decisione consensuale, rapporto di vicendevole scambio: Imran Amed di Bof sostenne che “è la decisione giusta per entrambe le parti, così Wang ora si può concentrare sul proprio marchio e Kering può provare a cercare nuovamente il giusto talento che possa iniettare a Balenciaga quel tipo di creatività che la renda il suo prossimo brand miliardario” (laddove gli americani, se difettano di visione, ci hanno sempre raccontato di essere primi assoluti nell'arte del business e degli incassi, e quindi Wang avrebbe dovuto far suonare potentemente i registratori di cassa), mentre Vanessa Friedman del NewYork Times, sosteneva che “Wang è stato effettivamente
tra una storia e l’altra. Ora Balenciaga e la sua casa madre Kering, sono libere di trovare qualcun altro senza le stesse aspettative”. Le aspettative a cui si fa riferimento qui sono quelle, altissime, del predecessore di Wang, l'"ex fidanzato" Nicholas Ghesquière, quello che poi sarà termine di paragone sentimentale per tutti quelli venuti dopo, secondo la Friedman, e che aveva lasciato il suo posto da direttore creativo, emigrando da LVMH e da Louis Vuitton. Aspettative che, dopo il passaggio di Wang, che cercava di ricreare i volumi ad uovo per cui Balenciaga era famoso senza però infondere in loro abbastanza grazia, si sono settate su altri parametri, sostiene la Friedman. Al ribasso, ci si sente di aggiungere.
Oggi Alexander porta avanti con un certo successo la sua linea, è famoso per essere famoso, tanto da apparire nella pubblicità di Dom Pérignon insieme a Zoe e Lenny Kravitz in un circolo di amici belli e affluenti che fanno festa solo con bollicine di un certo livello, e a breve arriverà sulla nuova piattaforma di streaming americano Quibi, il suo programma PottyTime, dove intervisterà i suoi amici belli e famosi, sempre gli stessi, nelle toilette degli eventi più ambiti, dal Met Gala agli Oscar. Ha recentemente lavorato con Bvlgari, ricreando la borsa Serpenti, a Natale uscirà una sua capsule con Lane Crawford, ma i lustri di Parigi e Balenciaga sono lontani.
Un destino che, senza i picchi di Wang, hanno ricalcato in molti, Jason Wu e Prabal Gurung, Derek Lam e Thakoon, né couturier né dissacratori dichiaratamente anti-sistema, come Gvasalia e Rubchinskiy, finendo in quella terra di mezzo comoda e rassicurante –tra co-lab con i grandi magazzini e feste alle quali saranno sempre ospiti d'onore – ma ininfluenti fuori dai confini nazionali. E tocca di nuovo chiedersi, come dieci anni fa, chi porterà la moda americana nel futuro, facendole definitivamente abbandonare le glorie di un passato ormai impolverato, e ancora purtroppo incastrata in una vecchia pagina di un album di ricordi in bianco e nero, tra Halston, Robert Redford in Ralph Lauren nel Grande Gatsby, e Oleg Cassini? Neanche Anna Wintour, forse, ha (ancora) la risposta.