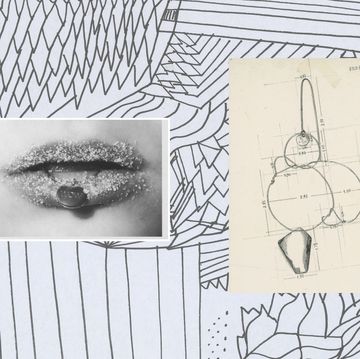L’ultima volta che avevo incontrato Beppe Modenense, alle sfilate milanesi di febbraio, ignari di essere nell’anticamera dell’inferno, era già sulla sedia a rotelle. Da quando era morto il suo adorato e adorabile compagno Piero Pinto – fratello di Aldo, a sua volta marito di Krizia – la sua salute era improvvisamente peggiorata. Era dolore che si sommava a dolore: quello per la perdita della persona amata per oltre mezzo secolo e quello per un corpo che ti abbandona. Naturalmente questo era un sentimento che aleggiava ma che dissimulava perché non sta bene ammorbare il mondo con i propri malumori: il retaggio di quell’educazione che lo ha accompagnato per una vita lunga, densa e felice.
Alle sfilate, presenziava sempre: era una forma di rispetto che ha mostrato, finché ha potuto, anche agli stilisti meno conosciuti per testimoniare l’impegno del loro lavoro. Avevamo scherzato, come ogni volta che ci vedevamo. Si era lamentato, sorridendo (ma neanche poi tanto), della scelta di Bebo Storti per interpretarlo nella serie tv Made in Italy su Amazon. «Ero più carino, all’epoca. Tu te lo ricordi, vero?». Certo che me lo ricordavo. Era il 1985. Ci eravamo conosciuti a Roma, quando iniziavo a scrivere per il Corriere della Sera e lui scendeva da Milano per le sfilate d’alta moda quando nella capitale sfilavano Capucci, Valentino, Raffaella Curiel, Raniero Gattinoni, André Laug, Mila Schön, Pino Lancetti.
Un periodo d’oro per me ma normale amministrazione per lui, che aveva già costruito un fashion system nazionale sostanzialmente immutato da allora: riunire in una sola sede e in pochi giorni i nomi più importanti dello stile italiano allora, allo stato nascente che lui aveva organizzato e sistematizzato per diffonderlo nel mondo. Era convinto che l’essere tutti insieme, anche se in sfilate non collettive ma individuali, avrebbe irrobustito il messaggio del prêt-à-porter. Questo aveva dato vita, in quello che oggi è il Palazzo delle Scintille e allora era il Padiglione Centrale della Fiera di Milano, al Modit e al Centro Sfilate che, successivamente, con la supervisione della Camera della Moda di cui dal 1998 Beppe Modenese era presidente onorario, è diventato Milano Collezioni. Lui riunì Armani, Versace, Ferré (uno dei suoi amici più cari), Biagiotti, Krizia, Missoni, Genny, Fendi, Moschino, Romeo Gigli e last but not least, Dolce & Gabbana, sulle stesse passerelle: impresa difficilissima date le personalità di ogni stilista, tutte molto dominanti, che gestì con la mitica signora Carla Ling, suo storico braccio destro, abilissimi entrambi nel destreggiarsi tra desideri, capricci, gelosie, pierre, «tutti in cuor loro volevano essere i primi della classe. Ma il tre ottobre 1979 fu il vero inizio della moda a Milano: in calendario c'erano 19 nomi e tre giornate di défilé». Beppe ha inventato, senza tema di smentite, il concetto stesso di Fashion Week. Lo sapeva ma non se ne vantava, forte di quella grazia che gli intellettuali definiscono sprezzatura: far passare come facile e naturale un lavoro titanico, sia pur nato da una geniale intuizione.
Era un uomo, oltre che attraente, di fascino incredibile e di un’eleganza di modi che lo avevano, già all’epoca, fatto amare dal jet-set internazionale, per cui organizzava eventi incredibili: non so quante volte mi sono fatto raccontare di quando per lanciare i tessuti italiani, a New York aveva pensato a un gigantesco party in cui, a un certo punto, aveva fatto liberare, nell’immenso salone, centinaia di farfalle vive. Temutissimo, rispettatissimo, preferiva essere amato: l’ho visto trattare con gentilezza chiunque, dai cameriere ai capi di stato, dalle vestieriste allo stilista-divo, dalle hostess alle dame aristocratiche. Così come l’ho visto arrabbiarsi con il designer arrogante, con chi non gli aveva riservato un posto in prima fila, con chi copiava dagli altri a cui riservava staffilate verbali pronunciate ad alta voce anche agli interessati.
Non credo di non averlo mai notato una sola volta senza giacca e cravatta, ma la sua classe era sempre discreta, sussurrata, quella di un gentiluomo che tende a farsi ricordare più che a farsi notare. Da quando feci una terribile gaffe nella mia prima intervista con lui (io, entusiasta: «Ho letto la sua biografia, sa che lei ha quasi l’età di mio padre? Che bello!» e lui, vanitoso, mi tolse il saluto per un anno) con Piero erano diventati teneri e protettivi nei miei confronti. «Se ho quasi l’età di tuo padre», mi rimproverò bonariamente (l’anno dopo), «converrà che ti dia un po’ di consigli come se fossi mio figlio. Inizia ad avere più fiducia in te stesso, subito. E magari, evitiamo troppi piatti di spaghetti». Ridemmo, e passammo a darci del tu. Ci siamo affezionati l’un l’altro, senza mai oltrepassare quella cortesia di modi che era affabilità e barriera, amabilità e autorevolezza, grazia ed estrema riservatezza. Credo che in me, giovanotto goffo e sovrappeso, rivedesse un po’ di quel ragazzo che era stato lui: nato ad Alba nel ’29, aveva condotto il suo tirocinio mondano a Torino per poi approdare, con il suo bell’aspetto e le sue buone maniere, a Milano.
Da lui ho imparato moltissimo, soprattutto in termini di stare al mondo: che essere provinciali come essere moderni è uno stato d’animo, innanzitutto. Indipendente dal luogo di nascita e dall’anagrafe. Beppe non è mai stato un nostalgico o un passatista: a cena da loro, capitava che, tra una chiacchiera sul governo e un gossip sull’ultima sfilata, lui introducesse en passant aneddoti del tipo che Coco Chanel in persona nei primi anni Settanta aveva chiesto a lui di accompagnarlo in treno alla prima sfilata della maison in Russia, «sì, una signora molto esigente ma di gusto strepitoso».
Ho imparato che è importante essere educati con tutti, perché è sintomo di intelligenza e non di debolezza: di fronte a tanti che, al primo successo, già se la tirano al punto di non salutarti più quando fino al giorno prima ti trattavano come il loro bff, “best friend forever”, lui salutava tutti con una parola che in quel preciso istante, attestava che fossi proprio tu al centro delle sue attenzioni.
Ho imparato che la prima cosa da mantenere viva, nel lavoro, è stabilire connessioni con altri settori e altre figure. Essere cioè il web di sé stessi, perché è la curiosità a mantenerci vivi e non i pregiudizi, nel senso stretto del termine: un giudizio dato a priori, basato sul «mi piace» o «non mi piace», frasi che non gli ho mai sentito dire. Ho imparato che è importante saper criticare, se la critica è costruttiva, ma la si può esprimere con garbo e motivazioni sensate.
In un anno dove stiamo perdendo i grandi maestri eppure c’è qualcuno che si permette di dire che gli ultrasettantenni siano improduttivi, credo che a me mancherà davvero la mia Stella Polare nel mirabolante mondo della moda. Così utile e anche così futile, talvolta. E colpevolmente privo di memoria: negli ultimi anni, a chi lo faceva entrare alle sfilate chiedendo di qualificarsi, di fronte alla mia faccia scandalizzata – ogni tanto lo accompagnavo – mi guardava con un sorriso che significava: «Ma che pretendi, che questo sappia chi sono? Avrà sì e no vent’anni!».
Ho imparato che il modo migliore per parlare di moda è farlo standone dentro ma contemporaneamente fuori, come spettatori di sé stessi che sanno benissimo come la vita profonda scorra in parallelo a certi rituali cerimoniosi e consunti. Sarebbe stato un personaggio perfetto raccontato da Proust come da Bret Easton Ellis.
Ancora un ultimo ricordo: quando, recentemente, condussi una serie di incontri per Brooks Brothers sul tema dell’essere gentiluomo, invitai lui con Sergio Tavelli, uno dei protagonisti della Milano d’avanguardia, dj del Plastic e giovane uomo dai mille interessi: temevo non avessero niente da dirsi. Si piacquero così tanto da sforare l’orario previsto. Così, due mondi in apparente collisione generazionale sfornarono una conversazione intelligente, ironica, ricca di idee. Produttiva, insomma.