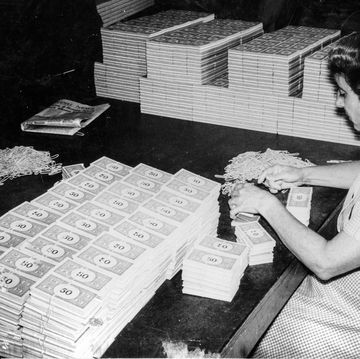"Sono Dio, perché ho creato io le condizioni perché la mia vita andasse in un certo modo, nel bene e nel male [...]", scriveva nel 2020 Fabrizio Corona, autore di Come ho inventato l'Italia, Non mi avete fatto niente, nonché di numerosi altri reati continuati; testi che si collocano tra le più autorevoli fonti biografiche sull'imprenditore e principale celebrity convict italiano che non siano offerte dalle sentenze della magistratura.
Credere eccessivamente in se stessi è da sempre un'arma a doppio taglio, non fosse altro che per la notevole dipendenza che lega la riuscita dell'operazione all'eventualità che potremmo avere torto marcio. È un po' come puntare sul rosso gli introiti di un'intera vita di lavoro in nero, con l'aggravante che, in molti casi, le probabilità non sono poi così fifty-fifty come alla roulette.
Le ultime storie Instagram di Fabrizio Corona – che con tutta probabilità passeranno alla storia delle worst practice dei social media e, in generale, della società – ci mostrano, con la chiarezza di una parabola diversamente evangelica, il peso schiacciante dei rischi legati a quella particolare forma di monoteismo che è la mitomania. Ma sono anche così drammatiche che è impossibile restare coi tatuaggi in mano e non sperare in una soluzione che possa ribaltare, il prima possibile, le forze in gioco. Infatti, per quanto autoriferita l'esistenza di Corona possa essere, non è escluso, anzi è molto probabile, che i suoi veri carnefici siano da ricercare al di fuori della sua persona.
Dopo aver parzialmente scontato in carcere una parte dei suoi 13 anni e 2 mesi di condanne definitive, nel dicembre 2019 Fabrizio Corona si vede concessa la detenzione domiciliare, una volta accertata una patologia psichiatrica. Oggi vi verranno in mente i paradossi alla Catch-22: chiunque si dichiari insano di mente in una situazione del genere potrebbe, di fatto, stare autocertificando la sua lucidità. Ma nessuno, all'epoca, ci pensò.
Le attività di comunicazione col mondo esterno di Fabrizio, un tempo intensissime e che, a San Vittore, si erano limitate principalmente alla pubblicazione di una mezza dozzina di libri e una manciata di seminudi artistici, improvvisamente, sembrano poter esplodere di nuovo.
Provare a spiegare a Fabrizio Corona che usare Instagram o organizzare festini mentre si è detenuti, seppure in casa propria, è una risoluzione piena di imprevisti, almeno quanto quella di vietare la movida a un adolescente nel mezzo di una zona arancione e in piena crisi ormonale. Seguono, così, reati e meta-reati incasellati gli uni dentro gli altri come matrioske. Party domiciliari con schiamazzi. Assembramenti ante e post litteram. Collegamenti con trasmissioni televisive con annesse calunnie a mo' di easter egg.
Pensare che quell'uomo avrebbe potuto resistere alle tentazioni offerte dei media pubblici e privati, digitali e fisici di cui Corona, in una vita precedente, era stato il Dalai Lama, sarebbe stato come pensare di essere davvero connessi al mondo contando solo sul proprio hotspot personale. Arriva così, puntualissima, la revoca del differimento della pena ai domiciliari. Il resto è storia di questi ultimi giorni: le minacce di togliersi la vita, le urla per strada, il ricovero al Niguarda, la prospettiva del ritorno in cella.
Una delle immagini più romantiche e upbeat della prigionia contenuta nel repertorio della musica leggera è quella offerta da Jailhouse Rock. Il testo comincia così: "Il secondino aveva organizzato una festa nella prigione della contea. / C’era la band della prigione e tutti iniziarono a gridare. / La band si agitava e la prigione si animava. / Avresti dovuto sentire come cantavano quei galeotti fuori di testa". Il film di cui il brano era la colonna sonora raccontava la storia di un detenuto (interpretato da Elvis Presley) che scopriva il potere liberatorio di ritmo e melodia mentre si trovava dietro le sbarre.
Non c'è mai stato niente di romantico o upbeat nei domiciliari di Fabrizio Corona. Al contrario: quella costrizione, apparentemente allentata, non faceva che imprigionarlo ulteriormente, stringendo ancora di più le manette prima invisibili e ora tangibili di un'altra forma di costrizione: curvarsi sullo schermo del telefono, sostituendo al rock di Memphis le storie di Instagram.
Si è detto e scritto molto sulla tendenza all'imitatio Christi da parte di Fabrizio Corona. Nelle foto di Ray Banhoff l'iconografia c'era tutta. E fu buona l'idea di assimilare il concept del rosario alla corona su cui il nostro porterebbe, fin dall'anagrafe, i segni del destino alla sofferenza dell'uno per tutti, di Fabrizio per l'umanità.
Ma è in quelle ultime, fatidiche storie su Instagram – presto cancellate dagli stessi gestori della piattaforma – pubblicate poco prima e durante l'arresto, che la profezia contenuta negli scatti di Banhoff si è compiuta nel modo più drammatico e solenne che avremmo potuto mai immaginare.
In quel volto, per metà una maschera di dolore e per metà una mascherina chirurgica abbassata, c'è lo sguardo dissennato e, al tempo stesso, lucidissimo di chi vive sulla propria pelle la follia di dover pagare con la propria umanità un'ultima, disperata dose di celebrità.
I due cicli di storie – di cui quelle ambientate fuori di casa, ormai sul marciapiede, non sono meno terribili e spiazzanti di quelle in casa, col pavimento insanguinato dal tentativo di ferirsi i polsi – compongono un tableau vivant che sembrerebbe girato da Mel Gibson se non sapessimo che sono invece il frutto del lavoro del social media manager di Corona. Fabrizio, più volte, inveendo contro le forze dell'ordine, invoca lo strumento del suo martirio, che non sono flagelli o chiodi, ma il suo telefonino che, invece che essergli inflitto, gli viene portato via. I suoi torturatori non sono soldati pagani ma conduttori televisivi e utenti del web apparentemente cristianissimi. La madre accorre con disperazione ejzenštejniana e, anche se non possiamo vederne l'occhio, ascoltiamo la sua voce, spezzata dal dolore di vedere il figlio portato via in manette. È una croce tutta invertita di segno, quella che attende Fabrizio, che giace sul marciapiede meneghino invece che essere issato sul Golgota. La narrazione cristologica al contrario si compie, infine, con l'invocazione a Dio che diventa una paurosa imprecazione.
In un angolo poco frequentato di Palazzo Barberini a Roma, c'è un dipinto in cui il pittore spagnolo Pedro Fernández de Murcia mise in scena, nel 1513, la Visione del Beato Amedeo Menez da Sylva. È una pala alta tre metri ma concepita per l'altare di una chiesetta di provincia, nell'eremo sabino di Montorio Romano. Mostra due ordini di realtà: sotto, un vasto paesaggio leonardesco, lussureggiante, ma anche pieno di ombre in cui nascondersi e riposare; sopra, poche nuvole spaurite reggono il peso di una specie di cassa armonica color rose gold, affollata da un convegno di santi e arcangeli truccatissimi, elegantissimi, che occupano una spazio così affollato che il vero miracolo non sembra che quella stravagante piattaforma volteggi nel cielo, ma che loro vi restino in equilibrio, quasi come i fruitori di una giostra non stabilissima e, in fin dei conti, neppure tanto divertente. Una scala a pioli pericolante unisce il mondo terreno a quello, incasinatissimo, che fluttua nell'aere. Questa bipartizione sembra una parodia della Disputa del Sacramento di Raffaello, affrescata una manciata di anni prima nella solennità delle Stanze Vaticane. Chissà che non sia anche una satira degli star system di tutte le epoche e di tutti i media. A metà strada tra la terra e il cielo, il protagonista della visione, il beato Amedeo Menez de Sylva, sollecitato da una creatura alata (che, incredibilmente, non somiglia affatto a Lele Mora), non sembra tanto chiederle di salire, quanto pregare di farlo scendere, di farlo tornare indietro, in direzione della pianura su cui la pesantezza di quel catafalco sembra incombere più come l'astronave aliena di un disaster movie che come la visione estatica di un francescano portoghese della metà del Quattrocento.
Fabrizio, forse sei ancora in tempo. Prova a trarre dalla storia di Amedeo, originario proprio di quel Portogallo in cui un giorno maledetto provasti a rifugiarti, l'insegnamento più importante. Non ascoltare chi ti invita ancora a salire. Lascia perdere una volta per tutte quel Tagadà chiamato fama o ricchezza o illusione. Se ci riuscirai, faremo finta che l'altro ieri non sei stato colto da un impeto di pazzia. Non ce ne vogliano i registi che ti hanno diretto nelle tue prove attoriali precedenti: ci convinceremo che solo in questi giorni di marzo ci hai voluto regalare la tua interpretazione migliore.
Ci renderemo conto allora che la tua non è stata una visione un po' picchiatella, ma un'evasione in piena regola. Magari non avrà avuto dietro un piano complesso come quello di Steve McQueen ne La grande fuga, o non conoscerà forse la poeticità della preparazione di Tim Robbins e Morgan Freeman ne Le ali della libertà. Ma sarebbe la prova che hai compreso finalmente quale fosse l'unica strada per lasciare il tuo carcere interiore, e l'hai percorsa brandendo coraggiosamente le armi che avevi a disposizione: il tuo sangue e la nostra pietà.
Solo così potresti non aver prodotto il tuo ultimo scandalo, ma il tuo primo prodigio: tornare alla normalità prima di tutti noi che, come te, ma diversamente da te, siamo costretti e reclusi. Una normalità che ti aspetta con le cure e nel rifugio di un luogo in cui non potrai più essere raggiunto dal tuo seviziatore: che sia tu riflesso allo specchio o noi coi nostri like.
Certo, è vero che su ogni Olimpo si campa d’ambrosia e audience. Ciascun Nume ha bisogno dell'attenzione dei suoi fedeli almeno quanto loro della sua benignità.