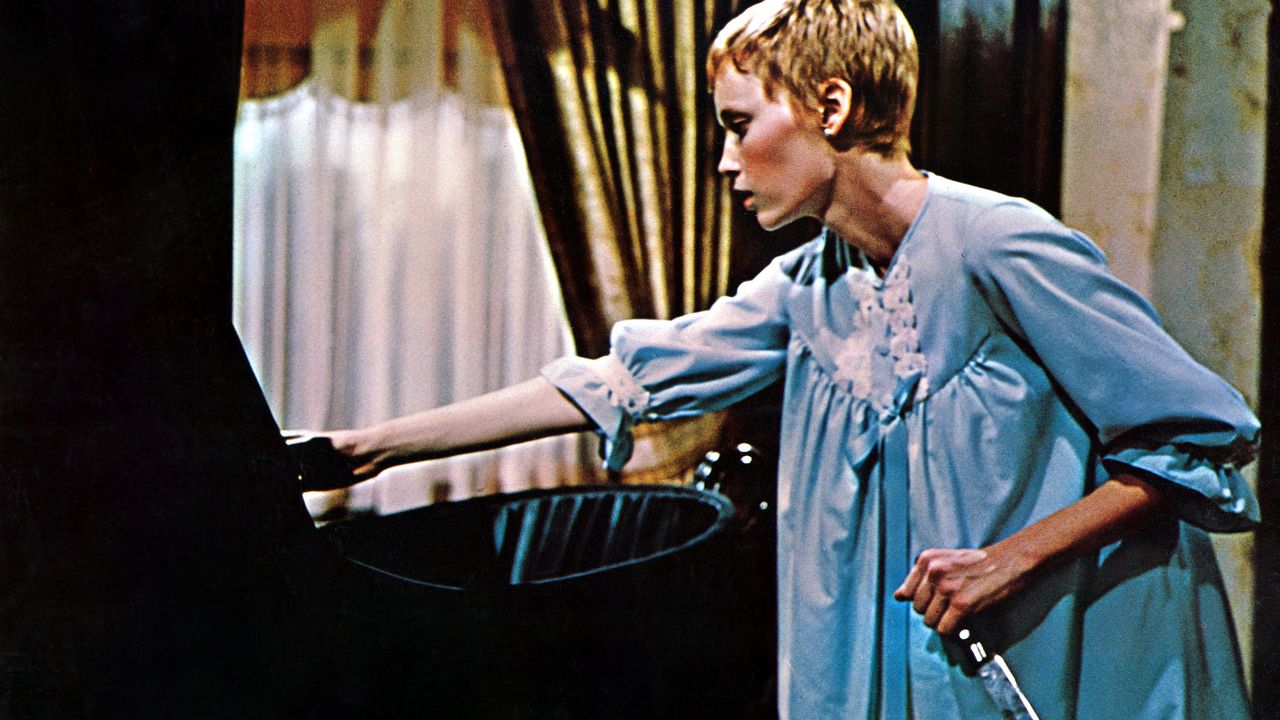"Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è rovinata", dice Csezlaw Milosz. Se in una famiglia nasce un aspirante scrittore, è ancora peggio, dico io. Magari fosse una nascita nefasta, qui si parla di aborto. Non è una tragedia, ma una farsa. Della tragedia restano soltanto le pose. T'è nato un caprone che si crede Anticristo.
Con qualche compagno pasteggiavamo in una mensa per muratori dietro la scuola di scrittura Oliver Twist.
C’era Lanfranco, un botolino ventiseienne con la forfora e gli occhiali spessi, che assicurava di essere vergine, nonché al quarto e ultimo volume della sua opera capitale, un fantasy i cui capitoli dispari erano in pentametri giambici, e gli altri scritti in una lingua da lui stesso coniata, il Lanfranto – contrazione di Lanfranco ed esperanto – comprensibile indistintamente per elfi, nani, orchi, giganti, silvani, maghi e per le dai lui inventate figarde, uniche femmine del pianeta Godus, dov’era ambientata la storia, che hanno il potere di risucchiare finanche un mago di nono livello dentro le loro vagine velenose. Ho saputo che terminati i due anni di corso ha trovato impiego nell’ufficio stampa di un’azienda che commercia dentiere.
C’era Wanda, una poetessa fatta e finita, anche se, che cazzo, lo sapeva che al giorno d’oggi era un po’ come essere misso dominico o maniscalco o bolscevico o gladiatore, ma, porca puttana d’una troia, per dire le cose vere, quelle vere davvero, bisogna parlare con la pancia e il colon e il buco là sotto, senza struttura e a piena voce, solo così il popolo si solleva, tutti i popoli si sollevano, e, che cazzo, solo così quei bastardi di borghesi e oligarchi e cardinali e fascisti e europeisti, si cagano sotto e sospendono i lavori della TAV. Quando un insegnate le disse che i suoi esercizi narrativi sembravano pagine di diario adolescenziale si mise a piangere come un vitello e gridò che non ne sapeva un cazzo, quel paraculo, di cosa significhi soffrire perché è morto tuo padre, e le sue cose, fanculo, potevano capirle solo quelli che avevano sofferto come lei.
C’era Roberto, un taciturno giornalista di Udine, che a trent’anni s’era accorto, spiegava, che i giornali non avevano futuro e che quindi voleva capire se la sua scrittura – timidamente ironica, piana, senza subordinate, puntellata come un colabrodo – potesse essere adatta a sceneggiature o romanzi. “Se non è cosa – disse raschiando col cucchiaio il fondo del minestrone – pazienza, così va il mondo, c’è chi c’è portato, chi nasce con gli occhi azzurri e chi con un soffio al cuore, così va il mondo”. Ora scrive di politica per un quotidiano locale, rigurgitando sui paginoni una frustrazione e un cinismo di cui tutti hanno poi finto di stupirsi.
C’era Davis, un fanatico di Lars Von Trier che voleva sceneggiare un horror metafisico e aveva il brutto vizio di non rimuovere tutte le mattine le caccole dagli occhi e il sudore dalle ascelle, e c’era Loretta, una trentaduenne romana che si era iscritta lì in attesa si liberassero posti per un dottorato accademico da incentrare su una presunta riscoperta di Boccaccio come post-post-modernista.
C’era Pina, una tizia che aveva investito nella retta della Oliver Twist i soldi risarciti dall’assicurazione per un incidente che l’aveva sfigurata. Scriveva da dio, le volte in cui si riusciva a comprendere quello che scriveva, e così, quando alla fine del primo anno venne rinchiusa al manicomio lasciando a Loretta i suoi pochi averi (un cappotto in lana cotta, un criceto piagato, una collezione bambole giapponesi), suscitò una serpeggiante e goduriosa rivalsa in tutti i compagni.
C’era Camilla, una fighetta che smontava i tacchi a spillo da una Mini Cooper dopo che le lezioni erano già iniziate da mezz’ora – se allungavo il collo oltre il davanzale la vedevo sculettare giù in strada– e, preso posto, via a scrivere lagne sulla crudeltà dell’esistenza.
E c’era Gian Vittorio, in fondo il mio solo amico, con un forte accento abruzzese, peloso, di cuore, furbo, vestito come il primo della classe della quinta elementare di un paesino appenninico (camicia a quadri, gilè e jeans marroni), ambizioso, fumettista, fedele a Rosita – una pianista bulgara – talentuoso, che organizzava seminari letterari chiamati “ritrovi degli argonauti”, dove ognuno leggeva qualche passo dei propri scrittori preferiti e dove io non misi mai piede.
Era lui che guardavo in cerca di comprensione prima di uscire a chiamare Silvia, appena finito di divorare il fegato ai ferri o le polpette in umido – proteine, proteine per i muscoli, mi dicevo. E Gian Vittorio, mentre mi alzavo col cellulare in mano, annuiva con gli occhi chiusi: “ti tocca, vecchio mio”.