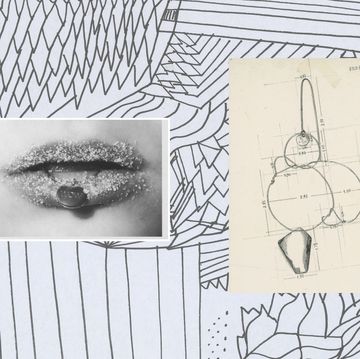Come sempre è tutto lì. Nel linguaggio. Quello usato dai media anglosassoni per comunicare la notizia che Christopher Bailey abbia deciso di, sia stato sollevato da, non lavori più per, insomma che lui e Burberry hanno divorziato, è un linguaggio funerario. Da lapide commemorativa. Addirittura il sito di Vogue Usa mette una foto cui manca solo la porcellanatura per tessere le lodi di un designer la cui dipartita segna una la fine di una delle più lunghe collaborazioni con un brand (ma a noi vecchi, abituati a 52 anni di tenuta di Karl Lagerfeld da Fendi, 17 anni non sembrano poi così tanti) che ha aureolato di esclusività, desiderabilità, esclusività e bla bla bla, in un crescendo da prefiche che si affannano a urlare disperate quanto fosse e bravo e bello e buono ed eccezionale il fu. Non so voi, ma in questo stile da marmista più che da giornalista, io ci trovo riflessa la grande ipocrisia che in questi giorni pervade, luttuosamente, la comunicazione in generale.
Il super “politically correct” addirittura in modalità autocensoria preventiva, neanche espressamente richiesta, porta certi colleghi a cercare la quadra tra incensamento di chi ha fatto un buon lavoro, elogio delle politiche espansionistiche commerciali, formulare auspici verso il Nuovo Salvatore che verrà (o Salvatrice: si fa il nome di Phoebe Philo, che andrebbe via da Céline, e anche lì sarebbe una perdita irreparabile).
Anche un neanderthaliano, dopo aver appurato che il buon Bailey è vivo e vegeto, ha 46 anni, sembra un ragazzino, che comunque rimarrà in sede fino alla sfilata per la primavera-estate 2018, di fronte a questi alti lai da vedove inconsolabili si chiederebbe: «Vabbè, ma se è così bravo, perché se ne va?».
Perché, pur di non ammettere che – purtroppo, eh – le vendite erano calate da un po’, che aver puntato sul famigerato “see now, buy now” non aveva dato i risultati economici sperati, che l’essere amministratore delegato e il direttore creativo della stessa azienda è un’impresa che riesce solo a un semidio comeGiorgio Armani (infatti certi rumors cominciavano già a girare dalla nomina del ceo Marco Gobbetti, a marzo 2016, che ora, secondo quanto scrive MFF Fashion, dice che il gruppo che possiede il marchio «ha una chiara visione sul futuro, nell’ottica di accelerare la crescita e contribuire al successo del marchio. Perciò sono emozionato per le opportunità che arriveranno per i nostri team, per i partner e per gli azionisti»), si preferisce un elegiaco tono come quello dedicato a chi non è più.
Non è più al timone di un marchio, il buon Bailey, perché una strategia di investimenti estremamente impegnativi non si è vista ricompensata nei dividendi al momento di tirare le somme. Il che è estremamente triste per un creativo che ha fatto di tutto perché il motivo check cammello-rosso-nero della maison diventasse patrimonio di chi può spendere e non dei “chavs”, i cafoni britannici che ne avevano fatto la loro divisa, rivestendoci pure i sedili delle auto. Ma è tutto estremamente realista, quando a dominare la creatività del singolo è solo la ricerca di una fatturato che deve obbligatoriamente crescere di anno in anno, pena l’essere estromessi. Cosa che è evidentemente capitata. Ma nessuno lo ammette.
Non che il buon Christopher non ci abbia provato. La “profitable fashion”, vera sciagura di questi tempi, è una triangolazione difficilissima tra domanda, offerta e desiderio che riesce a pochissimi. E non per lunghissimo tempo, perché fortunatamente le leggi della moda sono sottoposte a regole che nessun Dow Jones o Nasdaq riesce a prevedere.
Si chiede di fornire a getto continuo prodotti di lusso ma da vendere a tutto spiano, anticipatori del gusto ma non troppo, belli ma anche funzionali, in grado di soddisfare le aspettative di chi vuole “the Next Big Thing” ma allo stesso tempo rassicuranti per soddisfare i consumatori più tradizionali, innovativi ma nello spirito dell’heritage del marchio. Una roba da schiattarci dietro, il che spiega probabilmente quello stile da necrologio con cui il designer inglese oggi viene “ricordato”, mentre in realtà ha solo il torto di non aver fatto entrare nelle casse di più, di più, di più.
E dire che aveva inondato il mercato di profumi, sciarpe, orsetti e gadget da duty free, aveva suddiviso la produzione dell’abbigliamento in fasce differenti per prezzo e per estrosità, aveva creduto nella possibilità di raddoppiare i guadagni vendendo al momento della sfilata, in streaming planetario, quei capi che in teoria sarebbero planati nei negozi sei mesi dopo. È a questa mentalità da capitalismo ingordo che noi vorremmo fare, definitivamente, i funerali. Non a un grande direttore creativo che, pur avendocela messa tutta, ora andrà a ingrossare le fila dei Bravi Disoccupati: Alber Elbaz, Hedi Slimane, Riccardo Tisci, Frida Giannini, Massimiliano Giornetti. Da piangere, certo. Dalla rabbia.