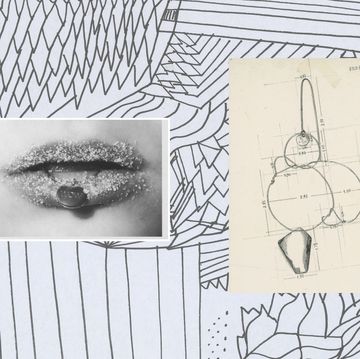Dopo aver visto Il grande Gatsby, al netto della zavorra di aspettativa che l'opprimeva da un anno (è stato montato, rimontato, ri-smontato, ri-montato) è ammirevole il contributo del regista Baz Luhrmann all'apoteosi del Burino Globale. Contributo che – spiace dirlo – non arriva fino alla glorificazione del parvenu come principio e principe del giusto lifestyle. Nel seminale (come dicono gli intellettuali oggi) romanzo, che per gli americani ha lo stessa scolastica potenza dei I promessi sposi per noi italici, Jay Gatsby e gli invitati alle sue feste orgiastiche, eccessive, pacchiane, potrebbero essere benissimo i protagonisti di un Cafonal dell'epoca.
Droghe, malavita, soldi da ripulire, corruzione e ragazze facili, facilissime comprese: vi suona familiare? Siamo noi, siamo l'Occidente, siamo quelli che non sentono l'allarme rozzo e lo giustificano come stravaganza. E qui casca l'asino: fedelissimo ai testi che vengono riportati paro paro sullo schermo, il film tradisce le intenzioni del libro facendone un mélo dove Daisy/Carey Mulliganappare in cielo in un effetto simil-Medjugorie del genere “ho visto Gesù nel mio toast in cucina”, laddove Fitzgerald la tratteggia per quello che è: una stronza superficiale. Cioè: una che nel romanzo, quando Jay le lancia addosso valangate di camicie una più costosa dell'altra, si mette a piangere non perché lo ami ma perché «non ha mai visto camicie così belle», voi come la chiamereste? Dev'essere andata così: siccome a Baz piace molto girare scene di massa (sontuosamente addobbata, tra deliranti scialaquamenti di soldi e titanici esibizionismi economici) e poco le scene one to one, ha pensato di metterci una pezza facendo di: lei, una che tutto sommato ha un cuore: suo marito, la caricatura di un marito incazzoso perché cornuto; Nick/Tobey Maguire una specie di sacerdote spretato che non fa altro che allargare il morale occhio bovino su ciò che vede, manco fosse uscito il giorno prima da un monastero di trappisti.
Peccato: un'occasione sprecata di raccontare il fascino morboso sempre sprigionato dagli arricchiti e l'ennesimo tentativo di interpretare quel mondo con la nostalgia per lo chic di un'epoca che fu. Attestando così una sostanziale e autentica burinaggine del tutto. Ma Luhrmann non è Luchino Visconti. E questo Gatsby non è La dolce vita.
*Per il titolo, il copyright va agli amici de Il Deboscio