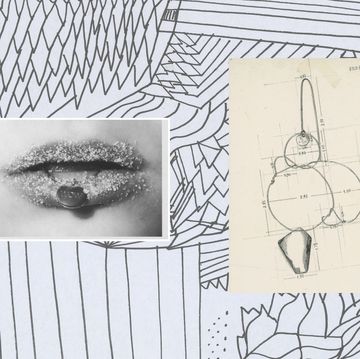Sì. Prima ancora che formuliate la domanda, la risposta è: «sì». O almeno così pensano più o meno prestigiose maison, autorevoli amministratori delegati delle stesse, le istituzioni del caso – prima fra tutte, la Camera Nazionale della Moda Italiana – e perfino molto qualificati giornalisti ed esperti di comunicazione nel settore.
Tutti d’accordo: le sfilate servono. Se “in presenza” forse ancora un po’ di più.
La stranezza di questa stagione, già squassata da angosce virali, pericoli di contagio, terrori del crollo verticale di un’economia del settore, inizia così: da oggi la Fashion Week milanese prende il via tra stupori e tremori. Del resto, l’edizione tutta digitale dei défilé maschili, nello scorso giugno, non aveva acceso molti entusiasmi.
Come fosse prigioniera di una tenaglia temporale di Tenet, quella che un tempo era l’industria più innovativa di tutte (anche nella comunicazione), tranne sparuti casi si dimostra protesa a invocare l’inversione degli oggetti-vestito, al punto da permettere a essi (e di rimando a qualsiasi cosa, anche esseri viventi come gli spettatori Vip in prima fila) di tornare indietro nel tempo. Una nuova narrazione di moda, imposta dai tempi veloci dei social e dall’ancor più veloce capacità del desiderio, si è un po’ afflosciata nell’accorato ricordo dei bei tempi pre-Covid. Sia chiaro: questo vale per l’Italia, per l’America, per la Francia, dove ancor oggi si va discutendo se fare alcune presentazioni “live” o spostare tutto sulle piattaforme.
I grandi brand oggi, teoricamente non hanno più bisogno di sfilate attirafolle (ehi, che fine faranno quelli conciati come scotennati per farsi ritrarre dagli streetstyle photographer, anche loro in via d’estinzione? Poveri) ma per vendere si avvalgono altri media meno tradizionali, e questo da parecchio tempo: i loro budget pubblicitari si sono mossi seguendo metodi molto differenti di quelli di venti o trent’anni fa.
E i grandi clienti ricchi ricchissimi non verranno per paura e nelle loro magioni mongole, indiane, moscovite, cinesi riceveranno via DHL qualche campione frutto della fertile mente degli stilisti e il resto lo sceglieranno via Zoom. E parliamoci molto chiaramente: anche quelli ricchi e basta non hanno neanche tanto più bisogno della guida di giornalisti e critici, visto che hanno un gusto affinato da anni di shopping sofisticatissimo: forse è più utile l’apporto degli influencer, per questo tipo di pubblico più adatti a suggerire cosa non comprare (ma se voi aveste tantissimi denari, comprereste quello che indossa una o uno con milioni di follower? Anche no).
Le voci di Alessandro Michele per Gucci o di Anthony Vaccarello per Saint Laurent, che hanno proclamato di sfilare solo due volte all’anno o addirittura quando pare a loro, sono rimaste quelle di chi strepita nel deserto: anche se Giorgio Armani, che prima di tutti aveva invocato un ritorno alla lentezza e a presentazioni più distribuite col contagocce, per questa tornata sceglie la democratica, cara vecchia TV per il suo défilé in una serata tutta a lui dedicata su La7. Tutto cospira a una torsione del Tempo verso una dimensione vintage, in effetti mai effettivamente dismessa da chi frequenta questi eventi rituali e sociali che sono i défilé: e mi spiace contraddire la collega che si dice «stanca di questi vestiti di pixel che non ti fanno apprezzare il tessuto» perché era la stessa che, un anno fa, si lamentava se non la mettevano in prima fila perché «non riusciva a vedere l’outfit completo»: non è che le sfilate dal vivo poi siano così chiarificatrici su trame, orditi e stampati rispetto a quelle in streaming. Diciamo che un posto in prima fila è un simbolo di potenza per alcuni di noi spettatori e pennivendoli: significa che hai raggiunto il potere (di cosa? Non si sa).
E allora, chiederete, perché alla fine le sfilate servono, e servono davvero?
Perché sì, la città ha bisogno di questi eventi, esattamente come quelli del Salone del Mobile, per movimentare non solo la gestione finanziaria dei suoi quartieri più blasonati, ma anche come vetrina dell’Italia tutta per dimostrare al mondo che l’industria della moda è viva e lotta insieme a chi ci lavora.
La scelta un po’ bizzarra di sfilare un po’ a tre dimensioni e un po’ sugli schermi dei computer (da sempre siamo democristiani e individualisti, mica potevamo pretendere che tutti pendessero da una parte o dall’altra) in questo spaventoso e spaventato periodo forse è la soluzione – se non migliore – forse più adatta a testimoniare non solo l’esistenza di un compartimento che è il secondo a tenerci a galla dopo il turismo, ma la sua vitalità ed energia, anche quando tutto sembra andarci contro.
Osservate da questo punto di vista (ehi, sono italiano, quindi democristiano anch’io!) più che sfilate sono proclami di essere ancora in vita, sono dichiarazioni sul valore del Made in Italy che tutto il mondo, speriamo a lungo, continua a rincorrere come un sogno tramutato in realtà. L’industria dell’abbigliamento e degli accessori significa cultura, saper fare, manualità, capacità esecutive e anticipatrici del gusto di un’epoca: è un patrimonio prezioso.
Se il mondo della moda non ha ancora trovato (spiace dirlo, eh) la maniera giusta di parlare alle persone d’oggi, a cominciare dai famigerati plutocrati della Generazione Z, ebbene: saranno proprio questi ultimi che lo premieranno acquistando capi pensati, realizzati e prodotti proprio in questi mesi da incubo. Che lo apprezzeranno anche se presentato nella solita formula di modelle in fila, apparizione momentanea dello stilista e applausi scroscianti alla fine: perché è proprio quando una cosa è bella, rimane bella anche se in una confezione un po’ fané.
Aspettiamoci sfilate più editate, più ragionate, forse minori per quantità di uscite ma maggiori per tutto lo sforzo che industriali, designer, artigiani, operai, grandi imprenditori che sperimentano nuove fibre e più sostenibili tessuti. Saranno premiati i marchi che costruiranno ponti emotivi con le persone, risponderanno con chiarezza sul chi, sul come e sul dove riguardo alla produzione, dimostreranno attenzione alla qualità delle materie come al loro impatto sul pianeta.
Forse c’è ancora tempo per ripensare il linguaggio con cui rivedere il sistema, ma è diventato improcrastinabile il pensiero di una moda che non tenga conto di questi fattori. Soltanto così, in un mondo che è sempre più smarrito e incerto, la bellezza intelligente e sensibile avrà la meglio anche sulle incertezze e le esitazioni con cui viene diffusa e cadenzata. Noi staremo a vedere. In tutti i sensi.