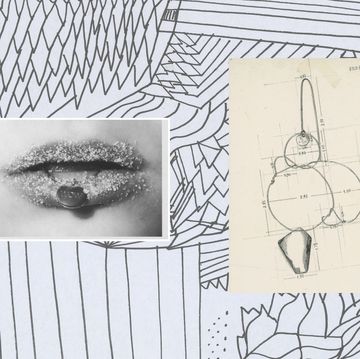Centoventi serrande, da abbassare per sempre in Europa: la notizia ferale, della chiusura di altrettanti negozi con l'insegna Gap, è stata battuta per prima dal quotidiano francese Le Monde. Un finale triste ma annunciato, almeno in suolo francese, dove lo scorso anno il colosso americano aveva già chiuso 8 delle sue 28 insegne, compresa quella di pregio sugli Champs-Elysées. Secondo le fonti del giornale, il 20 ottobre tutti gli impiegati italiani, francesi e britannici, sono stati invitati a collegarsi in una video conferenza, dove Mark Breitbart, presidente di Gap dallo scorso settembre, e Debbie Edwards, vice-presidente con il compito di gestire i mercati europei, hanno annunciato ai dipendenti la cessazione di tutte le attività entro il 2021. Secondo i dati di La Repubblica, il piano generale sarebbe quello di chiudere 230 negozi, con un risparmio di 90 milioni di dollari l'anno. Il sole ha quindi smesso di splendere sul regno del brand fondato da Donald e Doris Fisher, nell'infuocata Summer of love del 1969 a San Francisco? In realtà il cielo si era annuvolato da diversi anni, e la pandemia da Covid-19 non ha aiutato un impero nato sotto tutt'altra stella. Se l'idea del nome è da attribuire a Doris, e faceva riferimento al gap (divario) generazionale, indirizzandosi così in maniera esplicita ai più giovani, il progetto di business si deve a Donald, agente immobiliare specializzato in spazi commerciali. Ispirato dal successo subitaneo raggiunto da The Tower of shoes, negozio che si era installato a Quonset-Hut, in un'area di Sacramento lontana dai soliti circoli dello shopping, e che comunque riusciva ad attrarre una nutrita clientela grazie al claim invitante – "non importa il brand, la taglia o il modello: la tua scarpa la troverai qui" – aveva contattato il suo amico Wally Haas Jr, allora presidente di Levi Strauss & Co., proponendogli di replicare quel modello, con i jeans Levi's, in quel momento all'acme della desiderabilità, sinonimo su tela dello zeitgeist della cultura hippy, tanto che, anche nei magazzini di Macy's, il cliente allora più importante di Levi's, quei jeans non riuscivano a rimanere sugli scaffali, andando regolarmente in sold out.
Haas gli consiglia di parlarne con il capo del reparto pubblicità, Budd Robertson e lì, Donald legge il tentativo di un gentile declino da parte dell'amico Haas, che forse vuole demandare a qualcun altro il dovere di dirgli di no. Invece, incontrato Robertson, Donald Fisher scopre il reale desiderio del brand di realizzare quel progetto, tanto che i due mettono in piedi una strategia di marketing credibile, e a prova di leggi anti-trust: Donald potrà aprire il negozio a San Francisco, vendendo esclusivamente i prodotti del brand – che tra l'altro si incarica del 50% delle spese collegate alla promozione radiofonica del neonato The Gap – e gli verrà garantito, nel caso di sold-out, un rifornimento notturno, direttamente dal magazzino Levi's di San Jose. Per evitare l'accusa di monopolio, il brand si premura di far sapere che l'opportunità offerta a Donald sarà replicabile, da qualunque negozio si proponga di vendere, nei suoi spazi, solo ed esclusivamente Levi's. La trovata si rivela subito geniale: in quel negozio in Ocean Avenue i giovani accorrono a frotte, per comprare i loro jeans preferiti – in qualunque taglia, a rimarcare che l'attenzione all'inclusivity non è materia del nuovo millennio – e anche gli LP, unico altro prodotto presente, e altrettanto simbolico di una stagione nella quale la musica era viatico dell'espressione personale, sociale e politica. Nel 1970 si apre la seconda insegna a San Jose, nel 1971 il quartier generale, con solo quattro impiegati, prende sede a Burlingame, sempre in California. Nel 1973, travolgente come un riff di chitarra di Jimi Hendrix, Gap ha già aperto in 25 location diverse ed è arrivato sull'altra costa, nel New Jersey, conquistando i teenager dell'east coast con quella sua narrazione giovane, fresca, e, ovviamente ritmata, anche se gli LP scompariranno presto dagli scaffali. «Erano i jeans che facevano vendere i vinili, non il contrario» dirà al The San Francisco Chronicle Donald Fisher. A sostituirli, però, ci sono altri jeans, a marchio Gap, che si iniziano a produrre proprio nel 1973, e commercializzare l'anno dopo. La comunicazione fa l'occhiolino ai giovani, ma si immagina che, per fatturare due milioni di dollari già nel secondo anno di attività, l'originale negozio di Ocean Avenue trovasse la complicità, e i portafogli, dei loro genitori, convinti da un rapporto qualità-prezzo indiscutibile.
Nel 1976, il marchio si quota in Borsa, mantenendo sempre quel legame con le generazioni più giovani, anche se quegli stessi teenager – i famigerati baby boomer– crescono, crescono le loro capacità di acquisto, ma cambiano anche i loro gusti, lontani dagli informali jeans e più orientati verso un abbigliamento più adulto, anche se mai dichiaratamente formale: per questo il brand chiama, a guidare quello che ormai è già un impero, Millard Drexler, il cui soprannome regalatogli poco dopo "the merchant prince", lascia ben presagire sulla qualità del suo operato. T-shirt con taschino, i famigerati pantaloni khaki – indossati in una pubblicità degli Anni 90 da una Kirsten Dunst con lo stesso fascino naïve e disturbante con il quale avrebbe conquistato il grande schermo nel Giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola – e i maglioni. Anche se l'adolescenza è finita, il sogno ( di Gap) prosegue. Gli store vengono ridisegnati usando nelle pubblicità figure di artisti imperituri, da Jack Kerouac a Pablo Picasso, passando per Andy Warhol e Miles Davis: ribellarsi agli schemi, in fondo, non sembra più solo una faccenda da teenager. I profitti salgono, grazie anche all'acquisizione di altri brand: Banana Republic azienda già esistente che proponeva un abbigliamento estivo, in nuance neutrali, con giacche sahariane e appunto, i khaki, viene acquisita nel 1983 per ingolosire una fascia di pubblico più alta, nel 1986 apre Gap Kids, cogliendo ancora una volta la tempistica perfetta: gli imberbi adolescenti che compravano i jeans Levi's nel 1969 sono ormai diventati a loro volta genitori, trasformandoli in clienti fidelizzati, per sé e per la prole.
Nel 1992 la copertina di aprile di Vogue America per il suo centesimo anniversario esplode di bianco, glamour, e ovviamente, Gap: con lo sportswear e il casual che ormai conquistano il podio dei desiderata dei clienti statunitensi, Patrick Demarchelier sublima quella realtà su foto, mettendo al centro dell'obiettivo Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Karen Mulder, Elaine Irwin, Niki Taylor, Yasmeen Ghauri, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, e Tatjana Patitz – LE top model in purezza, assoluta famiglia reale deputata alla conservazione del concetto stesso di bellezza, in quegli anni – in camicie bianche annodate sotto il seno, e jeans GAP, ormai sinonimo di un continente fresco e vincente. Il prezzo delle azioni del brand raggiunge il suo massimo storico, 59 dollari. Laddove però mancano i loghi – come sulle maxi felpe sfoggiate con l'orgoglio di appartenenza di chi stia indossando un gagliardetto di Yale o Harvard – l'identità latita. Certo, aver centrato il momento, messo su tela l'american dream, vendendo quel sogno ad un prezzo accessibile, è encomiabile, ma oltre a capitalizzare su quel successo, raggiungendo testimonial e fotografi impensabili per un brand lontano dagli emisferi del lusso – Salma Hayek, Lenny Kravitz fotografato da Patrick Demarchelier, Debbie Harry dei Blondie fotografata da Albert Watson, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Faye Dunaway scattata da Gus Van Sant, Rossy de Palma scattata da Herb Ritts – il marchio fa poco altro, in termini di creatività. I giovani fanno ancora la fila per comprare la giacca in corduroy vista nel 1992 indosso alla bionda Kelly, californiana del Cap 90210 alle prese con il più dolce tra i dilemmi amorosi – il bravo ragazzo Brendan o il maledetto Dylan e la sua Porsche 911 con la quale fugge da un passato tempestoso e da un'ingente eredità monetaria della quale non vuole sentir parlare? – ma il brand pare diventato troppo grande, per poter ancora giocare in maniera convincente, il ruolo dell'outsider.
Un'operazione di ricostruzione di un heritage, da modificare in accordo con l'anagrafe dei suoi primi clienti, che, nel 1989, ingloba persino la più intellettuale tra le reporter americane, Joan Didion. Prima di divenire feticcio modaiolo di Céline –scattata da Juergen Teller in una campagna pubblicitaria del brand nel 2015, e poi, ancora, omaggiata nello stesso anno dal brand con il fotografo Tyrone Lebon che ritrasse la modella Daria Werbowy in una foto che ricordava un'altra foto, di Julian Wasser, nella quale la Didion guardava nell'obiettivo, dal sedile della sua Corvette – la giornalista fu infatti testimonial di una campagna del brand, insieme a sua figlia Quintana, scomparsa poi nel 2005, a 39 anni, per una pancreatite acuta. Nel 1994, un film generazionale come Giovani, carini e disoccupati, sancisce e mette su pellicola l'ambizione massima della Generazione X: lavorare da Gap, quello che fa Vickie, una delle protagoniste del film che contribuì a cementare l'immagine di fidanzata d'America di Winona Ryder. Certo, però, a poco valgono certi ricordi da nostalgici ossessionati da quel team di All-stars, se poi il brand diviene talmente sinonimo dell'"establishment" da collaborare con la Borsa di New York, nel 1997, vestendo i trader impettiti con i suoi khaki – e ci si immagina qui l'orrore che tale scelta avrebbe scatenato nello yuppie Patrick Bateman, broker di Wall Street nato dalla penna di Breat Easton Ellis nel 1991 (American Psycho) e portato sullo schermo nel 2000 da Christian Bale, capace di minacciare di morte la responsabile di una lavanderia a secco che non riesce a togliere le macchie di sangue dal suo completo, con la battuta passata alla storia. "Non può candeggiare un Cerruti: è fuori discussione".
«Ci chiedemmo 'Qual è il simbolo stesso del mondo del business?' Sarebbe interessante appropriarci di quel simbolo, uno dei pochi che non era ancora divenuto casual. E poi, ci dicemmo, che quel simbolo era quello della Borsa di New York» disse in un'intervista al New York Times, un dirigente del brand. Intervistato nel 2019 sempre dal quotidiano americano, lo scrittore e saggista Thomas Frank, autore del libro The conquest of cool: business culture, counterculture, the rise of hip-hop and consumerism, ha così spiegato, il conseguente declino che il brand ha affrontato negli anni successivi a quel risultato. «La ribellione contro lo stile pacificato della classe media era diventato mainstream. Il non conformismo non era più un'ideologia, ma un'estetica, e una alla quale ci si poteva conformare in tutta sicurezza. Gli artisti e i ribelli erano gli ultimi consumatori. O meglio, nel caso di Gap, le ultime icone del consumismo.
Drexler, l'uomo del miracolo, abbandona la compagnia nel 2002. Il fondatore, Donald Fisher, che con la famiglia aveva sempre mantenuto la sua presenza nel consiglio di amministrazione, muore nel 2009. I vari brand acquisiti nel corso degli anni subiscono sorti alterne. Dopo Banana Republic, Gap lancia nel 1994 Old Navy come alternativa economica: nel 2016 si parla di vendita, separazione, ma poi non se ne fa nulla. Forth & Towne, dedicato a una clientela femminile over 35, viene lanciato nel 2005 e chiuso 2 anni dopo; PiperLime dura qualche anno in più, dal 2006 al 2015. A rimanere attivi sono Athleta (linea di activewear femminile lanciata nel 2009) e Intermix. E nonostante le buone performance online del secondo trimestre del 2020 (+95%) le perdite in boutique (-48%) hanno portato il gruppo a registrare un calo delle vendite del 18%. Ad essere interessate dalla chiusura, in Italia, saranno 11 vetrine, compresa quella del flagship store milanese inaugurata 10 anni fa, accanto a quella di Banana Republic, ormai chiusa dal 2017. Il desiderio, però, è quello di ritornare nei cuori e nei guardaroba della Gen Z americana. La strategia? Firmare un accordo decennale con Kanye West, producendo e distribuendo Yeezy Gap (YZY GAP), variante più economica della sua linea Yeezy, e i cui primi prodotti – linee uomo, donna e bambino – saranno negli store, secondo il New York Times, per la prima metà del 2021. Una mossa che ha però già scatenato non poche polemiche: a gennaio, infatti, il brand aveva annunciato la sua collaborazione con il ben più giovane Telfar Clemens, nuovo nome del panorama dell'athleisure, designer black la cui linea incentrata sui concetti di inclusività e fluidità di genere sta contribuendo a vivacizzare la scena creativa newyorchese. La collaborazione pareva cosa fatta, e si era già organizzato un party alquanto sontuoso durante la fashion week parigina di gennaio, coperto dalle maggiori testate, pronte ad annunciare la lieta novella dell'arrivo di una collezione Gap x Telfar.
Vanessa Friedman, dalle colonne del New York Times, spiega che "il logo era già stato creato, le vetrine di Parigi erano state decorate con foto dell'ultimo show di Telfar, ma il contratto era ancora una bozza, da firmare da entrambe le parti, nonostante la macchina delle comunicazioni si fosse messa in moto, e dal brand si dicessero entusiasti di questo nuovo ingresso. Poi, a fine novembre, il CEO Art Peck è stato licenziato senza preavviso, mentre il CMO Alegra O'Hare si è dimessa alla fine di gennaio". Le difficoltà provocate dalla pandemia in un brand già affaticato, dopo il colpo alla reputazione seguito alla cancellazione degli ordini già effettuati nelle sue fabbriche in Bangladesh, e i 66 milioni di affitto arretrato da pagare al Simon Property Group, hanno quindi convinto il brand, nelle parole della Friedman " ad abbandonare un designer di colore per uno, sempre di colore, ma ben più famoso". Con la collaborazione tra Gap e Telfar sospesa – e il brand che però, ha ripagato il 35 enne a pieno, con tanto di scuse ufficiali per la gestione della faccenda, provocata da un cambio ai vertici imprevisto – il designer ha ammesso che, pur augurando a Kanye West, di cui apprezza e stima il lavoro, ogni fortuna «sono molto felice di essere libero da questo accordo». Il suo direttore creativo, Babak Radboy, ha però aggiunto «Siamo cresciuti guardando a quell'edifico, quello dei grandi magazzini, volendo farne parte, volendo avere autorevolezza proprio in quel luogo. Abbiamo realizzato, con questa vicenda, che non dovremmo. Fa parte da sempre, della nostra strategia di sopravvivenza in quanto marchi fondati da persone di colore, essere soddisfatti di una collaborazione con un brand molto più grande del nostro, per permettere loro di intascarsi una patente di "solidarietà razziale". Il vero problema è però la situazione alla base, che impedisce la crescita di un brand o di un designer di colore, e li obbliga a dire sì, quando gli vengono fatte queste proposte». Sono lontani i maglioni di Cher Horowitz – divinità della pop culture cinematografica, interpretata da Alicia Silverstone nel 1995, in Ragazze a Beverly Hills – e appare preistorico l'outfit total Gap che Mick Jagger indossò al Live Aid del 1985 (pantaloni lilla, t-shirt blu, camicia aperta giallo canarino, un effetto technicolor,che, 35 anni e molti trend dopo, si realizza, neanche il cantante dei Rolling Stones, poteva nobilitare). Di più recente, nell'immaginario estetico mondiale, c'è però la scorsa stagione di Stranger Things, ambientata proprio nel 1985, che metteva Eleven e i suoi compagni di avventure tra la realtà e il sottosopra, al centro di quello stesso consumismo sfrenato, in un grande magazzino dove a imperare, era proprio il logo di Gap. L'effetto nostalgia non è bastato. Basterà Kanye West?