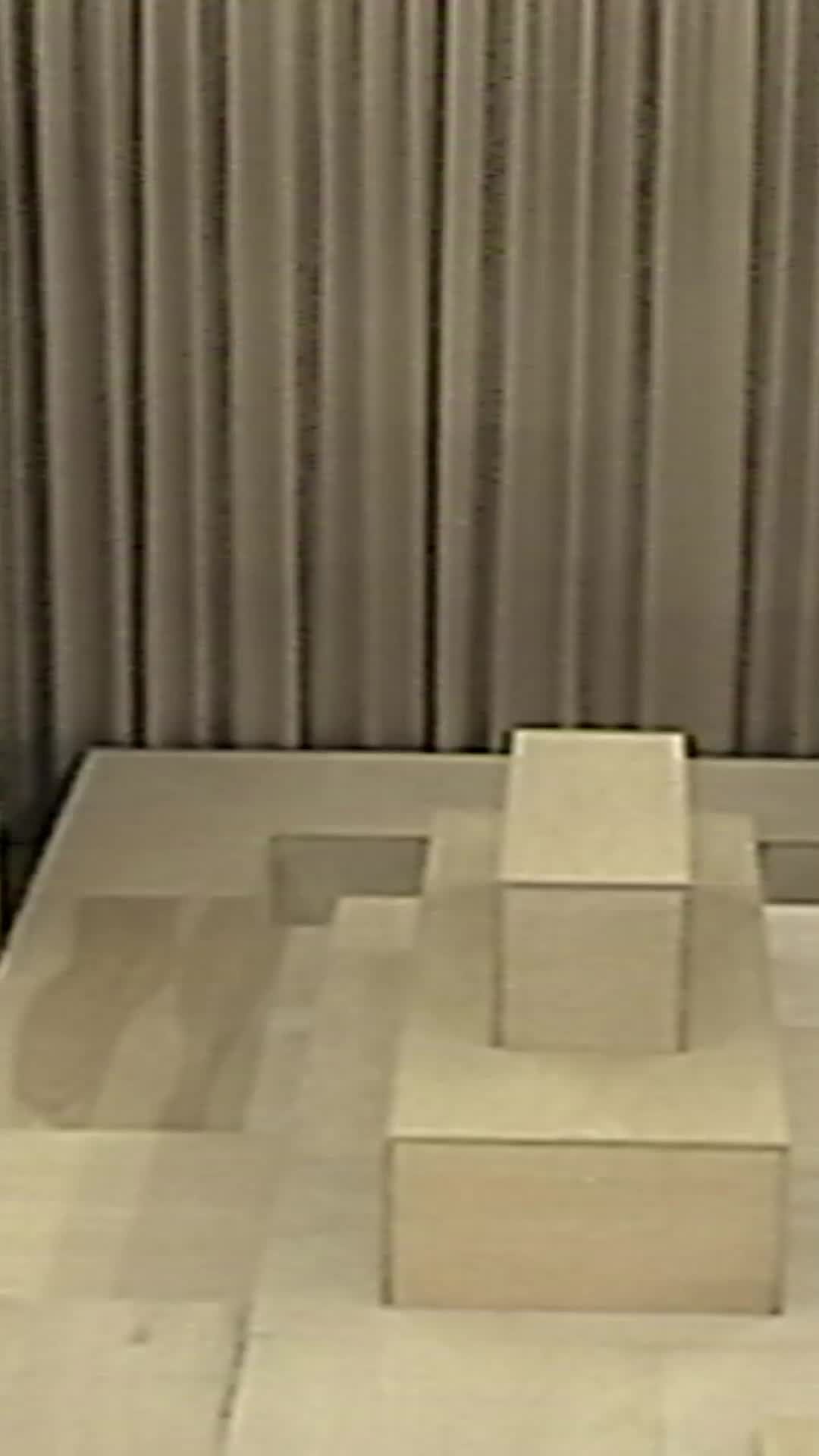Mentre sulle passerelle digitali londinesi hanno sfilato le collezioni per il prossimo autunno inverno, la domanda che serpeggia è una sola: con la Brexit, cosa cambierà? La London Fashion week, ricettacolo di ogni tipo di eversione stilistica, che ha dato i natali a talenti iconoclasti come John Galliano e Alexander McQueen, riuscirà a mantenere una rilevanza tra le capitali della moda? Oppure abdicherà, sotterrata dalla burocrazia e dalle limitazioni? Difficoltà che non includono l'anno di pandemia, che ha messo alla prova, in maniera indiscriminata, tutte le latitudini modaiole: a New York, dove l'ultima fashion week si è dimostrata ancora alla ricerca di autori e metodologie e nuove narrazioni, un gruppo di brand, giornalisti e associazioni no profit ha inviato negli scorsi giorni una missiva al numero uno della Casa Bianca, chiedendogli la nomina di un "fashion zar". «Un advisor di alto livello è necessario per coordinare le politiche e le persone dell’industria della moda» si legge nel documento cofirmato da Mara Hoffman, ThredUp, Reformation, giornalisti di Harper's Bazaar, e associazioni come Fibershed, Fashion Revolution USA e Sustainable Brooklyn. «Uno zar dovrebbe spingere per aggregare i membri chiave del sistema, esortare a cambiamenti politici e avere un ruolo di responsabilità all’interno dell’amministrazione.
La creazione di un fashion zar indicherebbe l’impegno della sua amministrazione nei confronti della manodopera e dell’ambiente, così come un riconoscimento del ruolo della moda come elemento dell’economia statunitense». E anche in Inghilterra, dove la situazione scatenata dalle nuove regole della Brexit entrate in vigore il primo gennaio, è ben più pericolante, si è pensato di rivolgersi all'inquilino del 10 di Downing Street, con una lettera dai toni ben più aspri, più cahiers de doléances che missive deamicisiane da libro Cuore. Sono circa 450 i nomi dei firmatari del plico inviato il 19 febbraio a Boris Johnson – tra i nomi più rilevanti quelli di Paul Smith e Roksanda Ilincic – e che, in buona sostanza, ricorda al capo di governo che le condizioni negoziate in extrema ratio con l'Unione Europea mettono a rischio le aziende, e di conseguenza i migliaia di posti di lavoro che garantiscono. «La moda contribuisce al Pil dell'economia inglese più di quanto non facciano, sommate, la pesca, l'industria musicale, quella cinematografica, quella farmaceutica e quella automobilistica» si legge nel documento redatto dal think tank Fashion Roundtable «eppure c'è un buco normativo laddove ci dovrebbe essere la garanzia di libero movimento in Europa per le professioni creative». Se il "worst case scenario", ossia il no-deal che era stato paventato a fine anno scorso, è stato sventato con un simil colpo di scena degno dei migliori film di spionaggio anglosassoni, la situazione di fronte alla quale si trovano i brand della moda dal primo gennaio, mette comunque in difficoltà estrema non solo le maison, ma anche i retailer, i grandi magazzini, e gli operatori del comparto a qualunque livello. Ma quali sono, nella pratica, le nuove regole che fanno sentire la moda inglese insularizzata più di quanto non lo sia già a livello geografico?
Con la Brexit, banalmente, non è più garantita la libera circolazione di persone, beni e servizi da e per il resto del vecchio continente. Di conseguenza, le modelle inglesi, ad esempio (come Naomi Campbell, Jourdan Dunn e Kate Moss, giusto per citarne alcune) dovranno richiedere un visto per viaggiare, e raggiungere le passerelle della fashion week milanesi o parigine, o anche solo località nelle quali i giornali europei organizzeranno dei servizi fotografici: se prima era quindi possibile selezionare una modella fino a un giorno prima dalla data dell'evento, ora le cose cambiano. Lo ha spiegato al New York Times John Horner, ceo di Models 1, l'agenzia che ha nelle sue fila, proprio Naomi Campbell e Lara Stone: «Le modelle ora avranno bisogno di uno tra 27 visti per viaggiare negli altri paesi europei: sarà un incubo amministrativo. Credo che molti giornali e brand internazionali devieranno su altre città europee, abbandonando Londra come set per servizi e, più in generale, per condurre affari». Un problema che il British Fashion Council, la versione anglosassone della Camera della Moda italiana, ha detto di stare affrontando con "un dialogo costante con gli enti governativi, al fine di evitare restrizioni sui viaggi, così come con i designer e i brand, per aiutarli a comprendere al meglio le nuove regole». Oltre allo spostamento delle persone fisiche, è problematico anche lo spostamento delle merci. Se secondo Walpole il 42% dei beni di lusso prodotti in Uk è destinato all'esportazione in UE, venendo meno la libera circolazione delle merci, i dazi doganali da pagare si faranno sensibilmente più alti. Già oggi, acquistando da siti online Uk, per i consumatori europei ci sono un 20% di tasse in più da pagare alla cassa digitale, e la stessa cosa succede se un consumatore britannico vuole acquistare da un sito europeo. Condizioni che, in un ironico paradosso, hanno messo in difficoltà persino il brand Cefinn, lanciato da Samantha Cameron, moglie di quel David che era al 10 di Downing Street nel 2016, quando venne indetto il referendum che portò al "Leave". Lo ha ammesso la stessa ex first lady in un'intervista ai microfoni della radio della BBC, sostenendo che le sfide davanti a lei sono importanti. E anche se poi si decidesse, al netto dei dazi doganali maggiorati, di acquistare, neanche i partner della logistica dei maggiori siti – da FedEx a Gls passando per DHL – sono preparati a gestire la nuova burocrazia, e di conseguenza si vedono già importanti ritardi accumulati dagli spedizionieri.
Infine, l'effetto del nuovo assetto politico, come riporta il NYT nel pezzo "Could Brexit destroy British Fashion", è stato critico anche per i negozi del lusso o i grandi magazzini come Harrod's. Con l'abbandono del Retail Export Scheme i visitatori internazionali che acquistano beni di lusso non potranno più vedersi rimborsato il 20% delle tasse – potendo, sostanzialmente fare shopping come se fossero nel loro paese di provenienza – limitando l'attrattiva dei negozi inglesi. A conferma di questa teoria, a dicembre, 17 aziende del comparto del lusso avevano già affermato che avrebbero rinunciato a un'espansione dei loro spazi e a ristrutturazioni e ampliamenti, precedentemente preventivate – con un investimento totale di 1 miliardo di sterline – in quanto la domanda, semplicemente, è calata. Questo vuol dire che persino i futuri e benestanti turisti che arrivano dai paesi Europei, eviteranno le vie del lusso inglesi, preferendo quelle francesi o italiane. A questo punto, il governo non ha ancora risposto in maniera ufficiale alla lettera, ma ha affermato che è al lavoro per organizzare "webinar, linee di aiuto, e strategie di sostegno alle aziende della moda per affrontare la fase della transizione". Più che una strategia di sostegno, sembra che a Londra serva un cambiamento radicale. E non si è certi che al 10 di Downing Street siano disposti ad affrontarlo.